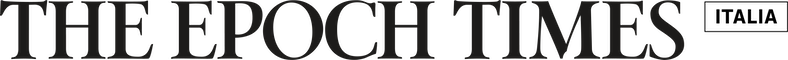C. S. Lewis, l’uomo può davvero controllare la natura?
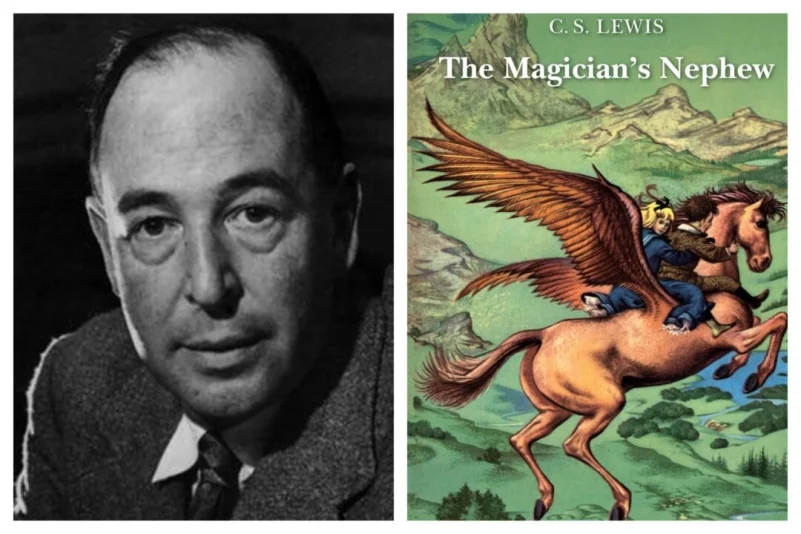
Ne “Il nipote del mago”, C.S. Lewis avverte che la capacità dell'uomo di corrompere la natura potrebbe essere estremamente pericolosa. Pubblico dominio
| Aggiornato alle
Condividi articolo
Tempo di lettura: 12 Min.
Tempo di lettura: 12 Min.
Lo scrittore e studioso britannico Clive Staples Lewis (1898-1963) ha posto al centro delle proprie opere un “monito” alla scienza, alla magia e ai tentativi di dominare la natura. Lewis non era certo contrario alla scienza, ma aveva capito che il buon uso della scienza poteva essere facilmente corrotto se le scoperte e lo sviluppo tecnologico erano frutto solo della ricerca del potere. Lewis riteneva che la ricerca del potere sulla natura – dal voler controllare la meteorologia fino alla stessa natura umana – è in contraddizione con lo spirito di meraviglia, gratitudine e ammirazione dell’uomo. Inoltre, rende gli esseri umani e la natura stessa accessori, facendoci perdere di vista il loro valore intrinseco.
Lewis ha esposto chiaramente questo pericolo nel saggio L’abolizione dell’uomo, tratto da conferenze tenute al King’s College di Newcastle nel 1943. Esordisce col criticare i libri di testo pubblicati a quel tempo, che promuovevano il relativismo e mettevano in discussione la fede nella verità oggettiva, e prosegue contestando i tentativi di ignorare la legge naturale, manipolando la natura per scopi “umanitari” – il che spesso significa, in pratica, che alcuni si servono della scienza applicata per controllare gli altri esseri umani.
Lewis propone tre esempi del potere dell’uomo sulla natura: la radio, l’aereo e il contraccettivo, dimostrando come ognuno di essi in realtà indebolisca l’umanità tanto quanto la rafforzi: «Per quanto riguarda il potere dell’aereo o della radio, l’uomo è allo stesso tempo possessore e oggetto, poiché è “bersaglio” sia delle bombe che della propaganda». Anche i contraccettivi, secondo Lewis, rappresentano il potere delle persone vive su quelle non ancora nate, il potere di impedire loro di venire alla luce. Considerando questi tre esempi, Lewis conclude: «Da questo punto di vista, quello che chiamiamo potere dell’uomo sulla natura risulta essere un potere esercitato da alcuni uomini su altri uomini, con la natura come strumento».
Lewis temeva che la sfrenata ricerca del potere, l’inestinguibile desiderio di plasmare la natura a seconda dei capricci dell’uomo, non solo avrebbe soggiogato un’ampia parte di umanità, ma avrebbe portato, in ultima analisi, all’abolizione completa dell’umanità. Scriveva:
«Lo stadio finale sarà quando l’Uomo, attraverso l’eugenetica, il controllo delle nascite, un’educazione e una propaganda basate su una mirata psicologia applicata, avrà ottenuto il pieno controllo su se stesso. La natura umana sarà l’ultima parte della natura ad arrendersi all’uomo. Allora, la battaglia sarà vinta… Ma chi, precisamente, l’avrà vinta?».
Cercando di riplasmare la natura umana per adattarla ai nostri programmi, rischiamo di distruggere la nostra stessa identità.
Naturalmente, la scoperta scientifica di per sé è una cosa positiva: molte tecnologie migliorano notevolmente la nostra vita, e Lewis indubbiamente lo ammetteva. Non metteva in guardia contro la scienza in quanto tale, ma ha dimostrato, sia con narrativa che con la saggistica, come l’impresa scientifica possa fallire quando è assetata di potere e ciecamente insensibile sia alla bontà intrinseca della natura che al valore dell’essere umano – che è parte di quella realtà naturale. Quando lo scopo della scienza diventa quello di armare la natura contro se stessa e contro l’umanità, significa che si è completamente deviato.
MAGIA E SCIENZA
Lewis probabilmente è più famoso per i romanzi fantasy Le cronache di Narnia, che parlano più di magia che di scienza. Ma Lewis presenta chiaramente il «mago malvagio» o «mago oscuro» – come lo zio Andrew o la Strega Bianca – come netto parallelo dello “scienziato pazzo” che oggi ci è più familiare.
In realtà, ne’ L’abolizione dell’uomo sostiene che la magia e la scienza – del tipo descritto sopra – si equivalgono in molti modi: «Il forte impegno della magia e il forte impegno della scienza sono gemelli: uno era malato e moriva, l’altro era forte e prosperava. Ma erano gemelli, sono nati col medesimo intento». E l’intento è quello di piegare l’ordine naturale alla propria volontà, a qualsiasi costo, compresa la corruzione morale.
Nel pensiero di Lewis vediamo alcuni sintomi rivelatori del «mago oscuro» assetato di potere o del suo omologo, lo «scienziato pazzo»: insensibilità alla sofferenza altrui, disprezzo per i limiti morali e indifferenza per la bellezza della natura.
Nel primo libro de Le Cronache di Narnia, ad esempio, un ragazzino, Digory Kirke, e la sua amica, Polly Plummer, vengono trattati come cavie dallo zio di Digory, Andrew, un mago che ha creato degli anelli magici in grado di trasportare le persone in un altro mondo. Andrew inganna Polly facendole toccare un anello e mandandola in un altro mondo, perché è troppo codardo per esplorare egli stesso l’altro mondo. Vuole che le cavie lo facciano per lui.
Terrorizzato per la sua amica, Digory si oppone strenuamente, ma Andrew ignora la preoccupazione di Digory per Polly, considerando la sua sicurezza del tutto irrilevante rispetto al suo «grande esperimento». Dice a Digory: «Sono io il grande studioso, il mago, l’adepto, che sta facendo l’esperimento. Naturalmente ho bisogno di soggetti su cui farlo». Il consenso o il rifiuto di queste cavie non significa nulla per il mago, la loro sofferenza non lo riguarda minimamente.
Digory obietta anche per la mancata promessa dello zio il quale, con la quintessenza dell’arroganza di chi ha il potere, risponde:
«Devi capire che regole di questo tipo, per quanto eccellenti possano essere per i ragazzini, per i servi, per le donne e per le persone in generale, non ci si può aspettare che si applichino a bravi studenti, grandi pensatori e saggi. No, Digory. Gli uomini come me, che possiedono una saggezza nascosta, sono liberi dalle regole comuni proprio come siamo esclusi dai piaceri comuni».
Anche in un altro romanzo di Lewis, Lontano dal pianeta silenzioso, il protagonista viene usato come cavia da uomini in cerca di potere. Questa volta si tratta di scienziati, più che di maghi, anche se la distinzione tra le due figure rimane sempre sfumata. Elwin Ransom viene rapito da due scienziati e chiuso in un’astronave diretta su un altro pianeta alla ricerca di oro, non per amore della scoperta o per un senso di meraviglia verso nuovi mondi. Questo è un altro segno dello scienziato pazzo-mago oscuro: l’indifferenza alla bellezza e al mistero di quello che vogliono ottenere.
SULLE ORME DI LEWIS: PIRANESI
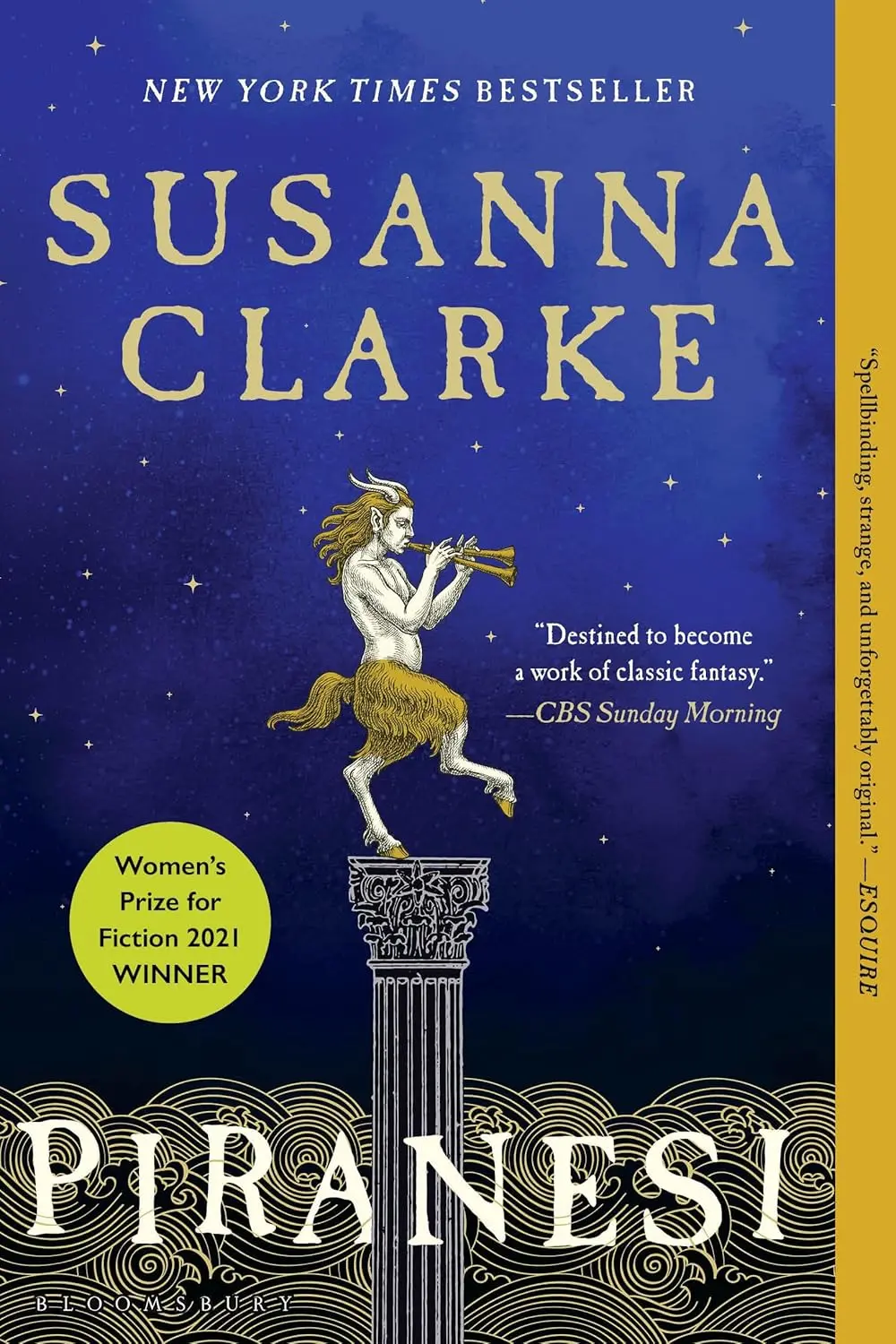
Autori contemporanei come Susanna Clarke si ispirano al tema di C.S. Lewis sulla ricerca del potere da parte dell’uomo.
Questo tema si ritrova in tutta la grande letteratura: alcuni davanti alla bellezza sono accecati dall’amore per il potere che li rende incapaci di apprezzare qualsiasi cosa per se stessa. Nel romanzo Piranesi, la scrittrice contemporanea Susanna Clarke rivela la forte influenza di Lewis e la vediamo confrontarsi con le sue idee nel corso del libro.
Come Ransom o Digory, il protagonista, Piranesi, è stato catturato da un uomo per un «esperimento» e si ritrova intrappolato in un altro mondo, una casa labirintica di enormi sale e scalinate, immersa in uno strano mare e piena di belle statue silenziose. L’uomo cammina solitario attraverso corridoi che si susseguono e risuonano con le misteriose maree dell’oceano. Ammirando la bellezza della «Casa», parla con gli uccelli marini, dimentica il proprio passato e il fatto che il suo rapitore, il mago-scienziato Valentine Ketterley, è un nemico e non un amico.
Qui l’autrice non fa distinzione tra scienziato e mago, chiamando Ketterley in entrambi i modi. Come innumerevoli maghi e scienziati prima di lui, è assorbito dalla ricerca di una conoscenza segreta che gli garantirà il potere su se stesso e sugli altri. Crede che l’uomo antico possedesse questa conoscenza segreta e che sia nascosta da qualche parte nel labirinto sommerso dal mare.
Ketterley riconosce che per l’uomo antico il mondo era incantato e ricco di significato, la natura era personificata, potente e viva. Tuttavia, commette un errore tipicamente moderno, confondendo l’incantesimo con la magia, vuole cioè la saggezza degli antichi per usarla per i propri fini, per dominare la natura. Non si rende conto che questo atteggiamento è antitetico alla vera saggezza degli antichi.
Per l’uomo che desidera solo “usarlo”, il mondo non può essere incantato, non può essere un luogo di gioia, di delizia e ricco di significato. Ecco perché Ketterley è completamente insensibile alla bellezza del labirinto e lo vede solo come un mezzo per raggiungere il potere. La «conoscenza segreta» degli antichi è proprio davanti a lui, intorno a lui, nella bellezza del labirinto, eppure non la vede, lo trova un luogo squallido e noioso. Mentre Piranesi, guardandolo con meraviglia, coglie la scintilla della gloria in ogni cosa: le statue squisite, gli uccelli svettanti, il suono del mare. Per lui, tutto ha un significato.
Alla fine Piranesi si rende conto dell’inutilità della ricerca della conoscenza segreta da parte di Ketterley:
«Mi sono reso conto che la ricerca della Conoscenza ci ha incoraggiato a pensare alla Casa come a una sorta di enigma da sciogliere, un testo da interpretare, e che se mai scoprissimo la Conoscenza, allora sarebbe come se il Valore fosse stato strappato dalla Casa e tutto ciò che rimarrebbe sarebbe un mero scenario. La vista della Centonovantaduesima Sala Occidentale al chiaro di luna mi ha fatto capire quanto questo sia ridicolo. La Casa ha valore perché è la Casa. È sufficiente in sé e per sé. Non è il mezzo per raggiungere un fine».
Qui Piranesi mostra una profonda saggezza che credo avrebbe trovato d’accordo molte delle migliori menti del mondo antico, per non parlare dello stesso C.S. Lewis.
Articoli attuali dell'autore
24 novembre 2025
Quattro antichi imperi che hanno segnato la Storia
10 novembre 2025
Riti e valore spirituale dell’investitura di un cavaliere
09 ottobre 2025
T.S. Eliot e come si riconosce un’Opera Classica
04 settembre 2025
Studiare la Storia è l’antidoto alla tirannia del presente