Nel silenzio del cuore della notte, davanti a un altare e a un’icona, alla luce tremolante delle candele sulle fredde pietre, un uomo sta inginocchiato. Sull’altare sono disposte le sue armi, una collocazione che simboleggia la loro appartenenza a Dio e che devono essere usate per difendere la giustizia, la verità e l’onore. Nell’oscurità, per un’intera notte, lo scudiero apre il proprio cuore a Dio, implorando la forza di cui avrà bisogno per adempiere alla vocazione di cavaliere. Quando le striature rossastre dell’alba finalmente squarciano il cielo, lo scudiero sa che il momento della sua investitura alla cavalleria si avvicina.
L’elaborata cerimonia che nella società medievale europea accompagnava la nomina di un cavaliere, rifletteva gli alti ideali impliciti nella concezione che si aveva a quel tempo del guerriero. Anche se, naturalmente, i cavalieri non sempre si dimostravano all’altezza di quegli ideali, possono sicuramente dirci qualcosa sulla visione del mondo medievale e sul ruolo del gentiluomo e del guerriero al suo interno.
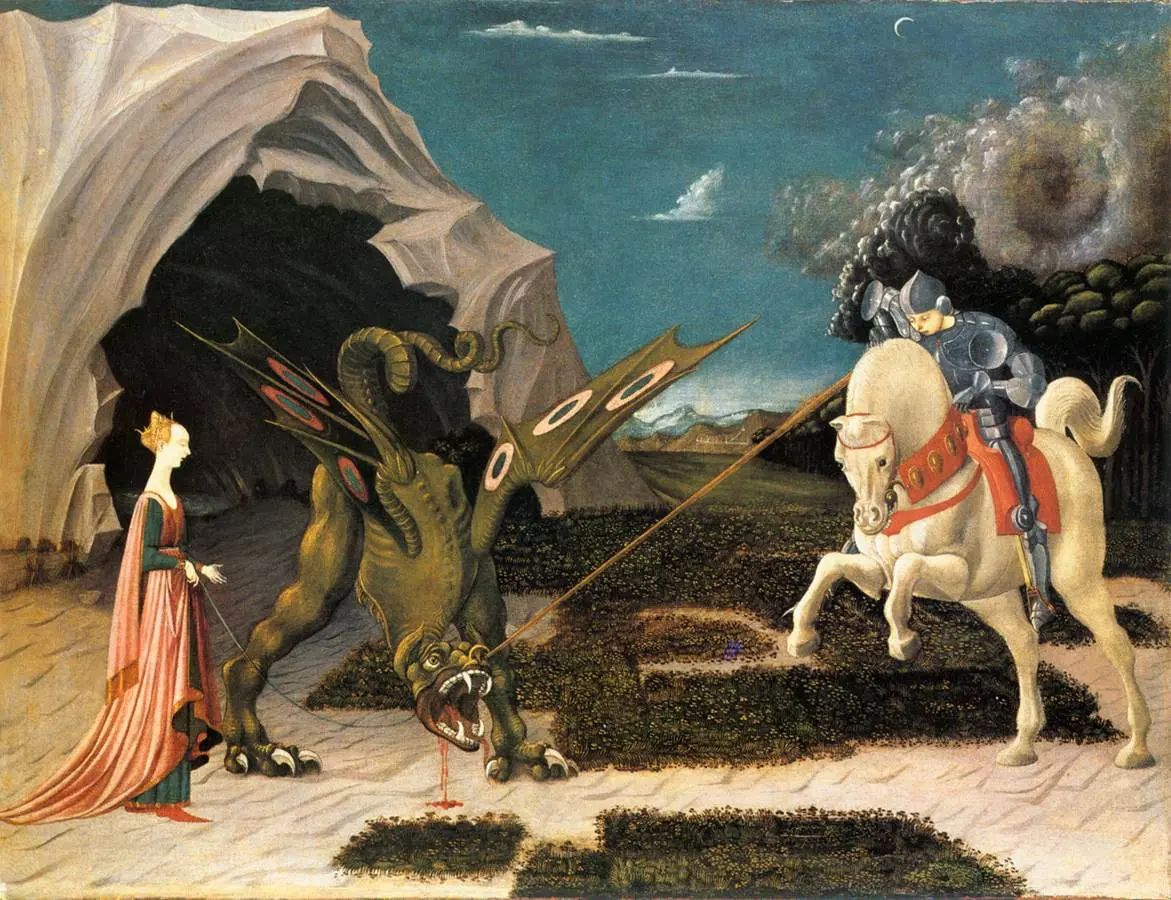
I rituali per l’investitura riflettevano il significato di cavalleria, e il contesto sociale che la società medievale sviluppò per armonizzare la guerra con i concetti di fede e civiltà. Questa concezione emerse per la prima volta in Francia intorno al X secolo, quando la Chiesa cattolica tentò di frenare le tendenze violente dei Franchi, per i quali la sfrenata sete di sangue costituiva un modo di vivere.
Etimologicamente, il termine “cavalleria” deriva dal francese chevalier, che si riferisce a un guerriero a cavallo (da cheval). I Franchi facevano ampio uso dei cavalli in battaglia e, in genere, solo i ricchi potevano permettersi di possedere un cavallo e utilizzarlo in guerra, quindi a partire da quel tempo la cavalleria venne associata agli aristocratici. A questa élite marziale il Cristianesimo proponeva un codice di nobili ideali, per indirizzare la loro natura violenta verso la difesa della cristianità piuttosto che verso la sua distruzione. Al meglio della sua manifestazione, per gli uomini la cui natura e vocazione era marziale, la cavalleria rappresentava una via verso la santità: da un cavaliere veramente cristiano ci si aspettava che perseguisse la virtù con lo stesso ardore di un monaco. Per dedicarsi a questa via, come a un monaco, gli veniva impartita una regola di vita, sotto forma dell’Ordine o Codice della Cavalleria. I cavalieri dovevano difendere i diritti di Dio e della Chiesa, aiutare e difendere i deboli, sfidare i malfattori e vivere nella lealtà al loro signore o re.
Sebbene fossero sempre presenti conflitti tra il lavoro sanguinario del campo di battaglia e il codice morale cristiano – per non parlare dell’eventuale mancato rispetto da parte dei cavalieri del codice di condotta che professavano – l’ideale cavalleresco, nella sua espressione migliore, impresse nei suoi paladini l’idea che anche la guerra potesse essere condotta con virtù e onore e al servizio di Dio e dell’uomo. Anche in tempo di pace ai cavalieri venivano assegnati ruoli importanti, poiché amministravano la giustizia, gestivano le loro proprietà e servivano i loro feudatari. Questa concezione religiosa e ritualistica della cavalleria consente di comprendere perché l’investitura a cavaliere fosse considerata alla stregua di un sacramento della Chiesa. Infatti, gli scudieri che si accingevano all’investitura facevano un bagno e indossavano abiti bianchi per simboleggiare la purificazione dai peccati e la purezza di cuore con cui i giovani affrontavano la loro vocazione. Un rituale che ricorda da vicino il battesimo.

Una delle descrizioni più dettagliate delle elaborate cerimonie che circondavano l’investitura cavalleresca ci arriva dal cavaliere spagnolo Ramon Llull, vissuto nel XIII secolo. Llull spiegava come l’investitura avvenisse di solito nei principali giorni di festa cristiana, scelta che serviva a rafforzare il legame del cavaliere con la Chiesa e lo sosteneva con l’effusione di preghiere e celebrazioni associate a un giorno importante del calendario liturgico. Llull scriveva: «L’onore della festa farà sì che molti uomini si riuniscano quel giorno in quel luogo… e tutti pregheranno Dio per lo scudiero». Lo scudiero quindi trascorreva la notte prima dell’investitura in una cappella, pregando e vegliando sulle sue armi: era questa la famosa “veglia del cavaliere”.
Questo aspetto del rituale sottolineava ancora una volta la sacra dedizione del cavaliere a Dio, e dimostrava inoltre la sua capacità di sopportare le difficoltà e la solitudine. Dal momento che il dovere del cavaliere era difendere il regno e la Chiesa, era logico che la conclusione della sua formazione comportasse di vegliare mentre gli altri dormivano. Llull sottolinea anche l’importanza che lo scudiero iniziasse la carriera cavalleresca in modo puro e nobile: «Se [uno scudiero] ascoltasse i giullari che cantano e parlano di meretricio e peccato, dal primo momento in cui entra a far parte dell’Ordine cavalleresco inizierebbe a disonorare e disprezzare l’Ordine».
Dopo la veglia notturna, il futuro cavaliere partecipava alla Messa. Secondo Llull, il fatto che la cerimonia di investitura fosse inserita nella Messa sottolineava ancora una volta il carattere sacro della cavalleria. Lo scudiero si avvicinava all’altare e prestava giuramento all’Ordine cavalleresco, ovvero si impegnava a rispettare il codice di condotta dei cavalieri. A questa promessa seguiva un lungo sermone che inculcava al neo-cavaliere i fondamenti della fede cristiana e la loro relazione con la vocazione cavalleresca. Infine, un sacerdote o un nobile investiva lo scudiero del titolo di cavaliere: lo scudiero si inginocchiava nuovamente davanti all’altare, alzava gli occhi e il cuore in preghiera a Dio e, mentre era assorto in preghiera, il nobile o il sacerdote lo cingeva con la spada e lo colpiva sulla guancia con il lato piatto della lama. Questo era il “colpo di spada”, l’unico colpo che un cavaliere doveva subire senza reagire. Serviva a ricordargli la sofferenza che nel suo nuovo stato doveva essere pronto ad accettare per Dio e per il re.
Queste cerimonie esprimevano magnificamente la concezione medievale del cosmo, profondamente gerarchica e religiosa. Ogni persona aveva un ruolo specifico da svolgere e un posto specifico all’interno dell’ordine più ampio della società, che rispecchiava l’ordine dell’intero universo creato. Per un cavaliere, il ruolo era quello di allenarsi senza sosta per la guerra, in modo che tutto quanto di buono, sacro e bello esisteva nella sua civiltà egli potesse difenderlo da chi voleva distruggerlo.

In realtà, molti non riuscivano a soddisfare le aspettative cavalleresche, preferendo perseguire il proprio profitto e usando la spada per ottenerlo, mentre altri hanno seguito con fede la tradizione cavalleresca. Quello a cui realmente aspiravano, nonostante tutte le loro mancanze, rimane un monumento straordinario e unico tra le dottrine della storia militare.




