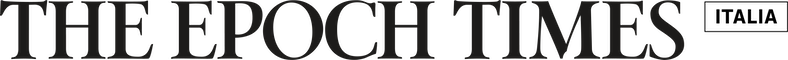A salvarlo sono solo i controlli sui capitali imposti dal regime
Lo yuan non è sottovalutato ma sopravvalutato
Kenneth Rogoff, ex capo economista del Fondo monetario internazionale, ribalta la vulgata secondo cui la valuta cinese sarebbe artificialmente sottovalutata: «Se la Cina permettesse ai propri cittadini di investire liberamente all’estero, lo yuan perderebbe molto del suo valore»

Banconote di Yuan. Foto Benjamin Chasten, Epoch Times
| Aggiornato alle
Condividi articolo
Tempo di lettura: 12 Min.
Tempo di lettura: 12 Min.
Mentre molti economisti criticano la Repubblica Popolare Cinese per la sua pluridecennale politica di controllo del tasso di cambio dello yuan – che è generalmente considerato tenuto artificialmente svalutato da parte della Banca Centrale cinese – Kenneth Rogoff, ex capo economista del Fondo monetario internazionale, dice il contrario: la valuta cinese è sopravvalutata. «Se la Cina permettesse ai propri cittadini di investire liberamente all’estero, lo yuan perderebbe molto del suo valore. Da questo punto di vista, la moneta è tuttora sopravvalutata» e non svalutata, ha dichiarato Rogoff a Epoch Times Usa.
Docente di economia internazionale a Harvard e membro della National Academy of Sciences e dell’American Academy of Arts and Sciences, Rogoff è considerato uno dei massimi economisti viventi. Negli ultimi tempi, la crescita esponenziale delle esportazioni cinesi – che ha pesantemente inciso sull’industria manifatturiera e sulla crescita economica in Europa e negli Stati Uniti – ha spinto molti economisti e funzionari occidentali a sollecitare Pechino a apprezzare lo yuan. Brad Setser, del Council on Foreign Relations, e Mark Sobel, ex funzionario del Tesoro statunitense – fra i molti – sostengono che «il renminbi è ampiamente sottovalutato» e che «è giunto il momento che le autorità ne favoriscano un marcato apprezzamento rispetto al dollaro». Anche Juergen Matthes, economista dell’Istituto tedesco per la ricerca economica, in un documento del 23 luglio scorso ha evidenziato che la «sottovalutazione ingiustificata» dello yuan rispetto all’euro rappresenta una delle principali cause del deficit commerciale europeo con la Cina.
Secondo il Rapporto sul settore esterno pubblicato quest’estate dal Fmi, l’avanzo delle partite correnti (in soldoni, l’attivo commerciale) della Cina nel 2024, corretto per il ciclo economico, equivaleva al 2 per cento del Pil, ossia 1,2 punti percentuali in più rispetto al livello considerato normale. Su questa base, la stima che lo yuan sia sottovalutato dell’8,5 per cento. Un altro documento dell’Fmi, il World Economic Outlook di ottobre, dà una valutazione ancora più netta, rivedendo verso l’alto l’avanzo delle partite correnti cinesi nel 2025 al 3,3 per cento del Pil. Applicando il consueto coefficiente di elasticità, il Fondo arriva a stimare una sottovalutazione della moneta cinese pari a circa il 18 per cento.
Ma Rogoff contesta la metodologia del Fmi, sostenendo che quest’ultimo non effettui confronti longitudinali tra i surplus commerciali storici: «È vero che la Cina registra un grande surplus commerciale, oggi pari a circa il 3 per cento del Pil. Nel 2010, però, era il 10 per cento. Il punto è che l’economia cinese è cresciuta enormemente in rapporto a quella mondiale, per cui, in proporzione al Pil mondiale, il suo surplus resta grande quanto quello del 2010, paradossalmente. Limitarsi a dedurne che la valuta sia gravemente sottovalutata è una conclusione un po’ superficiale».
Questo perché giudicare il valore di una valuta esclusivamente in base al saldo commerciale è fuorviante, dice l’ex dirigente dell’Fmi: «L’Europa registra un surplus colossale, perfino maggiore di quello cinese, eppure nessuno sostiene che l’euro sia sottovalutato. Perciò, non condivido del tutto l’idea che lo yuan lo sia: tutto dipende dai parametri che si scelgono per la valutazione». Rogoff spiega che, sotto certi aspetti, il renminbi risulta persino sopravvalutato: «Se la Cina liberalizzasse ulteriormente i movimenti di capitale, il tasso di cambio subirebbe una pressione al ribasso. È già successo nel 2015, quando la fuga di capitali costrinse Pechino a rafforzare i controlli valutari».
Questo perché giudicare il valore di una valuta esclusivamente in base al saldo commerciale è fuorviante, dice l’ex dirigente dell’Fmi: «L’Europa registra un surplus colossale, perfino maggiore di quello cinese, eppure nessuno sostiene che l’euro sia sottovalutato. Perciò, non condivido del tutto l’idea che lo yuan lo sia: tutto dipende dai parametri che si scelgono per la valutazione». Rogoff spiega che, sotto certi aspetti, il renminbi risulta persino sopravvalutato: «Se la Cina liberalizzasse ulteriormente i movimenti di capitale, il tasso di cambio subirebbe una pressione al ribasso. È già successo nel 2015, quando la fuga di capitali costrinse Pechino a rafforzare i controlli valutari».
L’11 agosto 2015, la Banca popolare cinese (Pboc) annunciò una modifica al meccanismo di fissazione del cambio, consentendo al mercato di incidere maggiormente sulla quotazione: lo yuan si deprezzò subito di quasi il 2 per cento in un solo giorno. La decisione inaspettata scatenò un’ondata di panico tra famiglie e investitori, inducendo molti a trasferire capitali all’estero. Secondo l’Institute of International Finance, nel corso di quell’anno fuggirono dalla Cina circa 700 miliardi di dollari.
Le conseguenti massicce vendite di yuan generarono una forte pressione al ribasso sulla valuta cinese, spingendo la Banca Centrale cinese a intervenire per stabilizzare il tasso di cambio mediante una cospicua vendita di riserve in valuta estera (in gran parte dollari e euro), che solo nel 2015 diminuirono di 513 miliardi di dollari, un record assoluto.
Le conseguenti massicce vendite di yuan generarono una forte pressione al ribasso sulla valuta cinese, spingendo la Banca Centrale cinese a intervenire per stabilizzare il tasso di cambio mediante una cospicua vendita di riserve in valuta estera (in gran parte dollari e euro), che solo nel 2015 diminuirono di 513 miliardi di dollari, un record assoluto.
A dieci anni di distanza, il fenomeno della fuga di capitali dalla Cina si ripresenta. I dati dell’Amministrazione statale dei cambi indicano che, nel luglio di quest’anno, le banche cinesi – per conto dei loro clienti – hanno trasferito all’estero 58,3 miliardi di dollari netti per investimenti in titoli, il livello mensile più alto mai registrato dal 2010. Per inciso: una fuga di capitali riflette sempre come minimo una forte sfiducia (a volte paura) per la situazione dell’economia nazionale. Se famiglie e imprese ritengono che l’economia nazionale stia peggiorando – per crescita lenta, inflazione alta, instabilità politica o crisi settoriali come quella immobiliare in atto in Cina – investono i propri soldi in asset esteri più sicuri, perché tenere i soldi in patria mette a rischio di perderli, in parte o del tutto.
Da due anni, la Repubblica Popolare Cinese sta vivendo un’emorragia di capitali senza precedenti: gli investitori stranieri stanno togliendo i soldi dall’economia cinese a un ritmo che non si vedeva da decenni. Il tracollo del mercato immobiliare, la scarsa domanda interna, la deflazione e la guerra commerciale con gli Stati Uniti hanno reso l’economia cinese tutt’altro che attrattiva. Problemi strutturali a cui si sommano le severe regolamentazioni, l’ingerenza del regime e le restrizioni all’accesso ai settori strategici.
LO YUAN STA IN PIEDI SOLO GRAZIE ALLE RESTRIZIONI SUI CAPITALI
Un nuovo esodo di capitali causerebbe un ulteriore deprezzamento della moneta, scenario che il Partito comunista cinese vuole evitare a ogni costo, considerato che sta persino tentando di il renminbi in una valuta di riserva internazionale (intenzione ridicola, se si considera la situazione dell’economia cinese).
Per realizzare questa ambizione, il regime cinese sta imponendo l’uso dello yuan negli scambi bilaterali con certi partner commerciali, sostituendolo al dollaro statunitense. A partire da settembre 2025, ad esempio, tutti i commerci tra la Cina e i Paesi africani sono regolati in renminbi. Pechino ha inoltre sviluppato il Cross-border Interbank Payment System, alternativa al sistema occidentale Swift, per agevolare le transazioni in valuta cinese.
Per realizzare questa ambizione, il regime cinese sta imponendo l’uso dello yuan negli scambi bilaterali con certi partner commerciali, sostituendolo al dollaro statunitense. A partire da settembre 2025, ad esempio, tutti i commerci tra la Cina e i Paesi africani sono regolati in renminbi. Pechino ha inoltre sviluppato il Cross-border Interbank Payment System, alternativa al sistema occidentale Swift, per agevolare le transazioni in valuta cinese.
Ma l’idea di uno yuan che prenda il posto del dollaro, sembra più un’illusione radicata nelle menti di certi gerarchi del Partito comunista cinese, che una reale possibilità. Il 4 dicembre 2025, la Banca Centrale cinese ha fissato il tasso di riferimento giornaliero dello yuan ben al di sotto delle aspettative degli analisti, stabilendo la parità centrale con il dollaro a 7,0733 yuan, cioè 164 punti base più bassa delle previsioni medie del mercato. Si tratta dello scostamento più ampio dal febbraio 2022.
Secondo Bloomberg, questo riflette la volontà della Banca Centrale di contenere l’apprezzamento della valuta. La stessa testata riporta che, nelle ultime settimane, diverse banche statali avrebbero acquistato regolarmente dollari per frenare ulteriormente l’apprezzamento dello yuan.
Ma perché il regime cinese agisce in un modo che sembra ostacolare la propria strategia di internazionalizzazione monetaria? Rogoff spiega che, al momento, Pechino ha altre priorità: «L’economia cinese vive quella che definiremmo una recessione di crescita. L’espansione si è drasticamente rallentata, la disoccupazione – soprattutto giovanile – è molto elevata e la domanda interna rimane debole. Ci sarebbe spazio per stimolare il consumo, ma la strategia scelta è ancora quella di esportare per venire fuori dai problemi interni. Mantenere una moneta debole, in questa logica, è piuttosto utile», perché meno vale la propria moneta, più è facile vendere i propri prodotti sui mercati esteri.
Quindi, mentre una valuta di riserva dovrebbe essere forte, il Pcc svaluta lo yuan invece di fare in modo di farlo apprezzare, perché è vero che il regime «vuole rendere lo yuan una valuta internazionale», spiega Rogoff, ma è anche vero che «Xi Jinping deve rispondere le urgenze del presente: la disoccupazione giovanile altissima, l’aumento generale della disoccupazione e le pesanti eredità della bolla immobiliare e infrastrutturale».
Nel 2023, il tasso di disoccupazione cinese nella fascia d’età 16-24 anni (esclusi gli studenti) ha superato il 21 per cento, tanto che il regime comunista ha sospeso la pubblicazione dei dati mensili per poi “rivederne” il metodo di calcolo. Ma nell’agosto 2025 il tasso di disoccupazione rimaneva comunque elevato: al 18,9 per cento.
Decenni di crescita trainata dagli investimenti hanno generato un enorme indebitamento nei grandi gruppi immobiliari, con fallimenti clamorosi come quelli di Evergrande e Country Garden. E questo ha compromesso la ricchezza delle famiglie e la fiducia dei consumatori cinesi. Nel frattempo, molti governi locali finanziavano imponenti opere infrastrutturali ricorrendo a debiti “fuori bilancio”, accumulando esposizioni debitorie per migliaia di miliardi di dollari. Per questo, dice Rogoff, «pur restando l’obiettivo di lungo periodo quello di internazionalizzare lo yuan, la priorità immediata in Cina è stabilizzare l’economia». Ma i due obiettivi rispecchiano una contraddizione insanabile. Come ogni altro aspetto di ogni società comunista.