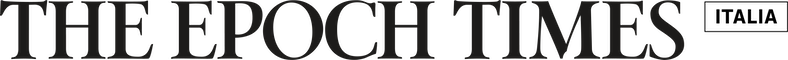Omaggio di uno scrittore alla madre

Disegno ad acquerello di una fabbrica di acciaio a Bethlehem, Penn, nel 1881. Una preziosa lezione davanti a una fabbrica di acciaio. Pubblico dominio
Quando ero molto piccolo la mamma non guidava, ma era una donna dinamica. Spesso prendevamo il tram per fare le commissioni a Baltimora, dove si recava per sbrigare qualsiasi cosa, dalla spesa alla visita dal pediatra. Eravamo negli anni Cinquanta, quando si poteva vivere nei sobborghi verdeggianti di una grande città americana e spostarsi con il tram. I tram erano fantastici! Nella mia giovinezza, erano come un tappeto magico per l’avventura e, con la mamma, anche per imparare.
Una domenica mattina, la mamma mi portò in un posto del centro, forse stavamo visitando la vecchia cattedrale, non ricordo bene la destinazione. Ma non dimenticherò mai quello che ho imparato in quel viaggio: passammo davanti a una grande acciaieria e devo essermi meravigliato per le grandi ciminiere che sprigionavano fumo. Pochi anni prima della mia nascita, durante la Seconda Guerra Mondiale, questi impianti erano stati una parte vitale della produzione di acciaio. Ed erano ancora lì, a fumare.
La mamma mi chiese: «Sai perché le ciminiere e gli altiforni restano sempre accesi, anche nei giorni in cui non c’è nessuno per produrre acciaio?».
Era una bella domanda, ma forse più difficile di quanto la mente di un bambino fosse in grado di comprendere. Così la mamma, che è sempre stata un’insegnante straordinaria, mi spiegò dettagliatamente come si produce l’acciaio: «Gli altiforni sono molto caldi! E i fuochisti che li accendono non possono mai farli raffreddare. Se mai dovessero spegnersi, ci vorrebbero settimane per riportare nuovamente la temperatura al livello ottimale».
Settimane! La mamma descrisse esattamente come veniva realizzato un altoforno. Bisognava costruire un forno di mattoni con una ciminiera enorme. Poi, i falegnami costruivano al suo interno un’impalcatura fatta di legname e alla base di questa si accendeva un fuoco che avrebbe bruciato l’intera struttura. Il fuoco faceva aumentare la temperatura mentre consumava tutto il legname.
Per questo doveva essere alimentato continuamente, anche di domenica e a Natale, anche nelle notti in cui non c’era nessuno a lavorare, una squadra di pompieri a rotazione alimentava i grandi forni – che ora andavano a carbone – per mantenerli alla giusta temperatura. Con questo sistema gli operai del primo turno potevano mettersi subito al lavoro per produrre l’acciaio.
La mamma era una bravissima insegnante. Infatti, appena uscita dal Westhampton College – che ora è parte dell’Università di Richmond – insegnò in una zona che spesso definiva ironicamente «la terza battaglia di Manassas» e viveva in una pensione nella quale risiedeva anche un bravo cacciatore. Si era al culmine della Depressione e la mamma gradiva molto di trovare spesso la carne in tavola, anche se a lei e a tutti gli altri ospiti capitava sovente di togliere i pallini (contenuti nelle cartucce dei fucili da caccia) dalla loro cena a base di selvaggina fresca.
In un’epoca in cui erano poche le donne di campagna che potevano completare gli studi universitari, la mamma si è laureata in fisica. Lasciò l’insegnamento e andò alla Johns Hopkins di Baltimora, andava a scuola in tram. Poi arrivò la Guerra Mondiale, in quegli anni la Glenn L. Martin Company progettava e costruiva idrovolanti per il teatro di guerra del Pacifico e la mamma ottenne un lavoro nel loro dipartimento di ingegneria. Se avete visto il film Hidden Figures, (Il diritto di contare, film del 2016 di Theodore Melfi) sapete esattamente cosa fece.
I dipartimenti di ingegneria assumevano donne esperte in matematica per lavorare a fianco dei progettisti – allora prevalentemente uomini. Il loro lavoro era essenziale per il rapido sviluppo di nuove fusoliere e la mamma era abile con il regolo calcolatore, allora non c’erano computer sofisticati, ma solo grosse e goffe addizionatrici… A quei tempi i “computer” erano le persone.
Quella era la quintessenza della storia americana: mio padre era un ingegnere che progettava aerei e sposò la sua “calcolatrice”. La mamma non ha mai perso la passione per l’insegnamento, era sempre pronta a stimolare le osservazioni dei suoi figli: com’era bello avere una madre che faceva notare quei bellissimi aeroplani! Era cresciuta in una fattoria, quindi era altrettanto entusiasta di far notare le meraviglie del mondo naturale.
Ricordo un giorno di sole, ero molto piccolo e ci sedemmo fuori al tavolo da picnic. La mamma tirò fuori del cartoncino, forbici, colla e costruimmo dei modellini di case che poi sistemammo in giardino. Per qualche particolare ragione, quel pomeriggio è stato per me molto soddisfacente, tanto che lo ricordo ancora oggi.
A quei tempi non erano in molti a studiare a casa, quindi la prima istruzione così idilliaca che avevo ricevuto ha dovuto lasciare il posto a quella che per me è stata un’esperienza piuttosto frustrante di istruzione di massa. Ho fatto fatica a seguire la scuola, ma mamma e papà sono stati dei maestri pazienti, mi hanno aiutato ad andare avanti. Molti anni dopo, la mamma mi confidò che avrebbe voluto che avessimo studiato a casa. Credo che pensasse che sarebbe stato certamente più proficuo.
Ci ha trasmesso l’amore per l’apprendimento (e per la condivisione del sapere), ma credo che la lezione più importante per me sia stata di tipo metaforico, mi ha insegnato qualcosa sul processo creativo. Anche quando eravamo in vacanza, era la mamma che spesso si soffermava su qualcosa che avevamo notato appena: mi ha insegnato a guardare il mondo. Ma la cosa che più ha influito sulla mia formazione mentale è stata la “lezione” sugli altiforni: c’è qualcosa nello spirito creativo che non deve mai raffreddarsi, bisogna sempre alimentarlo. Per questo dico: «Grazie, mamma! È vivo e vegeto anche nelle tue pronipoti!».
I miei figli, e i loro figli, vogliono conoscere e come amano spiegare! Quando studiano l’antica civiltà greca, vogliono sapere che cosa mangiavano gli antichi greci a quel tempo – e poi preparano quei piatti! Il testimone viene passato, ma una giornata con le mie nipoti è spesso un momento in cui l’energia creativa viene trasmessa a vicenda.
Abbiamo costruito un modello in scala di un castello francese, abbiamo fatto volare il paracadute di Leonardo da Vinci dal tetto del portico e abbiamo persino assemblato il suo unico progetto di ponte, quello che si incastra senza bisogno di fissaggi e che deve essere trasportato da soldati che portano ciascuno una parte. Passare un pomeriggio con loro è stancante, ma dà entusiasmo. Il fuoco è in tutti noi: lo alimentiamo con i nostri progetti estivi, con le conversazioni e a volte con il gioco, lo trasmettiamo uno all’altro. Il carburante inesauribile è la meraviglia. Credo che la mamma ne sarebbe contenta!
Articoli attuali dell'autore
25 giugno 2025
Omaggio di uno scrittore alla madre