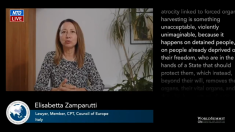Una volta il generale Gordon Sullivan, ex capo dello staff di peacekeeping delle forze armate statunitensi disse: «Per essere un buon peacekeeper devi essere prima di tutto un buon soldato».
A dispetto delle odiose guerre in Iraq e Siria, della ‘guerra fredda’ in Ucraina, e delle feroci guerre che a volte scoppiano nei Paesi africani, il concetto e l’idea del peacekeeping ha guadagnato una certa rilevanza negli ultimi tempi; è diventato addirittura la celebrità dell’anno per via delle numerose ‘piccole guerre’ in Libia, nel Sinai e per i conflitti in Mali, Sudan e nella Repubblica democratica del Congo.
Ma è una pratica del tutto inefficace: come usare un cerotto al posto di un operazione chirurgica.
Per capirlo meglio, si osservi un po’ di storia e si facciano un po’ di conti.
Stando a dati del 29 febbraio 2016, 124 Paesi hanno contribuito con 105 mila 314 addetti alle operazioni di peacekeeping, di cui 8 mila 324 provenienti dall’Etiopia, 7 mila 695 dall’India e 7 mila 525 dal Bangladesh; molti di questi ‘caschi blu’ non erano esattamente motivati da una forte abnegazione e da senso del sacrificio: il compenso messo a disposizione dalle Nazioni Unite per i soldati, infatti, includeva uno stipendio mensile di 1.028 dollari per ogni peacekeeper, con un’aggiunta di 303 dollari per gli specialisti, 68 dollari per abbigliamento, attrezzatura ed equipaggiamento e 5 dollari per armamenti personali. Questo porta a considerare i peacekeeper in modo più simile a dei moderni mercenari e la cosa si riflette nei crimini commessi da questi ‘operatori di pace’, che non si sono esattamente rivelati la crème de la crème.
Recentemente la partecipazione canadese alle missioni Onu è stata solo nominale; sin dal 1995 è andata declinando sempre più, quando invece, nel passato, il Paese non aveva perso occasione per farsi coinvolgere in tali attività (anche solo offrendo aiuto con del personale); il declino della partecipazione è iniziato quando il Canada ha preso a dedicarsi alle operazioni militari ‘Warfighting’ delle Nazioni Unite sanzionate dalla Nato, piuttosto che a quelle puramente dell’Onu.
Nel luglio 2006 il Canada si è posizionato al 51mo posto tra i caschi blu delle Nazioni Unite contribuendo con 130 unità su un totale di 70 mila uomini impiegati dalle Nazioni Unite; nel 1990 il Canada aveva 1.002 soldati su un totale di 10 mila 304 caschi blu impegnati.
Ma ora il Paese sta pensando a un ritorno in scena. L’idea che l’attuale governo liberale ha del peacekeeping è descrivibile dalla definizione ‘non siamo come i conservatori di Stephen Harper’, il quale aveva evitato le spedizioni militari come quelle in Afganistan; ancora più cinico è il pensiero implicito che il Canada del peacekeeping otterrà più voti quando ci saranno le elezioni del Consiglio di Sicurezza nel 2021. Ma qualora perdurasse ancora un vago ricordo, di quello che era il peacekeeping una volta, cioè civili in abiti militari, il ritorno al futuro procurerà un’amara e forse sanguinosa delusione.
L’immagine che il Canada ha del ‘mantenimento della pace’ è forse simile a quella che si è vista nel caso di Cipro, dove aveva impiegato 25 mila soldati, spesso in formazione da combattimento, che pattugliavano l’isola per impedire che greci e turchi ciprioti si prendessero per la gola.
C’era una larga e ben definita ‘Linea Verde’ che divideva le due fazioni opposte e questo rendeva il tour piuttosto noioso. Alla fine infatti Ottawa si ritirò, ritenendo che fosse uno spreco di soldi e che sarebbe bastato impiegare un gruppo di boy scout.
Tuttavia di recente il ministro della Difesa canadese Harjit Sajjan è tornato da una vista in Mali, Sudan del Sud, Repubblica del Centro Africa e Repubblica Democratica del Congo, e ha dato l’impressione di essere alla disperata ricerca di una missione da affidare ai soldati canadesi, utile a ottenere il plauso nazionale, ma che non metta in pericolo delle vite.
Appena tornato ad Ottawa, infatti, Saijan ha annunciato che il Canada metterà a disposizione 600 uomini, inclusi ingegneri e personale medico con l’ausilio di aerei ed elicotteri; tuttavia non ha specificato quando e dove sarebbero stati dislocati. Di conseguenza in molti, in ambito militare, erano in fibrillazione sul ‘dove’; quanto al ‘quando’, si è lasciato intendere che un contingente di peacekeeper sarà pronto per la fine dell’anno.
Fortunatamente gli addetti non sono sulla pista di lancio in attesa di un ordine di partenza che sembra non arrivare mai.
Ci sono ancora tre cose da tener presente: primo, i Paesi menzionati del viaggio di Saijan non hanno dei parametri chiari di azione/responsabilità che il Canada potrebbe controllare; secondo, non ci sono vie di uscita chiare dal conflitto, in quanto questo Paesi hanno dei problemi indefiniti e degli obiettivi imprecisi; terzo, le perdite sarebbero significative e i canadesi sono alquanto avversi ai caduti in battaglia. Ed infine ci sono situazioni che offrono migliori vantaggi e migliori opportunità di mettere in mostra i talenti del Canada: per esempio Haiti.
L’isola di Haiti rimane un semi-disastro a lungo termine: è ancora lontana dal riprendersi dopo il terremoto del 2010, con case e infrastrutture in deplorevoli condizioni, esacerbate e aggravate dal recente Uragano Metthew. Inoltre le forze del Nazioni Unite sono accusate di aver provocato un’epidemia di colera sull’isola. Al contrario, il Canada ha una considerevole esperienza ad Haiti, grazie a molto cittadini canadesi haitiani, che possono offrire un solido supporto linguistico e una base culturale per la comprensione dei problemi. In più il Paese ha definito i suoi parametri, la sua cultura è comprensibile, e la sua politica, sebbene nel caos, non è caratterizzata da un’insurrezione armata. Tutto questo rende gli obiettivi per la ricostruzione ben definibili.
In breve, il Canada dovrebbe adottare Haiti e dovrebbe fare della riabilitazione di Haiti un obiettivo a lungo termine, tramite il quale il peacekeeping tradizionale diverrebbe di nuovo importante. I vantaggi sarebbero tangibili e visibili da tutto il mondo, e non ci sarebbero morti da contare.
David T. Jones è un ufficiale in pensione del servizio estero del Dipartimento di Stato americano. Ha pubblicato diverse centinaia di libri, articoli, editoriali e recensioni sulle questioni bilaterali USA-Canada e sulla politica estera in generale. Nel corso di una carriera durata oltre 30 anni, si è concentrato su questioni politico-militari, e ha servito come consulente durante il mandato di due capi di Stato Maggiore dell’Esercito.
Le opinioni espresse in questo articolo sono le opinioni dell’autore e non necessariamente riflettono le opinioni di Epoch Times.
Articolo in inglese: Peacekeeping Is a Feckless Exercise
Traduzione: Fabio Cotroneo