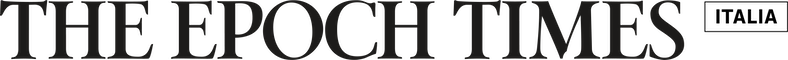Come sconfiggere la fame emotiva

Illustrazione: Epoch Magazine
Da sempre l’equazione “calorie assunte contro calorie bruciate” è insegnata come regola per controllare il peso, ma nella pratica non sempre funziona. Lo spiega lo psichiatra Judson Brewer, docente alla Brown University, nel suo libro The Hunger Habit (2024). Molti pazienti, pur conoscendo la dieta adatta, non riuscivano a smettere di mangiare oltre il necessario. Interrogandoli, Brewer ha scoperto che le ragioni erano spesso emotive, non legate alla fame.
La maggior parte delle persone, secondo Brewer, non distingue tra fame fisica, o “omeostatica” — caratterizzata da stomaco vuoto e stanchezza — e fame “edonica”, spinta da impulsi emotivi. Oggi si mangia spinti dalla tristezza, noia o rabbia. Una persona stressata cerca sollievo nel cibo, un comportamento che si radica al punto da ignorare i segnali del corpo. Consumare zuccheri, ad esempio, sopprime temporaneamente emozioni come rimpianto o vergogna, permettendo di evitarle senza affrontarle.
Questo meccanismo si basa sul “rinforzo negativo”: il cervello, per sfuggire a sensazioni spiacevoli, spinge verso cibi gustosi che offrono un piacere immediato. Nel tempo, si preferiscono queste sensazioni positive a quelle negative, creando un circolo vizioso. Il filosofo britannico Bertrand Russell, nel libro La conquista della felicità (1930), descriveva cinque tipi di mangiatori: l’annoiato, che mangia per routine; il malato, che segue diete mediche; l’intenditore, sempre insoddisfatto; il ghiottone, che divora senza controllo; e chi ha un rapporto equilibrato col cibo e mangia con consapevolezza.
Brewer sottolinea che spesso si mangia in “modalità automatica”, disconnessi dal corpo. Racconta di Anne, una paziente perfezionista che, nel tentativo di controllare l’obesità con regole rigide, finiva per cedere a eccessi quando era stanca. «Le regole l’hanno allontanata dai segnali del corpo — spiega Brewer — più ci si distacca, più è difficile riconoscerli». Per regolare le abitudini alimentari, bisogna ascoltare il corpo e capire di cosa ha bisogno.
IL MITO DELLA FORZA DI VOLONTÀ
Affidarsi solo alla forza di volontà è un errore, secondo lo psichiatra Judson Brewer. L’idea di controllare il comportamento con la sola determinazione è un’illusione. Cita l’esperimento degli anni ’80 del neurologo Benjamin Libet, che misurava l’attività cerebrale tramite l’elettroencefalografia per studiare decisioni consapevoli. I partecipanti piegavano il polso spontaneamente, segnalando il momento dell’intenzione con un orologio. I risultati hanno mostrato che il “potenziale di prontezza”, un segnale cerebrale, inizia 550 millisecondi prima del movimento, mentre la consapevolezza emerge solo 200 millisecondi prima. Questo intervallo di 350 millisecondi indica che il cervello decide inconsciamente. «Il cervello decide prima che ne siamo consapevoli — afferma Brewer — e ci illudiamo di avere forza di volontà».
Ma l’interpretazione di Libet non è priva di critiche. Nel 2012, il neuroscienziato Aaron Schurger ha contestato questa tesi, sostenendo che il potenziale di prontezza sia un artefatto statistico derivante dal rumore neurale, ossia fluttuazioni casuali dell’attività elettrica cerebrale non legate a una decisione specifica. Secondo Schurger, questo rumore si accumula fino a una soglia che scatena l’azione, con la consapevolezza che emerge in parallelo all’integrazione di questi segnali cerebrali, non dopo una decisione inconscia.
In ogni caso, l’idea che la forza di volontà sia limitata trova riscontro nelle difficoltà pratiche di controllo del comportamento. Sforzarsi con la forza di volontà crea una lotta interiore che consuma energie. Funziona a breve termine, ma a lungo termine crolla. Quando si cede, spesso si abbandona del tutto il controllo, preferendo cibi spazzatura a opzioni più sane. Qualsiasi dieta, se basata solo sulla forza di volontà, porta a una perdita di peso iniziale, ma poi a un recupero, spesso superiore.
CONSAPEVOLEZZA E NUOVE ABITUDINI
Per spezzare questo ciclo, Brewer propone un approccio basato sulla consapevolezza, che permette di riconoscere i momenti critici e interrompere gli automatismi. La sua esperienza con tossicodipendenti e fumatori lo ha portato a sviluppare un programma in 21 fasi, diviso in tre componenti, tutte incentrate sulla consapevolezza.Mappare le abitudini: Si inizia identificando i cicli abituali, un fattore scatenante (stress, noia), un comportamento (mangiare) e una conseguenza (sollievo temporaneo o senso di colpa). Scrivere un diario aiuta a notare quante volte si mangia per emozioni, non per fame. Questo sviluppa la consapevolezza per riconoscere in tempo reale i momenti di vulnerabilità.
Ascoltare il corpo: Si impara a prestare attenzione a ciò che accade quando si mangia o si beve. Ad esempio, sorseggiando una bevanda zuccherata, ci si chiede se ogni sorso è piacevole come il primo. Questo aiuta a capire quando si è sazi e a valutare se un’abitudine è davvero gratificante. In alcuni casi, riconoscere le conseguenze negative (come la pesantezza) crea un’avversione che spinge a cambiare.
Cercare alternative positive: Si sostituiscono le vecchie abitudini con comportamenti più appaganti. Ad esempio, invece di abbuffarsi, si mangia con moderazione, notando come ci si sente meglio. Questo “rinforzo positivo” rafforza il nuovo comportamento.
STRUMENTI PRATICI
Brewer suggerisce tecniche per facilitare il processo. La “scansione corporea” consiste nel focalizzarsi sulle sensazioni fisiche, dalla pianta dei piedi alla testa, per riconnettersi col corpo e sviluppare curiosità verso i suoi segnali. Si può praticare ovunque, dalla mattina al tragitto in autobus. Un’altra tecnica è il metodo Rain (Riconoscere, Accettare, Investigare, Notare), che aiuta a osservare le emozioni senza giudicarle, riducendo sensi di colpa e resistenze.
Per distinguere la fame fisica da quella emotiva, Brewer propone il “test della fame”: sensazioni come vertigini o gorgoglio indicano fame omeostatica, mentre tensione o desiderio di evitare emozioni segnalano fame edonica. Rallentare il ritmo del pasto è cruciale: il corpo impiega circa 20 minuti per inviare segnali di sazietà al cervello. Concentrarsi sul piacere di ogni boccone aiuta a identificare il “plateau del piacere”, il momento in cui il gusto non aumenta più, indicando che è ora di smettere.
CAMBIARE PROSPETTIVA
Mangiare a orari fissi, spesso consigliato per la salute, può allontanare dall’ascolto del corpo, secondo Brewer. Il corpo sa inviare segnali precisi di fame e sazietà. Seguire schemi rigidi può confondere. La consapevolezza non si limita al cibo: imparare a gestire le abitudini alimentari insegna a modificare altri comportamenti, come reagire con più gentilezza in situazioni di stress.
«Lavorare col cibo è un punto di partenza — conclude Brewer. — Una volta aperta questa porta, si possono trasformare molti aspetti della vita, sviluppando una saggezza che va oltre il piatto».
Le informazioni e le opinioni contenute in questo articolo non costituiscono parere medico. Si consiglia di confrontarsi sul tema col proprio medico curante e/o con specialisti qualificati.
Articoli attuali dell'autore
13 novembre 2025
Sharaa sui contrasti con Israele: Trump appoggia la Siria
12 novembre 2025
Trump chiede la grazia per Netanyahu
07 novembre 2025
Israele continua le operazioni contro Hezbollah in Libano