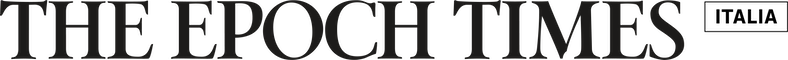Un anno fa l’attentato a Donald Trump

Donald J. Trump si alza dopo essere stato ferito, mentre parlava al comizio di Butler, in Pennsylvania, e col pugno in aria urla tre volte alla folla «Fight»
Photo: foto © Artem Priakhin/SOPA Images via ZUMA Press Wire via Ansa.
Il 13 luglio 2024, durante un comizio elettorale all’aperto, Donald Trump scampava miracolosamente a un proiettile che avrebbe dovuto colpirlo in testa ma che invece gli sfiorava l’orecchio destro, ferendolo solo lievemente. Riportiamo il racconto in prima persona scritto, due settimane dopo, da Janice Hisle, una collega di Epoch Times Usa presente al raduno elettorale repubblicano di Butler, in Pennsylvania.
Sotto un tavolo di legno, tremante, mi trovavo sola, intrappolata e disorientata, nonostante migliaia di spettatori mi circondassero. Era poco dopo le 18:11, ora della costa orientale degli Stati Uniti, del 13 luglio 2024.
Per la prima volta in trent’anni di carriera giornalistica, mi trovavo nel mezzo di una sparatoria. E non era un episodio qualunque: si trattava del tentato assassinio dell’ex presidente Donald Trump. Quella sera, scrissi sui social media: «Non era questo il tipo di evento ‘storico’ che avrei mai voluto raccontare». Ma era il mio dovere. Un dovere che mi ha scosso nel profondo. Non avevo mai temuto tanto per la mia vita. Eppure, mi ripromisi di cercare la verità, per quanto scomoda fosse. Ora, a due settimane di distanza, continuo a riflettere sulle scelte che ho dovuto affrontare, sul vuoto informativo che ha avvolto la mia zona del raduno e sulle circostanze che mi hanno riempito di un senso di inquietudine, più di quanto fosse mai accaduto nei trentaquattro eventi di Trump che avevo seguito per The Epoch Times.
Cinque ore prima che Trump salisse sul palco, arrivai al Butler Farm Show, il luogo del raduno. Notai subito numerose strutture sparse nell’area aperta e pianeggiante, e mi chiesi: «Come faranno a mettere in sicurezza tutti questi edifici?». All’inizio scacciai quel pensiero, ma ora so che il deputato Mike Kelly, il cui collegio elettorale include la città di Butler, era preoccupato per la scelta di quel sito. Durante un’audizione parlamentare del 23 luglio, ha dichiarato che le molteplici strutture rappresentavano troppe vulnerabilità per la sicurezza. Una di quelle strutture divenne il punto d’appoggio per il sospetto attentatore, il ventenne Thomas Crooks, a meno di 150 metri dal palco dove Trump avrebbe parlato.
Arrivata al punto di controllo per la stampa, un volontario verificò il mio nome sulla lista dei giornalisti accreditati. Tuttavia, contrariamente alla prassi, non mi fu consegnato alcun cartellino. Il volontario mi disse di ritirarlo all’interno dell’area dell’evento. Superati i metal detector, raggiunsi la “zona stampa”, un’area recintata riservata ai reporter. Qui accadde qualcosa di insolito: nessuno mi fermò per controllare le mie credenziali. Entrai senza che nessuno mi chiedesse nulla. Non mi era mai successo prima.
Arrivata al punto di controllo per la stampa, un volontario verificò il mio nome sulla lista dei giornalisti accreditati. Tuttavia, contrariamente alla prassi, non mi fu consegnato alcun cartellino. Il volontario mi disse di ritirarlo all’interno dell’area dell’evento. Superati i metal detector, raggiunsi la “zona stampa”, un’area recintata riservata ai reporter. Qui accadde qualcosa di insolito: nessuno mi fermò per controllare le mie credenziali. Entrai senza che nessuno mi chiedesse nulla. Non mi era mai successo prima.
Chiesi a un collega informazioni sui cartellini per la stampa, e lui mi rispose: «Li distribuisce il Secret Service». Trovai un agente, mostrai il mio documento, ottenni il cartellino e iniziai a preparare la mia attrezzatura. Cinque minuti dopo, una donna in uniforme si avvicinò: «Scusi, come è entrata qui?». Le spiegai i miei movimenti, e lei, con un’espressione accigliata, disse qualcosa sul dover verificare la situazione, poi si allontanò. Sul momento non mi parve grave, tanto che non annotai a quale agenzia appartenessero gli agenti. Tuttavia, ripensandoci, mi chiedo se quell’apparente svista fosse un segnale di problemi più ampi nella sicurezza, culminati con la morte di uno spettatore, Corey Comperatore, e il ferimento di Trump e altre due persone. All’epoca, però, misi da parte le mie preoccupazioni e mi misi al lavoro sotto un ombrello nero che proteggeva me e la mia attrezzatura dal sole cocente.
La temperatura raggiunse i 34 gradi. La folla sudava copiosamente, in attesa del discorso di Trump. Ogni tanto, una brezza vivace offriva un po’ di sollievo. Poco prima delle 16:00, un’ora prima dell’inizio previsto del discorso, il vento fece attorcigliare un’enorme bandiera americana, creando una forma insolita. «Guarda, sembra quasi un angelo davanti a noi», disse un uomo alle mie spalle. Pubblicai una foto della “bandiera angelo” sui social media pochi minuti dopo, colpita dalla sua bellezza. Mi chiesi se avesse un significato simbolico. In seguito, molte persone mi dissero che lo pensavano. Gli addetti srotolarono la bandiera e la issarono di nuovo; circa un’ora e mezza dopo, Trump salì sul palco.
Trump apparve intorno alle 18:00, con un’ora di ritardo rispetto al programma. Nel frattempo, il presunto attentatore si trovava su un tetto; alcuni spettatori avevano segnalato alla polizia una persona “sospetta” quasi un’ora prima del discorso, ma né la folla né Trump ne erano consapevoli. Come di consueto, scattai alcune foto delle reazioni del pubblico prima di concentrarmi sul discorso. Meno di quattro minuti dopo aver iniziato a prendere appunti, fui colta di sorpresa. Sentii dei rumori simili a petardi, un “pop-pop-pop”. Seguirono suoni più secchi, e capii l’orrenda verità: erano spari. In quel momento, mi parve che la seconda raffica provenisse dal fuoco di risposta delle forze dell’ordine. Ma l’Fbi rivelò il 24 luglio che otto colpi erano partiti dall’arma dell’attentatore; le registrazioni mostrano che passarono circa dieci secondi prima che un cecchino neutralizzasse il sospetto. Mi fece rabbrividire il pensiero che in quel lasso di tempo avrebbe potuto sparare ancora; grazie a Dio non lo fece. Mi chiedo se sapremo mai perché si fermò.
La folla iniziò a urlare. Il mio istinto era diviso tra “scappa per salvarti” e “resta per la verità”. Qualcuno dietro di me gridò: «Giù! Tutti a terra!». Mi accovacciai sotto il tavolo, il cuore mi batteva all’impazzata. Il mio Apple Watch registrò una frequenza cardiaca di 130 battiti al minuto, il doppio del normale. Una piattaforma alta, occupata da troupe televisive e attrezzature, impediva a me e a chi era vicino di vedere Trump. Tutti ci affidavamo a un grande schermo per seguirlo. Ma al momento degli spari, lo schermo mostrava un grafico sui dati dell’immigrazione, non lui. Quel grafico gli salvò la vita, avrebbe detto Trump in seguito, che era uscito dal copione e aveva chiesto di mostrarlo. Girò leggermente la testa per guardarlo. L’ex medico della Casa Bianca, Ronny Jackson, disse che un proiettile aveva perforato la parte superiore dell’orecchio di Trump, mancando il cranio di pochi millimetri.
Sul fondo della folla, Logan Reynolds, 27 anni, mi raccontò di aver visto più di mille volti terrorizzati voltarsi verso di lui subito dopo gli spari. «Ho visto il terrore in un istante», disse, aggiungendo che cercò di calmare le persone.
Alcuni sostenitori di Trump rimasero fermi, senza mai abbassarsi. Mike Boatman, dell’Indiana, ed Erin Autenreith, di Pittsburgh, seduti in prima fila, mi dissero che la preoccupazione per Trump superava il timore per la propria sicurezza, così rimasero seduti. A pochi minuti dalla sparatoria, un applauso si levò dagli spettatori più vicini a Trump. Nessuno vicino a me sapeva che si era appena rialzato, con il sangue che gli colava sul viso, e aveva alzato il pugno, incitandoli: «Fight! Fight! Fight!».
Alcuni sostenitori di Trump rimasero fermi, senza mai abbassarsi. Mike Boatman, dell’Indiana, ed Erin Autenreith, di Pittsburgh, seduti in prima fila, mi dissero che la preoccupazione per Trump superava il timore per la propria sicurezza, così rimasero seduti. A pochi minuti dalla sparatoria, un applauso si levò dagli spettatori più vicini a Trump. Nessuno vicino a me sapeva che si era appena rialzato, con il sangue che gli colava sul viso, e aveva alzato il pugno, incitandoli: «Fight! Fight! Fight!».
Anche se non potevamo vedere cosa stesse accadendo, gli applausi e i cori che scandivano «Usa!» sembravano indicare che il pericolo fosse passato nella nostra zona. Tornai di corsa al mio laptop. Alle 18:14, tre minuti dopo la sparatoria, inviai un messaggio al mio caporedattore a New York: «Non riesco a far funzionare il telefono… non ho idea di cosa stia succedendo… sembrava fossero spari». Le persone vicino a me non avevano idea di cosa fosse accaduto. Qualcuno disse: «È una sparatoria di massa», e pensai che un cecchino potesse essere tra la folla. Gli spari sembravano troppo vicini per essere diretti a Trump. Tenendomi bassa, mi diressi verso la piattaforma televisiva, nascondendomi dietro grosse attrezzature, alzando la testa di tanto in tanto per capire cosa stesse succedendo. Un uomo nella folla mi gridò: «Signorina, hanno sparato a Trump?». Io risposi onestamente: «Non ne ho idea». Dovevo scoprirlo, senza presupposizioni, come troppe volte fanno alcuni colleghi. La paura per lui, per tutti i presenti e per la nostra nazione mi consumava. Ma mi feci strada verso la zona stampa, chiedendo alle persone: «Cosa è successo?». Una persona, di cui non colsi il nome, mi disse: «Potrebbe essere stato colpito… non lo so, ho visto persone portate via dall’area del palco». Finalmente trovai testimoni diretti della sparatoria disposti a parlare.
Gli agenti stavano ordinando alla gente di andarsene. Mentre i partecipanti al raduno passavano davanti alla zona stampa, molti gridavano insulti, accusando i “giornalisti bugiardi” di diffondere informazioni fuorvianti su Trump, alimentando l’odio nei suoi confronti. Quelle parole non mi ferirono, perché la mia coscienza era pulita. Io ho sempre rispettato il mio giuramento personale, fatto a dodici anni quando decisi che il giornalismo sarebbe stato il mio mestiere: essere il più possibile veritiera in ogni mio lavoro.
Ma cercare la verità non è sempre piacevole. Quel giorno, fu doloroso guardare negli occhi persone terrorizzate e traumatizzate e chiedere cosa fosse successo. Mi sentivo un’intrusa. Ma era fondamentale raccogliere le loro parole. Internet, telefono e laptop non funzionavano, in parte per il caldo intenso, e probabilmente le reti cellulari erano sovraccariche. Avevo raccolto notizie, ma non potevo trasmetterle in redazione. Non riuscii nemmeno a dire a mio marito che stavo bene finché un altro reporter non mi prestò il suo telefono.
Ma cercare la verità non è sempre piacevole. Quel giorno, fu doloroso guardare negli occhi persone terrorizzate e traumatizzate e chiedere cosa fosse successo. Mi sentivo un’intrusa. Ma era fondamentale raccogliere le loro parole. Internet, telefono e laptop non funzionavano, in parte per il caldo intenso, e probabilmente le reti cellulari erano sovraccariche. Avevo raccolto notizie, ma non potevo trasmetterle in redazione. Non riuscii nemmeno a dire a mio marito che stavo bene finché un altro reporter non mi prestò il suo telefono.
Mentre i minuti passavano, le donne continuavano a singhiozzare. Un elicottero ronzava sopra di noi. Un veicolo fuoristrada sfrecciò con degli agenti a bordo. La polizia gridava: «Fuori! Fuori! Fuori!». Qualcuno disse che l’intera area era ora una scena del crimine, e gli agenti si fecero più insistenti, urlando ai reporter: «Via, via!». Continuavo a intervistare persone mentre correvo verso la mia auto; finalmente riuscii a contattare una collega e le riferii cosa era accaduto. Mi sentii fortunata a essere viva, anche se in seguito scoprii di non essere stata nella linea di tiro diretta.
Uscendo, riconobbi che la mia esperienza era nulla rispetto a quella di chi aveva vissuto la sparatoria in prima persona, di chi era stato colpito, dei loro cari, di chi aveva sentito i proiettili sibilare o era vicino alle vittime. Pensai anche a questo: nulla di ciò che avevo vissuto si avvicinava al pericolo che militari e agenti di pubblica sicurezza affrontano per tenere il nostro paese sicuro e libero. Quel giorno ebbi un piccolo assaggio del terrore che loro affrontano con coraggio, e la mia stima per la loro dedizione e i loro sacrifici crebbe immensamente. Prima di andarmene, mi voltai e vidi la bandiera americana pendere sopra la scena vuota della tragedia: una silenziosa testimonianza della resilienza americana.