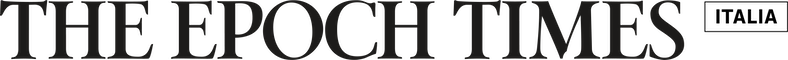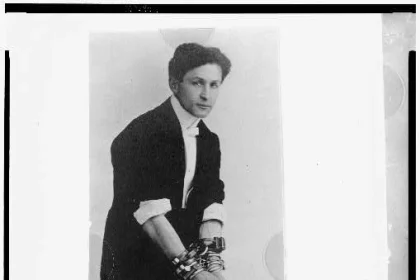Le favole di Esopo sono antiche perle di arguzia e saggezza

Raffigurazione di Esopo tratta dalla Cronaca di Norimberga. Pubblicata nel 1493. Matanya. Pubblico Dominio
| Aggiornato alle
Condividi articolo
Tempo di lettura: 9 Min.
Tempo di lettura: 9 Min.
Che da bambini abbiate letto o meno Esopo, le sue favole sono un’occasione per grandi e piccoli di godere di antichi gioielli di arguzia e saggezza. Le sue brevi storie, con animali parlanti e finali a sorpresa, attraggono naturalmente i bambini, facendo nel contempo riflettere un po’ anche gli adulti. Se ne contano almeno 358, ma si ritiene che al gruppo iniziale se ne siano aggiunte altre nel corso dei secoli. Il termine “favola” tramandato nella tradizione ha avuto origine proprio dalle favole del narratore greco, e il loro scopo era lasciare una morale, una lezione di vita. Alla fine di ogni racconto infatti si trova la frase o mythos deloi oti: la favola insegna che.
Le favole di Esopo probabilmente venivano raccontate molto prima che fossero messe per iscritto, tramandate oralmente di generazione in generazione. Alcune sono diventate tanto familiari da essere entrate nel linguaggio comune: Al lupo al lupo, La lepre e la tartaruga, La cicala e la formica, La volpe e l’uva sono solo alcune. Quando si definisce un politico “un lupo travestito da agnello” o si liquida qualcuno con: «certo, l’uva è acerba», sappiamo esattamente cosa si intende, grazie a Esopo.

La Cicala e la Formica, illustrazione di Milo Winter del 1919. Pubblico Dominio
Nei racconti si trovano temi ricorrenti di personaggi o cose: Favole della volpe, Alberi e piante, Scherzi da scimmia e altri ancora. Sebbene in alcune storie compaiano persone e occasionalmente qualche dio greco, i personaggi sono per la maggior parte animali, piante e persino oggetti. Ma, nella loro brevità, offrono uno spaccato della vita nell’antica Grecia, dove l’agricoltura, la pastorizia e la caccia permettevano ai primi ascoltatori e lettori di restare più in contatto con il mondo naturale rispetto agli abitanti delle città di oggi. Essi avevano familiarità con il bestiame, i raccolti, le stagioni e i caratteri tradizionali propri di varie creature: la volpe astuta, il bue stupido, il pavone vanitoso e la formica laboriosa. Esopo attinge a questa familiarità per intrecciare le storie con le caratteristiche umane: apparenza, verità, stoltezza, astuzia, riuscendo a trasmettere così il messaggio educativo.
Diamo un’occhiata a una delle favole più conosciute, La gallina dalle uova d’oro.
Un uomo possedeva una gallina che ogni giorno deponeva un uovo d’oro. Tuttavia, guadagnare così tanto ogni giorno non gli bastava e, nella sua stoltezza, voleva di più. Così un giorno uccise la gallina, per impossessarsi di tutte le uova contenute al suo interno ma, non trovando assolutamente nulla, si rimproverò: «Speravo di trovare ricchezze e spinto da quella speranza ho perso quello che già possedevo». La morale è che molto spesso le persone perdono il poco che hanno per l’avidità di possedere di più.
Non si sa quando la gallina sia diventata un’oca, forse è dipeso dalle traduzioni, perché in alcuni Paesi si dice: «Non uccidere l’oca che depone le uova d’oro!». La favola è così famosa che a volte l’ammonimento viene abbreviato in: «Non uccidere l’oca!».
Aristotele osservava: «Le favole sono particolarmente adatte ai discorsi rivolti alle assemblee popolari». Ancora oggi gli oratori se ne servono per chiarire un’analogia o strappare una risata. Nell’antica Grecia, le favole venivano impiegate anche in altri ambiti, per esempio i pedagoghi le trovavano utili per insegnare ai bambini a leggere e scrivere.
E secondo lo storico John Horgan: «Dal punto di vista politico, le favole sono comparse in un periodo della storia greca in cui il regime autoritario rendeva spesso pericoloso per l’oratore parlare liberamente e apertamente. [Erano] un mezzo attraverso il quale era possibile esprimere critiche al governo senza temere punizioni. In effetti, le storie assumevano la funzione di “codice”, il quale permetteva ai più deboli e agli impotenti di esprimere il loro dissenso verso i forti e i potenti».
E secondo lo storico John Horgan: «Dal punto di vista politico, le favole sono comparse in un periodo della storia greca in cui il regime autoritario rendeva spesso pericoloso per l’oratore parlare liberamente e apertamente. [Erano] un mezzo attraverso il quale era possibile esprimere critiche al governo senza temere punizioni. In effetti, le storie assumevano la funzione di “codice”, il quale permetteva ai più deboli e agli impotenti di esprimere il loro dissenso verso i forti e i potenti».
Ma chi era Esopo? Si conosce pochissimo della sua vita, se ne trovano alcuni cenni in epoche successiva in autori come Aristofane, Platone e Aristotele. Nel V secolo a.C. Erodoto lo descriveva come uno schiavo vissuto cento anni prima. Plutarco, nel I secolo d.C., citava Esopo come consigliere del famoso e ricco re Creso di Lidia. Altre fonti antiche lo identificano variamente come cittadino della Tracia, dell’Etiopia e di Samo.

La volpe e l’uva. Foto di Lin Tong da Pixabay. Pubblico Dominio
È anche possibile che Esopo sia una figura leggendaria, così come molti studiosi ritengono che sia Omero: non una persona realmente esistita, ma un nome della tradizione popolare a cui semplicemente sono state attribuite le favole. Lo studioso britannico Martin Litchfield West ha scritto: «Il nome di Esopo è conosciuto quanto qualsiasi altro nome tramandato dall’antichità greco-romana, (tuttavia) non è affatto certo che sia mai esistito storicamente. … Nella seconda metà del V secolo [a.C.] appare qualcosa di simile a una leggenda coerente su Esopo, e Samo sembra essere la sua patria».
Aristotele riteneva che fosse nato intorno al 620 a.C., e lo cita nella Retorica in merito a un discorso pubblico che il favolista pronunciò in difesa di un demagogo di Samo. Si diceva che fosse deforme e brutto, nato schiavo ma liberato dal suo padrone grazie alla sua erudizione e al suo ingegno. Lo storico greco Erodoto riporta che a Delfi, intorno al 564 a.C., sarebbe stato condannato a morte con una falsa accusa e gettato da una rupe da una folla inferocita, e che a questo atto seguì una pestilenza, quale punizione divina.
Tornando ai giorni nostri, sono sempre meno oggi le famiglie in cui sono presenti più generazioni, dove i nonni o altri parenti aiutano i bambini a crescere, trasmettendo loro la propria saggezza. L’arrivo della televisione ha ridotto il tempo dedicato di solito a parlare con i propri figli, e può essere difficile anche solo riuscire a distogliere l’attenzione degli adolescenti dai cellulari. Questi sviluppi sociali hanno reso più difficile per ogni generazione trasmettere alla successiva le proprie conoscenze, i propri valori etici e le lezioni apprese con fatica.
Le favole di Esopo possono aiutare genitori e insegnanti a colmare questo divario, sono un tesoro di saggezza ancestrale, presentata in modo semplice in storie tanto divertenti quanto istruttive. Ecco un’altra favola, meno conosciuta, Il gatto e le galline:
Un gatto, avendo sentito dire che in una fattoria alcune galline erano malate, si travestì da medico, prese con sé una borsa piene di strumenti utili alla medicina e andò a visitarle. Fermatosi davanti alla fattoria, chiese loro come stavano e se poteva curarle. E quelle risposero: «Staremo bene, quando te ne sarai andato di qui».
Morale: le persone assennate sanno riconoscere gli inganni dei malvagi, per quanto questi fingano di essere buoni. È una lezione di grande valore, oggi come 2.500 anni fa.
Articoli attuali dell'autore
06 settembre 2025
Le favole di Esopo sono antiche perle di arguzia e saggezza
16 agosto 2025
Beethoven e la libertà
09 giugno 2025
La storia del "mago” Harry Houdini
02 giugno 2025
Rosa Ponselle, la "Enrico Caruso” americana