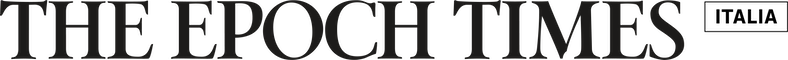COMMENTI
Il ruolo dell’America nella Terza guerra mondiale

La portaerei classe Nimitz USS George Washington esce dalla base navale di Norfolk, Virginia
Photo: foto: © Mc3 Maxwell Orlosky/Planetpix/Planet Pix via ZUMA Press Wire via Ansa
Negli ultimi giorni aerei russi hanno violato lo spazio aereo di Polonia e Romania per mettere alla prova la determinazione della Nato, mentre lo scenario internazionale si avvicina a un possibile conflitto in Asia — uno scontro che potrebbe essere ben più grave della guerra in Ucraina — dove la vera capacità di deterrenza e la fermezza restano, in larga parte, carenti.
Per comprendere meglio, occorre fare un passo indietro. Il 3 settembre Pechino ha messo in scena una spettacolare parata militare, sfoggiando un intero arsenale di armi di grande potenza. Molti giornalisti ne sono rimasti impressionati, mentre alcuni analisti di orientamento rinunciatario hanno suggerito politiche di appeasement sul modello di Chamberlain. Altri, in particolare osservatori della Cina, hanno tentato di interpretare la disposizione dei vertici del Partito comunista cinese sulla tribuna di piazza Tienanmen, nella speranza di cogliere indizi sulle lotte di potere a Zhongnanhai.
Ciò che spesso sfugge nelle analisi di quell’evento è che esso rappresenta la manifestazione delle modalità di finanziamento e di sostegno a un nuovo tipo di conflitto quasi mondiale. L’attuale guerra tra Russia e Ucraina ne è un esempio; un’eventuale invasione di Taiwan da parte di Pechino sarebbe un altro.
Ciò che spesso sfugge nelle analisi di quell’evento è che esso rappresenta la manifestazione delle modalità di finanziamento e di sostegno a un nuovo tipo di conflitto quasi mondiale. L’attuale guerra tra Russia e Ucraina ne è un esempio; un’eventuale invasione di Taiwan da parte di Pechino sarebbe un altro.
Le immagini diffuse dall’agenzia Xinhua, con Xi Jinping, Vladimir Putin e Kim Jong Un fianco a fianco in un gesto di solidarietà, vanno lette come la risposta calcolata al nuovo modello tripartito ideato dall’Occidente per sostenere militarmente l’Ucraina. Tale modello prevede che Kiev individui le proprie necessità in materia di armamenti, che i Paesi europei ne finanzino l’acquisto e che gli Stati Uniti li producano e consegnino.
L’evento di Pechino ha invece mostrato un modello parallelo: Mosca richiede materiale bellico, inclusi soldati, e Cina e Corea del Nord lo forniscono in cambio di energia russa a basso costo, con l’India e qualche altro Paese come partecipanti marginali. Pur essendo i combattimenti circoscritti a Russia e Ucraina, il finanziamento coinvolge un più largo fronte di Stati avversari. Questa simmetria coalizionale nel meccanismo di sostegno può protrarre a tempo indeterminato un conflitto sanguinoso che, lasciati soli, Russia e Ucraina non sarebbero in grado di mantenere.
Un modo per fermare la guerra è spezzare questa simmetria. È esattamente ciò che sembra perseguire il presidente statunitense Donald Trump con i suoi «dazi secondari». Il 6 agosto ha raddoppiato al 50 per cento il dazio di riferimento sull’India, colpevole di acquistare petrolio russo a basso prezzo. I primi effetti si vedono: in agosto Nuova Delhi avrebbe comprato molto meno greggio russo. Non a caso il primo ministro indiano Narendra Modi, presente al vertice dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai a Tianjin tra il 31 agosto e il 1° settembre, ha poi scelto con discrezione di non partecipare alla parata militare del 3 settembre.
Ora Trump pressa l’Europa affinché metta fine con urgenza a ogni residua dipendenza energetica da Mosca e si unisca a lui in un’azione analoga contro Pechino, proponendo dazi aggiuntivi fino al 100 per cento nei confronti della Cina per l’acquisto di petrolio russo. La dirigenza dell’Ue non ha ancora aderito pienamente, ma ha avanzato l’ipotesi di anticipare dal 2027 al 2026 — o persino prima — la cessazione di ogni importazione energetica dalla Russia.
Tuttavia, anche se la guerra in Ucraina dovesse concludersi con un passo indietro da parte di Putin, il mondo non potrebbe sentirsi al sicuro: Xi nutre tutte le intenzioni di proseguire con un «secondo capitolo». L’interesse principale di Pechino nell’aiutare Mosca risiede nella prospettiva di un sostegno reciproco qualora la Cina decidesse di invadere Taiwan. Ma che aspetto avrebbe una guerra Cina–Taiwan?
La guerra russo–ucraina è già, di fatto, un conflitto quasi-mondiale: i combattimenti sono circoscritti, ma coinvolgono circa cinquanta Paesi in quattro continenti con ruoli diversi. Una guerra Cina–Taiwan resterebbe geograficamente limitata allo Stretto di Taiwan e alle aree circostanti; tuttavia, il peso strategico dell’isola è immensamente superiore a quello dell’Ucraina. Taiwan eccelle nella produzione di microelettronica e detiene quasi il monopolio mondiale nei server per data center basati sull’intelligenza artificiale, oltre al 90 per cento del mercato mondiale dei microchip di alta gamma: la sua sopravvivenza come Stato indipendente è quindi molto più cruciale per l’economia mondiale rispetto a un importante esportatore di grano come l’Ucraina. Un’invasione di Taiwan si tradurrebbe in un conflitto di intensità ben maggiore, coinvolgendo subito tutte le principali economie industrializzate che dipendono dalle esportazioni tecnologiche dell’isola.
La stima del costo economico totale della guerra Russia–Ucraina, giunta al terzo anno, si aggira intorno al 3,5 per cento del Pil mondiale, ossia circa 3.500 miliardi di dollari. Un conflitto su vasta scala fra Cina e Taiwan potrebbe superare di oltre tre volte tale cifra, arrivando a un impressionante totale di 10 mila miliardi di dollari, secondo Bloomberg Economics.
A differenza del ruolo attuale nella guerra in Ucraina — caratterizzato da mediazione e coinvolgimento indiretto — gli Stati Uniti non avrebbero scelta: dovrebbero assumere un ruolo di primo piano nei combattimenti. Il Giappone sarebbe altresì costretto a intervenire attivamente, per vicinanza geografica e obblighi di trattato. Uno scenario del genere si avvicinerebbe pericolosamente a una vera guerra mondiale.
A differenza del ruolo attuale nella guerra in Ucraina — caratterizzato da mediazione e coinvolgimento indiretto — gli Stati Uniti non avrebbero scelta: dovrebbero assumere un ruolo di primo piano nei combattimenti. Il Giappone sarebbe altresì costretto a intervenire attivamente, per vicinanza geografica e obblighi di trattato. Uno scenario del genere si avvicinerebbe pericolosamente a una vera guerra mondiale.
Consapevoli di tale minaccia, gli Stati Uniti potrebbero già essere all’opera per rafforzare la propria posizione. Nel disegno di legge di stanziamento per la Difesa dell’anno fiscale 2026, il Senato ha previsto 1 miliardo e mezzo di dollari per l’Indo-Pacific Security Initiative, mentre la Camera ne destina 500 milioni attraverso la Taiwan Security Cooperation Initiative. Una volta armonizzate le due versioni, il testo sarà pronto per la firma del presidente.
Inoltre, nella settimana precedente alla parata del 3 settembre, alti funzionari della difesa di Taiwan e degli Stati Uniti si sono incontrati in Alaska. L’episodio, apparentemente di basso profilo, è trapelato alla stampa il 4 settembre e subito confermato da un funzionario statunitense: una sequenza calcolata e premeditata quale risposta americana all’evento di Pechino. Ma sarà davvero in grado Trump di dissuadere la Cina? Secondo l’analisi, sì, a condizione che riesca a far combaciare tre elementi della sua strategia generale.
In primo luogo, deve rafforzare l’Europa, incoraggiandola a ridurre l’ingente spesa sociale per destinare più risorse alla difesa. La stessa logica vale per Giappone, Corea del Sud, Taiwan e Australia, che devono essere saldamente allineati lungo la Prima Catena Insulare. Dietro questi due pilastri geopolitici vi deve essere però un’America radicalmente rigenerata, che purtroppo ha visto la propria forza logorata da decenni di degrado socio-economico. Trump vi sta lavorando attraverso una profonda riforma delle istituzioni e delle politiche nazionali in materia di cultura, istruzione, industria, commercio e difesa: l’essenza stessa del movimento Maga.
Come una bestia gravemente ferita che concentra il sangue verso il cuore per preservare le ultime energie vitali, gli Stati Uniti, nel processo di ricostruzione interna, possono sembrare isolazionisti agli occhi di chi, per decenni, ha beneficiato dell’apertura economica e della protezione militare garantita dalla “Pax Americana”. Sarebbe, questa, una grave incomprensione della visione di Trump, che molti Paesi — amici e nemici allo stesso modo — rischiano di compiere.
Description here (double click to change it)
Articoli attuali dell'autore
07 ottobre 2025
Il ruolo dell’America nella Terza guerra mondiale
20 febbraio 2025
Perché la Germania teme tanto le richieste di Trump per la Nato?