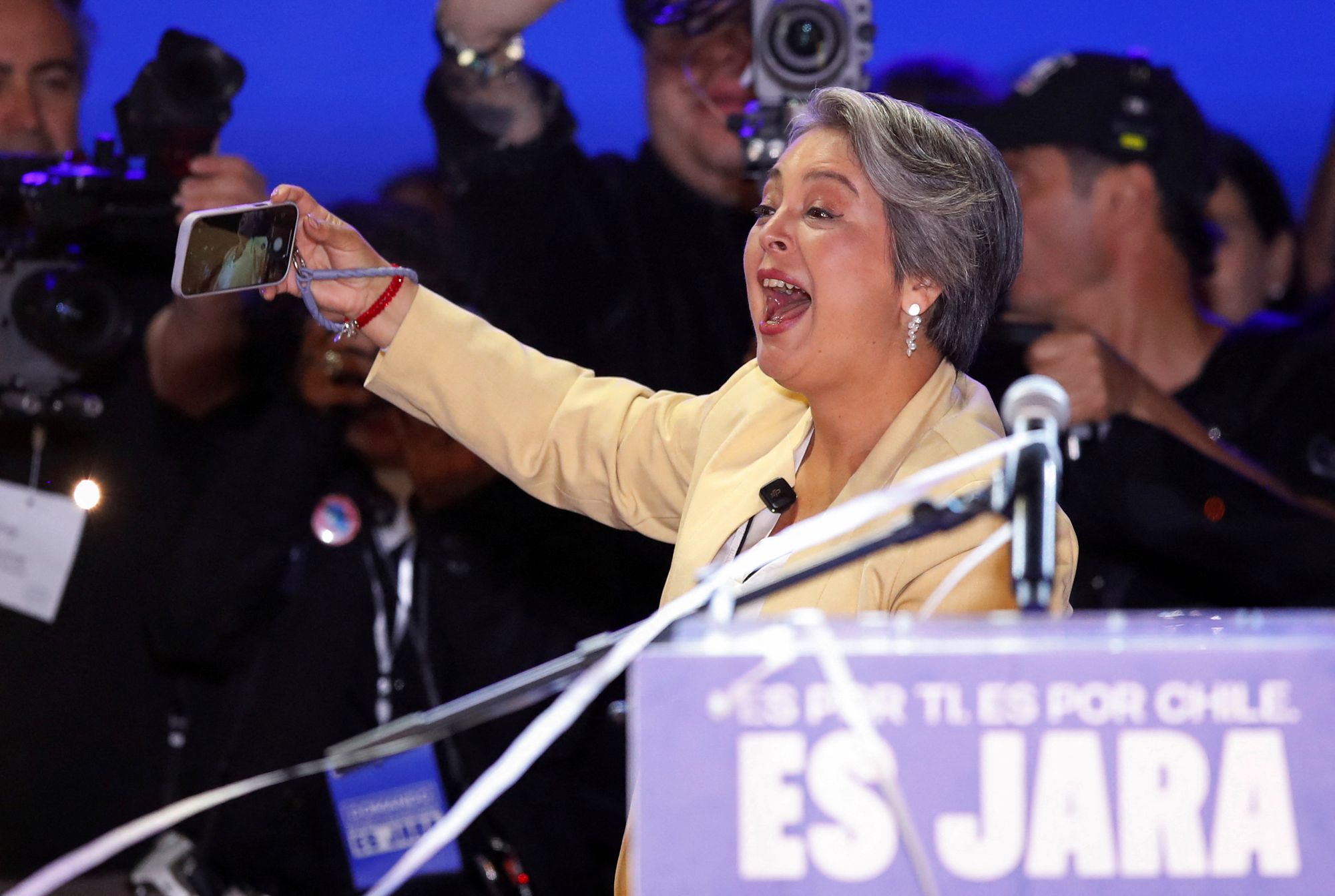Trent’anni fa, dal primo al 21 novembre 1995, gli accordi di Dayton mettevano fine a oltre tre anni di guerra civile in Bosnia-Erzegovina, che allora era parte della Jugoslavia. Una guerra che era costata la vita a centomila persone. L’intesa preservava l’unità formale dello Stato dividendolo però in due: la Repubblica Serba di Bosnia e la Federazione di Bosnia ed Erzegovina, abitata da popolazioni croato-musulmane.
L’accordo di Dayton – sottoscritto il 21 novembre 1995 – veniva stipulato quattro mesi dopo la strage di Srebrenica, in cui fino a ottomila civili bosgnacchi erano stati massacrati dalle forze serbo-bosniache. L’intesa era “presenziata” — ma non garantita — da Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania e Russia. Due anni più tardi, l’Alto rappresentante di Sarajevo diventava un plenipotenziario, quasi un monarca assoluto: gli venivano conferiti i cosiddetti “poteri di Bonn”, che gli consentivano di rimuovere politici regolarmente eletti, legiferare, riformare la magistratura e perfino annullare decisioni della Corte costituzionale.
Il prossimo 23 novembre, la Repubblica Serba di Bosnia terrà le elezioni presidenziali per scegliere il successore di Milorad Dodik, alleato di Mosca, destituito in seguito all’intervento dell’Ufficio dell’Alto rappresentante delle Nazioni Unite, un organismo controllato dai Paesi membri dell’Unione europea e della Nato.
Questo angolo di Europa conserva oggi un’importanza strategica assoluta: la Croazia, membro dell’Unione europea, confina con la Bosnia-Erzegovina e con la Serbia, e il suo confine è spesso sfruttato dalle reti di traffico di esseri umani dirette verso l’Europa occidentale.
Il 22 ottobre il governo britannico ha imposto sanzioni a due organizzazioni di trafficanti basate in Kosovo e in Croazia. In un comunicato ufficiale, il ministero degli Esteri inglese ha dichiarato che l’organizzazione croata «forniva falsi passaporti croati a bande balcaniche per agevolarne l’ingresso nei Paesi europei».
Christian Schmidt, alto rappresentante per la Bosnia-Erzegovina ed ex ministro del governo tedesco, nominato dall’Unione europea nel 2021, è entrato più volte in rotta di collisione con il presidente Dodik, deciso a staccare la Repubblica Serba di Bosnia per unirla alla vicina Serbia. Eletto presidente nel novembre 2022, Dodik ha incontrato più volte Vladimir Putin, ricevendone il costante appoggio anche in seno al Consiglio di Sicurezza dell’Onu.
Nel febbraio scorso, un tribunale di Sarajevo ha condannato Dodik a un anno di carcere e a sei anni di ineleggibilità per aver ignorato le decisioni dell’Alto rappresentante. Il Cremlino ha definito la condanna «un atto di natura chiaramente politica» minacciando «conseguenze molto negative» per i Balcani.
Il 6 agosto 2025, dopo aver rifiutato di ottemperare alla sentenza confermata in appello, Dodik è stato rimosso dall’incarico; la pena è poi stata commutata in una multa.
Aleksandar Grbic, fondatore e direttore della rivista della Repubblica Serba di Bosnia Indikt, parlando con Epoch Times Usa, ha definito la destituzione di Dodik «un atto antidemocratico» aggiungendo che «nessuna decisione di un “Alto Rappresentante” può essere considerata democratica, perché è una carica non legittimata da alcun voto. Per definizione – osserva il giornalista – è un’istituzione antidemocratica». Grbic accusa poi l’Unione europea e la Nato di aver mantenuto, negli ultimi trent’anni, un atteggiamento di pregiudizio nei confronti dei serbi, e sostiene che le decisioni dell’Ohr siano «sempre avvenute a spese del popolo serbo».
In un’intervista concessa al Sunday Times il 25 ottobre, l’alto rappresentante per la Bosnia-Erzegovina Christian Schmidt ha dichiarato: «Il mio mandato consiste nel difendere gli accordi di Dayton, e io lo prendo estremamente sul serio». Schmidt ha poi accusato Dodik di essere «una pedina» o una «marionetta» nelle mani di Putin.
Alla radice del conflitto dell’ex Jugoslavia resta il fattore religioso: i serbi di Bosnia sono in massima parte cristiani ortodossi, i croati cattolici e i bosgnacchi musulmani. La Russia post-sovietica, tecnicamente “ortodossa”, si considera da sempre la protettrice dei serbi. Un ruolo che rivendica fin dal 1914, quando l’attentato di Sarajevo – in cui Gavrilo Princip (un serbo di Bosnia) assassinò l’arciduca erede al trono d’Austria-Ungheria Francesco Ferdinando e la moglie Sofia – fu il casus belli che provocò lo scoppio della Prima guerra mondiale.
Denis Dzidic, direttore editoriale della rete Balkan Investigative Reporting Network di Bosnia ed Erzegovina, finanziata da diversi governi europei, ha definito esatta la valutazione di Schmidt su Dodik: «È direttamente influenzato dal Cremlino. Molte delle sue mosse, in particolare quelle destabilizzanti, nascono dalla consapevolezza di avere Mosca che gli copre le spalle».
L’8 gennaio 2025, in uno degli ultimi atti del suo mandato, Joe Biden ha emanato un ordine esecutivo volto a fermare «i tentativi di minacciare la sovranità e l’integrità territoriale delle nazioni dei Balcani occidentali». Pochi giorni dopo, il ministero del Tesoro americano ha imposto sanzioni a diversi alleati di Dodik, accusati di comportamento destabilizzante e di complicità finanziaria. Il 17 ottobre successivo, l’amministrazione Trump ha revocato le misure restrittive per quattro di loro — Danijel Dragicevic, Jelena Pajic Bastinac, Dijana Milankovic e Goran Rakovic — e il 29 ottobre anche per lo stesso Dodik, senza fornire spiegazioni.
Secondo Ron Slye, docente di diritto all’Università di Seattle, Putin considera l’ex Jugoslavia d’interesse strategico per «sbilanciare e destabilizzare l’Occidente e l’Europa». Oggi come trent’anni fa, dice il professor Slye, oggi si fronteggiano due visioni del mondo: da un lato, quella di uno Stato etnicamente “puro”, dall’altro quella di una società multiculturale e aperta all’immigrazione: «Tra i serbi di Bosnia esistono opinioni diverse: alcuni vorrebbero entrare nella “Grande Serbia”, altri preferirebbero mantenere un’identità autonoma».
Durante una visita a Sarajevo, nel marzo scorso, il Segretario generale della Nato, Mark Rutte, ha ribadito: «A trent’anni dagli accordi di Dayton, posso assicurare che la Nato resta pienamente impegnata nella stabilità della regione». E senza citare esplicitamente la Russia, ha aggiunto: «L’intera area trarrà beneficio da un autentico impegno verso la riconciliazione e la pace. Questo è il messaggio che rivolgo a tutti gli attori della regione».
Nel frattempo, l’Unione europea ha aperto colloqui di adesione con Albania, Montenegro e Serbia e, nel dicembre 2023, il Consiglio europeo ha deciso che potrà avviare negoziati anche con la Bosnia-Erzegovina, «una volta raggiunto il necessario livello di conformità ai criteri di adesione».
Secondo Dzidic, «Mosca considera ormai l’Ue alla stessa stregua della Nato, ossia come un avversario» e l’obiettivo russo è mantenere i Balcani «frammentati, instabili, carichi di tensioni etniche» insomma «una bomba a orologeria» nel cuore dell’Europa.