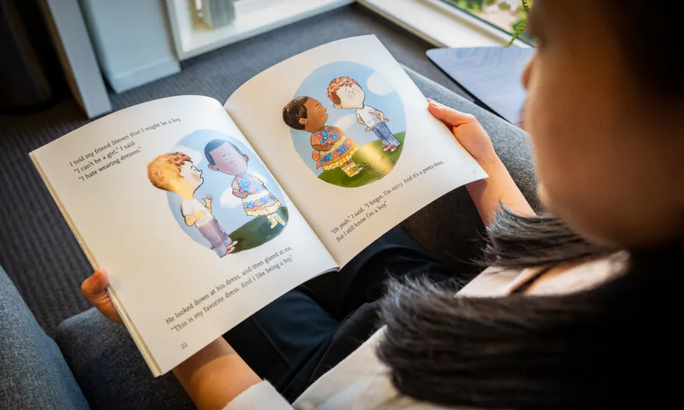La cataratta, principale causa di cecità a livello mondiale, affligge circa 6 milioni e 500 mila italiani sopra i 40 anni, colpendo uno o entrambi gli occhi. Oltre il 60% della popolazione italiana, raggiunti i 70 anni, sviluppa questa patologia, caratterizzata da un graduale offuscamento del cristallino, la lente naturale dell’occhio. Questo fenomeno, simile a guardare attraverso una finestra sempre più appannata, impedisce alla luce di raggiungere la retina, compromettendo la nitidezza della visione. La chirurgia rappresenta il trattamento più efficace, ma alcune scelte di vita possono rallentarne l’evoluzione.
L’opacità del cristallino si manifesta quando le proteine si aggregano, creando una barriera indolore che impedisce alla luce di raggiungere la retina. Questo processo, spesso legato all’invecchiamento a partire dai 40 anni, provoca una progressiva perdita della vista e può alterare la percezione dei colori, con il cristallino che tende a ingiallirsi o scurirsi. Tra le cause, l’invecchiamento è predominante, ma giocano un ruolo anche fattori genetici, con cataratte congenite legate a disturbi come la sindrome di Down o trasmesse ereditariamente in circa un quarto dei casi. Lo stress ossidativo, indotto da raggi ultravioletti o radiazioni, danneggia il cristallino, mentre traumi oculari, come colpi o lesioni penetranti, sono la principale causa di cataratte monolaterali nei giovani adulti. Trattamenti oncologici, come radioterapia e chemioterapia, possono favorire il disturbo, così come patologie come diabete, uveite cronica, glaucoma acuto, miopia elevata o infezioni da Hiv.
Diversi fattori accrescono il rischio di sviluppare questa patologia oculare. Il consumo eccessivo di alcol, specie se prolungato, aumenta la necessità di interventi chirurgici, mentre il fumo di sigaretta moltiplica le probabilità rispetto ai non fumatori. Una dieta ricca di sale, l’esposizione a microonde e carenze di antiossidanti, come vitamine C ed E, sono ulteriori elementi di rischio. L’uso prolungato di glucocorticoidi, l’ipertensione e l’obesità, che alimenta l’infiammazione sistemica, accelerano il processo. In gravidanza, infezioni materne come rosolia o malnutrizione possono provocare cataratte congenite nel feto. L’esposizione a sostanze chimiche, come cadmio o piombo, aggrava ulteriormente la situazione.
I primi segnali della cataratta, che si sviluppa lentamente, spesso passano inosservati finché non limitano le attività quotidiane. I colori perdono vivacità, compaiono aloni intorno alle luci, aumenta il bisogno di illuminazione intensa per leggere e si fatica a distinguere tra blu scuro e nero. Con il progredire della patologia, la visione appare velata, senza miglioramento sbattendo le palpebre e si riduce la capacità di vedere al buio. Possono manifestarsi immagini doppie, un aumento della miopia o, in rari casi, un’area bianca visibile nell’occhio. Talvolta, si verifica il fenomeno della visione ravvicinata temporaneamente migliorata. Altri sintomi includono difficoltà a cogliere dettagli fini, compromissione della visione centrale e sensibilità alla luce intensa.
La diagnosi, fondamentale per intervenire tempestivamente, richiede un esame oculistico completo. Il test dell’acuità visiva misura la nitidezza della vista, mentre quello del campo visivo rileva eventuali punti ciechi. La rifrazione valuta la necessità di correzioni visive e il test della pressione intraoculare esclude il rischio di glaucoma. L’esame con lampada a fessura consente di osservare cornea, cristallino e retina. Test specifici, come quelli per l’abbagliamento o la sensibilità al contrasto, chiariscono l’impatto della patologia sulla vita quotidiana. Gli over 60 dovrebbero sottoporsi a controlli con dilatazione della pupilla ogni uno o due anni.
Se non trattata, la cataratta può causare complicanze gravi, come il glaucoma facolitico, dovuto a un aumento della pressione oculare, o la sublussazione del cristallino. Il glaucoma secondario rischia di danneggiare il nervo ottico, mentre la cecità rappresenta l’esito più estremo, con un impatto significativo sulla qualità della vita, aumentando il rischio di cadute, depressione e declino cognitivo.
Nelle fasi iniziali, la patologia può essere monitorata senza interventi immediati, adottando accorgimenti come maggiore illuminazione, occhiali anti-abbagliamento o lenti d’ingrandimento. La chirurgia, efficace nel 90% dei casi, è ambulatoriale, rapida e con minimi disagi. La facoemulsificazione, che utilizza ultrasuoni per frammentare il cristallino, è la tecnica più comune, seguita dall’inserimento di una lente intraoculare. Tecniche avanzate, come la chirurgia laser a femtosecondi, garantiscono maggiore precisione.
Per rallentare la progressione, una dieta ricca di antiossidanti, come luteina e zeaxantina, presenti in cavolo e tuorli d’uovo, supporta la salute oculare, mentre alimenti processati e sale eccessivo la compromettono. Esercizi specifici, come quelli proposti dallo specialista cinese Kuo-Pin Wu, combinano tecniche tradizionali con massaggi agli agopunti. Le strategie di prevenzione includono occhiali protettivi contro raggi Uva e Uvb, il mantenimento di un peso sano, l’astensione da fumo e alcol e un’attività fisica regolare.
Le informazioni e le opinioni contenute in questo articolo non costituiscono parere medico. Si consiglia di confrontarsi sul tema col proprio medico curante e/o con specialisti qualificati.