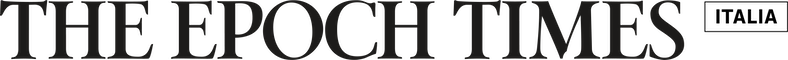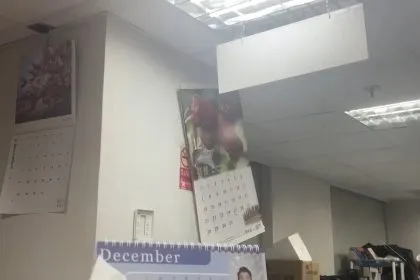Romeo e Giulietta ovvero quando il rancore distrugge le cose buone

Frederic Leighton, Riconciliazione tra Montecchi e Capuleti sui corpi senza vita di Romeo e Giulietta. Collezione privata. Immagine ritagliata. Pubblico dominio.
| Aggiornato alle del
Condividi articolo
Tempo di lettura: 13 Min.
Tempo di lettura: 13 Min.
Romeo e Giulietta, talvolta descritta come una tragedia immatura di William Shakespeare, è in realtà un’opera saggia e complessa sull’immaturità: immaturità sia per il bellissimo inizio di un amore giovanile, sia nel senso più deleterio, per la tragica faida familiare, dominata dalla rabbia e alimentata dall’odio. Pur essendo una bella storia di vero amore, c’è molto di più: mette in guardia dall’odio, che ha l’oscuro potere di corrompere cose buone come l’amore e la virtù. Riconoscere questo aiuta il pubblico a lasciarsi alle spalle i propri risentimenti.
Nel Prologo, il Bardo introduce a una comprensione autentica dell’opera:
Nella bella Verona
dove è ambientata la nostra scena,
una nuova contesa oppone,
per un antico rancore,
due famiglie di pari nobiltà
per cui sangue civile macchia mani civili.
Dai fatali lombi di questi due nemici
ha preso vita una coppia di amanti
da maligna sfortuna contrastati,
le cui sorte pietosa e turbinosa pone
con la loro morte
una pietra sull’odio dei parenti.
Del loro amore la pietosa storia
porrà fine la morte
e dell’ostinata rabbia dei loro genitori,
che nulla, se non la fine dei loro figli, poteva placare:
questo è quanto su questo palcoscenico
per due ore rappresenteremo
e se con pazienti orecchie ascolterete,
ciò che qui mancherà, la nostra fatica cercherà di rimediare.
dove è ambientata la nostra scena,
una nuova contesa oppone,
per un antico rancore,
due famiglie di pari nobiltà
per cui sangue civile macchia mani civili.
Dai fatali lombi di questi due nemici
ha preso vita una coppia di amanti
da maligna sfortuna contrastati,
le cui sorte pietosa e turbinosa pone
con la loro morte
una pietra sull’odio dei parenti.
Del loro amore la pietosa storia
porrà fine la morte
e dell’ostinata rabbia dei loro genitori,
che nulla, se non la fine dei loro figli, poteva placare:
questo è quanto su questo palcoscenico
per due ore rappresenteremo
e se con pazienti orecchie ascolterete,
ciò che qui mancherà, la nostra fatica cercherà di rimediare.
Brevemente, nel primo atto dell’opera, ambientata nella città medievale di Verona, Romeo Montecchi e Giulietta Capuleti, discendenti di due nobili famiglie acerrime nemiche, si incontrano e si innamorano. Nel secondo atto si dichiarano il loro reciproco amore, nel terzo si sposano segretamente; ma dopo le nozze Romeo, per vendicare l’uccisione dell’amico Mercuzio, uccide in duello un parente di Giulietta. Romeo viene condannato all’esilio e la famiglia di Giulietta vuole costringerla a sposare un altro uomo. Lorenzo, frate francescano e mediatore della coppia, tenta di organizzare il ricongiungimento delle famiglie ma infine, dopo una serie di eventi sfortunati, in preda alla disperazione Romeo e Giulietta si suicidano.

Nella cella di Frate Lorenzo, illustrazione tratta da Tales from Shakespeare di Charles & Mary Lamb. Pubblico dominio.
Sebbene il linguaggio amoroso dei due giovani riesca a emozionare ancora oggi, alcuni critici lo leggono come una totale condanna dell’amore, considerandolo precipitoso, imprudente e distruttivo. Una visione comprensibile, dopotutto, Romeo e Giulietta rifiutano di confidarsi o di chiedere consiglio ai genitori e agli amici, senza contare che Giulietta ha appena tredici anni! Da questo punto di vista, la loro tragedia sembra causata dall’avventatezza. Inoltre, parlano del loro amore come di “idolatria”, e nel secondo atto si dice che sono «entrambi stregati dal fascino dell’aspetto fisico». E nonostante professino di essere cristiani, sembra che la loro attrazione sia basata esclusivamente sull’aspetto fisico, che abbiano sostituito il Dio del cristianesimo con la lussuria e che quindi il loro suicidio sia la prova più evidente di questa passione mal riposta. Sicuramente una tale passione non può essere amore nel senso più vero del termine, se ignora l’amore dovuto ai genitori, alla famiglia, agli amici e a Dio. Le parole di frate Lorenzo: «questi piaceri violenti hanno fini violenti», sono completamente e unicamente applicabili alla coppia.
Questa interpretazione, tuttavia, ignora il contesto dell’opera: nel prologo è chiaro che Shakespeare non sia preoccupato tanto della lussuria o dell’idolatria, quanto della faida aspra e implacabile tra le due famiglie, la «rabbia dei genitori». Questo scenario mette sotto una luce diversa le parole di frate Lorenzo sulla fine violenta: l’amore di Romeo e Giulietta è intrappolato dall’odio più antico e brutale tra le due famiglie, anticipato nella scena iniziale, in cui i servitori di entrambe le parti si provocano a vicenda e che termina con i capifamiglia Montecchi e Capuleti che si trascinano nella mischia, assetati di sangue. Lo scontro viene interrotto solo grazie all’intervento di Escalus, principe di Verona.
Tutte le persone su cui Romeo e Giulietta dovrebbero poter contare per ricevere consigli e guida sono impulsive e violente: il nobile Capuleti cerca di combinare un matrimonio per la figlia nel giro di pochi giorni, mentre la balia consiglia a Giulietta di agire contro la sua coscienza e di violare i voti matrimoniali sposando l’uomo scelto da suo padre. Anche frate Lorenzo, unico confidente di Romeo e Giulietta, agisce in modo affrettato e imprudente fin dall’inizio, benedicendo il matrimonio dei giovani non perché sia una cosa buona in sé, ma come espediente per risolvere la faida tra i Montecchi e i Capuleti. Infine, nel valutare l’amore tra Romeo e Giulietta, è importante considerare che in genere l’amore giovanile è estremamente appassionato, nasce dall’aspetto fisico e può portare a una sorta di idolatria in cui la persona amata diventa il mondo intero. Il vero amore potrebbe iniziare così, ma si rivela tuttavia un inizio pericoloso.
Secondo la tradizione cristiana che ispira quest’opera, le cose belle avvicinano gli uomini e le donne a Dio, fonte di tutta la bellezza. C’è il rischio però che gli amanti si distraggano, fermandosi al livello dell’amore per le cose inferiori. In questa tradizione, l’amore deve essere guidato per diventare amore in senso più vero, cioè non basato sul piacere emotivo e fisico quanto sul sacrificio di sé. Ma qui, il giovane sentimento di Romeo e Giulietta, quello che più necessita del sostegno di familiari e amici, può contare solo su sé stessi.
Shakespeare presenta questo amore giovanile come problematico, ma è evidente che ne mostra anche gli aspetti positivi. Alcune delle frasi più belle dell’opera provengono dalla coppia: Romeo, al primo incontro con Giulietta esclama «Oh, lei insegna alle torce a bruciare luminose!»; e Giulietta, nonostante la sua passione innocente e incontrollata, rappresenta nella storia il personaggio con più senso morale. È vero, disobbedisce al padre rifiutandosi di sposare un altro uomo, ma sa che ubbidendo commetterebbe adulterio. E se qualcuno dubitasse che Giulietta pensi solo alla passione per Romeo, in realtà quello che la spinge a rifiutare di commettere un peccato contro Dio e contro Romeo è proprio evitare l’adulterio: «Mio marito è sulla Terra, la mia fede è in cielo».

Philip H. Calderon, Giulietta, 1888. Molti critici considerano Giulietta Capuleti il personaggio più morale dell’Opera. Pubblico dominio.
Il fatto che Romeo e Giulietta non siano né lodati né biasimati chiaramente (dall’autore) ha sconcertato i critici, portando a una terza valutazione: che l’opera sia immatura, non all’altezza delle altre tragedie di Shakespeare, come Macbeth o Amleto. Questa era l’opinione di molti critici del XVIII e XIX secolo e di non pochi studiosi moderni. Essi contestano non solo l’apparente ambiguità morale, ma anche lo sviluppo dei personaggi. Nelle altre tragedie di Shakespeare i protagonisti, pur incontrando una triste fine, sviluppano anche una comprensione e una consapevolezza più chiare di se stessi e del loro mondo, mentre Romeo e Giulietta diventano sempre più ossessionati l’uno dall’altra e precipitano verso una morte inutile.
Questa interpretazione è troppo limitata: le forze che realmente muovono l’azione della tragedia sono le famiglie in guerra, non Romeo e Giulietta. I Capuleti e i Montecchi hanno collettivamente fallito nel guidare l’amore innocente che era sbocciato tra loro, ed è la mancanza di guida per questa passione, non la passione stessa, che costituisce il problema. Il modo stesso in cui Shakespeare descrive questa faida è un profondo monito contro il rancore e la vendetta.

Frank Bernard Dicksee, Romeo e Giulietta, particolare, 1884. Southampton City Art Gallery. Pubblico dominio.
Per sua natura, il rancore si nasconde per ingannare e, alla fine, spinge chi lo nutre a prendere decisioni avventate. Sebbene sia la faida il filo conduttore dell’opera, essa è profondamente nascosta. Poche scene mostrano le due famiglie in un reale confronto. In apparenza, i principali rappresentanti dei Montecchi e dei Capuleti passano più tempo a manifestare timori per i propri figli che a soffermarsi sul loro reciproco odio. Eppure dietro il testo si nasconde questo odio e motiva tutti i tristi eventi dell’opera: l’incapacità di Romeo e Giulietta di confidarsi con i loro amici e familiari, la sete di sangue di Tebaldo e l’inganno e la fretta che si manifestano ripetutamente.
Il rancore inganna anche chi lo nutre che spesso pensa di tenerlo sotto controllo. Tuttavia, non è la ragione a governare la rabbia e l’odio, ma sono loro che in modo subdolo prevalgono sulla ragione. All’inizio del primo atto, i signori Capuleti e Montecchi concordano una parvenza di tregua ma Tebaldo, parente dei Capuleti, alimenta il fuoco della faida uccidendo un amico di Romeo che a sua volta uccide Tebaldo. Il gesto di Tebaldo è reso possibile perché i Montecchi e i Capuleti hanno assecondato il loro rancore fingendo solamente di lasciarlo andare, mentre nei loro cuori aveva già prevalso.
Inoltre, chi prova risentimento è in preda all’impazienza e i genitori e la Balia di Giulietta sono precipitosi, così come i loro servitori e quelli dei Montecchi. Quanto avviene nelle strade di Verona rivela cosa succede a chi cede al risentimento invece di controllarlo. Il rancore consuma silenziosamente il cuore, anche mentre le persone che lo nutrono mangiano, bevono, mostrano buone intenzioni e fanno buoni progetti. Quando prende il sopravvento e tiranneggia la ragione, l’odio è come Tebaldo: un subordinato che forza la mano del suo superiore.
Infine, il rancore induce chi lo cova a distruggere inconsapevolmente ciò che ama di più. Come recita il prologo, ci vogliono le morti di Romeo e Giulietta per «seppellire la faida dei loro genitori». È il messaggio per i lettori e gli spettatori di questa opera: perdonare e seppellire il proprio risentimento prima che distrugga se stessi e chi si ama.
Articoli attuali dell'autore