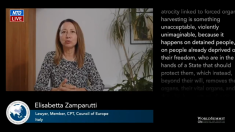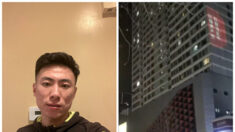Secondo un recente studio, i grandi marchi della moda preferiscono non divulgare informazioni sulle loro catene di approvvigionamento.
Il Fashion Transparency Index ha analizzato cento brand con ricavi superiori a 1,2 miliardi di dollari e li ha classificati in base al livello di trasparenza sulle loro catene di approvvigionamento.
Dior, Heilan Home e S.Oliver occupano le ultime posizioni poiché sono tra le aziende che hanno scelto di non divulgare alcun dato. Adidas, Reebok, Marks & Spencer e H&M hanno ottenuto invece i risultati migliori, in parte perché hanno pubblicato la lista delle fabbriche dove vengono realizzati i loro capi.
Degni di nota sono gli sforzi continui per cambiare in meglio l’industria da parte degli appassionati di moda e degli attivisti della Fashion Revolution, un movimento globale che richiede maggiore trasparenza nel settore della moda. Ma secondo Carry Somers, co-fondatrice della Fashion Revolution, anche i marchi che hanno ottenuto i migliori risultati hanno ancora molto da fare in termini di trasparenza dei processi produttivi. Ad esempio, Adidas e Reebok, i primi classificati, hanno ottenuto solo il 49 per cento dei punti totalizzabili; inoltre, solo poche aziende hanno reso nota la propria politica di minimi salariali nei confronti dei lavoratori della catena di approvvigionamento. Nessun marchio ha invece pubblicato i dati sui fornitori di materie prime.
I risultati del Transparency Index sono stati pubblicati il 24 aprile, il primo giorno della Fashion Revolution Week, in memoria della tragedia avvenuta quattro anni prima in Bangladesh, quando la fabbrica Rana Plaza era crollata uccidendo 1.138 persone e ferendone oltre 2.500. In seguito alla tragedia, Somers e la designer di moda etica Orsola de Castro hanno fondato nel 2014 Fashion Revolution, che inaspettatamente si è trasformata in un movimento globale.
Lo scorso anno oltre 70 mila persone da tutto il mondo hanno chiesto ai diversi brand #whomademyclothes (chi ha fabbricato i miei vestiti?), e sono stati pubblicati oltre 156 milioni di post con questo hashtag.
«Dopo che la fabbrica Rana Plaza è crollata abbiamo pensato che tutte quelle vite non potevano essere morte in vano. Molti avevano avvisato da diversi anni che poteva accadere un disastro di queste proporzioni a causa delle catene di approvvigionamento troppo opache» spiega la Somers, «non potevamo permettere che venisse semplicemente archiviato come l’ennesimo disastro avvenuto in nome della moda».
I dati mostrano che la provenienza di molti degli abiti in vendita nei negozi di lusso è ancora un mistero. Dalla semina e coltivazione, alla sgranatura, filatura, tessitura, rifinitura fino a chi cuce gli indumenti, per Carrie Somers tutti questi esperti artigiani che fanno parte del processo produttivo, meritano un equo riconoscimento: «Solo dando loro visibilità possiamo far si che non vengano più sfruttati».
Inoltre, la corruzione nell’industria della moda non è un segreto. Secondo il Forum dei Diritti Umani Uzbeko-Tedesco, circa un milione di cittadini uzbechi sono stati costretti dal proprio governo a raccogliere cotone nel 2015; dal momento che gran parte di questo cotone finisce in Bangladesh, è difficile stabilire quali vestiti contengano cotone uzbeko: «Il cotone uzbeco viene regolarmente etichettato come ‘Made in Bangladesh’. Se non c’è trasparenza sulle materie prime, il consumatore non ha modo di sapere se dietro il capo di cotone che acquista ci sia una qualche forma di schiavitù o meno» conclude la Somers, «Penso che le materie prime siano una questione molto seria e che anche con i migliori sforzi delle grandi aziende sarà necessario molto tempo per riuscire a tracciarle completamente».
Articolo in inglese: Global Fashion Companies Criticised Over Lack of Transparency
Traduzione di Marco d’Ippolito