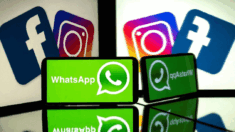Quando si parla di ‘made in China’ sempre più persone pensano a prodotti a basso costo di scarsa qualità e contraffatti. Ma non tutti sanno che molto probabilmente la maggior parte di questi viene prodotta in condizioni di sfruttamento della manodopera.
Perché il ‘made in China’ è così diffuso nel mondo? Costa poco, e ciò attira i consumatori occidentali. Ma come mai il prezzo del ‘made in China’ è così basso?
Principalmente i motivi sono due. Da un lato il Partito Comunista Cinese mantiene il Paese attraente per gli investimenti esteri tenendo basso il costo del lavoro e controllando la libertà della Federazione dei Sindacati di tutta la Cina, l’unico sindacato in Cina. Inoltre 60 anni di terrore hanno intimorito la mentalità dei Cinesi, che tendono a lavorare oltremisura al fine di accumulare e risparmiare.
L’altro motivo, celato e oscuro, è che la Cina, nonostante le convenzioni stipulate con l’Organizzazione mondiale del Commercio, sfrutta il lavoro di un enorme numero di persone. Alcune persone sono rinchiuse in strutture detentive e campi di lavoro forzato, altre lavorano in fabbriche legalmente riconosciute ma sono vittima di grave sfruttamento.
LAVORO IN SCHIAVITÙ
Nelle strutture detentive e nei campi di lavoro forzato si trovano non solo criminali, ma anche persone scomode al regime cinese, come dissidenti politici e prigionieri di coscienza, tra cui i Cristiani, gli Uiguri, i Tibetani e i praticanti del Falun Gong. Qui si lavora anche 12-16 ore al giorno, senza il minimo rispetto dei diritti umani e se i prigionieri non rispettano i vincoli di produzione imposti dalle guardie carcerarie, vengono puniti con meno cibo, rispetto già a quel poco che hanno.
Queste prigioni lager esistevano già al tempo di Mao, ma data la politica fortemente chiusa al mercato estero, non esportavano merci. Hanno cominciato a esportare all’estero «quando negli anni 80 Deng Xiaoping ha aperto la Cina al mercato», precisa Francesca Romana Poleggi, membro del CdA della Laogai Research Foundation (Lrf) italiana.
In queste strutture si producono tutte le tipologie di merce: dall’elettronica ai prodotti per la casa, dai mobili ai materiali dell’industria pesante, sino ad arrivare ai comuni giocattoli e alle scarpe. Insomma un ampio giro d’affari per lo Stato cinese. Al punto che nel 2008 almeno 314 imprese commerciali della Cina erano collegate a questi campi di lavoro, secondo quanto riporta il rapporto Laogai forced labor camps Listed in dun & bradstreet databases, pubblicato dalla Lrf.
Nella rapporto I laogai e le importazioni agro-alimentari dalla Cina, la Lrf stimava nel 2008 l’esistenza di almeno mille laogai (nome che definisce i campi di detenzione). Un altro rapporto della Lrf denuncia che 110 laogai pubblicizzano le loro attività su siti commerciali internazionali, e 33 di questi lo fanno in italiano.
Un esempio è China Commodity Net (ccne.mofcom.gov.cn), sito web sponsorizzato dallo Stato, da cui è possibile comprare un’enorme quantità di prodotti fabbricati nei campi di lavoro. Sul sito si legge che è un servizio per la cooperazione e il commercio tra la Cina e le piccole e medie imprese straniere, tutto apparentemente nella norma. Una volta entrati nella home page, si possono scegliere 39 generi merceologici, e dopo aver creato un profilo, si può acquistare di tutto.
Il sito contiene un motore di ricerca interno che permette di selezionare la provincia cinese da cui provengono i prodotti e il nome della compagnia. Ad esempio, se si digita ‘phone’ e si seleziona la provincia dell’Anhui, si trovano oltre 4.000 prodotti, tra cui telefoni fissi, cellulari, auricolari, batterie e gadget e accessori relativi a questo settore. Se si digita invece ‘computer’ nella provincia di Pechino, compaiono oltre 2.000 risultati.
Amnesty International ha dichiarato nel 2013 sul suo rapporto China: “Changing the soup but not the medicine?” : Abolishing re-education through labour in China [Cambiare la minestra, ma non la medicina?: Abolire i campi di lavoro in Cina, ndt] che secondo i dati apparsi sul sito della giustizia cinese, i campi di lavoro alla fine del 2012 erano 351. Attualmente non è possibile controllare il dato, poichè la pagina web non esiste.
Il 15 novembre 2013 il regime cinese ha confermato che stava chiudendo i campi di lavoro, ma la realtà è un’altra. I campi sono stati rinominati come prigioni o centri di trattamento delle dipendenze, ma all’interno delle stesse mura gli abusi continuano.
Secondo Amnesty International il nome è cambiato, ma la popolazione detenuta all’interno di queste strutture rimane la stessa e in media, un terzo della popolazione in queste strutture è composta da praticanti del Falun Gong, una disciplina meditativa perseguitata in Cina fin dal 1999. In alcuni campi il 100 per cento dei detenuti sono praticanti del Falun Gong.
FABBRICHE CHE SFRUTTANO LA MANODOPERA
L’altro caso è costituito da fabbriche legalmente riconosciute in cui si lavora fino a 16 ore al giorno, dove si sfruttano i minori e i lavoratori dormono accatastati in brandine, le ferie sono inesistenti e gli straordinari sono la regola. «Ci sono almeno circa 700 imprese in Cina, ti sfruttano quasi come nei campi di lavoro, con dei salari di 30-50 dollari al mese. Dormi dove lavori, un po’ come da noi a Prato, Empoli e Firenze», ha detto Toni Brandi, presidente della Lrf.
A causa delle richieste di lavoro troppo elevate in queste fabbriche ci sono stati molti suicidi. Il caso più celebre è quello della Foxconn, produttore taiwanese di componenti per la Apple. Nel 2010 in uno stabilimento nella città cinese di Taiyuan, 14 persone si suicidarono gettandosi da un tetto e due anni più tardi avvenne una mega rissa tra la polizia e i lavoratori a causa delle cattive condizioni di lavoro e igieniche.
«L’intero dormitorio puzzava come spazzatura quando sono entrato. Puzzava di un mix di rifiuti marci e sudore sporco», aveva detto un giornalista dello Shangai Evening Post quando si era recato nel settembre 2012 presso lo stabilimento Taiyuan. «Fuori da ogni stanza c’erano mucchi di spazzatura. Quando ho aperto il mio armadio, è uscita una moltitudine di scarafaggi. Le lenzuola che vengono distribuite a ogni nuovo lavoratore sono piene [di sporco] e cenere».
ASSENZA DI LEGGE
Attualmente esiste un vuoto a livello normativo che non tutela né i consumatori né le vittime, ma almeno i tentativi da parte dell’Italia di esporre e contrastare il fenomeno ci sono stati.
Nel 2011 la Lrf ha proposto una legge (n° 3887) contro la produzione, l’importazione e il commercio di merci prodotte in schiavitù. Per garantire la sicurezza ai consumatori, la legge prevedeva di istituire un albo nazionale a cui le aziende potevano aderire per garantire che i prodotti non venivano prodotti con la manodopera forzata.
«Presentai questa proposta di legge su cui ci lavorai quasi nove mesi e fu firmata da oltre cento parlamentari in modo trasversale. Dopo quattro anni e una quantità di firme così autorevoli non successe nulla e mi occupai di altro», ha detto Alessandro Pagano, deputato dell’area popolare (Ncd-Udc) e primo firmatario di questa proposta di legge. «Ma il 14 luglio 2015 ho ripresentato la proposta di legge, a firma unica».
Secondo Pagano, se la legge verrà esaminata e poi approvata, potrà avere un impatto positivo nel mondo del lavoro in Cina e nel resto del mondo. «Migliorando la situazione là, la situazione migliora dappertutto. Quindi anche noi avremo il beneficio, ma non devo pensare di fare questa legge perché sono egoista e per avere una competitività maggiore, perché altrimenti significa che mi metto allo stesso piano, in questo modo porterei la legge su un piano mercantilistico», spiega Pagano.
Anche la Lrf ha cercato di tenere una mostra su questo fenomeno al Parlamento Europeo. «C’eravamo dati da fare affinché i pannelli espositivi fossero comprensibili da tutti. Quando tutto era pronto, l’Unione Europea l’ha censurata. L’hanno censurata perché era troppo d’impatto. Con un bel giro di parole non hanno voluto che al Parlamento Europeo fosse esposta questa mostra sui laogai», ha spiegato la Poleggi, riferendosi a un tentativo avvenuto circa cinque anni fa.
«Nell’Unione Europea c’è poca intenzione di contrastare questo fenomeno, anche a livello italiano la nostra legge è rimasta lì dov’era. Fare affare con la Cina è sempre molto, troppo comodo», ha concluso la Poleggi. Le aziende che comprano in Cina forse sono inconsapevoli o superficiali sul fenomeno, oppure è anche lecito pensare che potrebbero esserne complici.
Immagine di un codice a barre fornito da Shutterstock