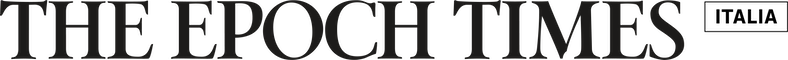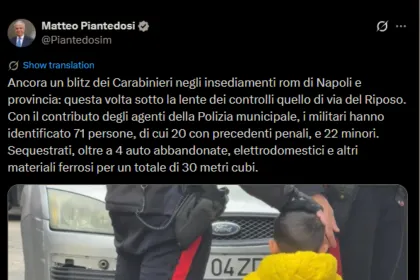COMMENTI
Il silenzio del regime cinese sull’economia vale più di mille parole

Foto: REUTERS/Florence Lo/File photo
| Aggiornato alle
Condividi articolo
Tempo di lettura: 9 Min.
Tempo di lettura: 9 Min.
Esiste una sorta di patto non scritto tra i governi di tutto il mondo per condividere i dati economici sulle condizioni prevalenti. Dietro questa prassi si cela una competizione amichevole per stabilire quale nazione vanti il sistema più solido, un esercizio che sostiene i mercati finanziari, indirizzando le risorse dove sono più necessarie.
A volte, i dati risultano imprecisi. In altri casi, si rivelano falsi. Tuttavia, in linea di massima, si tenta almeno di rispettare questa consuetudine, per consentire ad agenzie e investitori di formulare valutazioni più accurate, aiutando i politici e i banchieri centrali a prendere decisioni più consapevoli. Una regola generale sembra guidare questo processo: maggiore è la trasparenza dei governi nel condividere i dati raccolti, e più grande è la libertà di interpretarli in modi diversi, tanto più credibili risultano le informazioni. È anche probabile che i Paesi che condividono e discutono apertamente i propri numeri abbiano di che vantarsi.
Raramente una nazione sceglie di tacere completamente sul mercato, spegnendo gli interruttori e lasciando le sale dati al buio. Quando questo accade, è un segnale inquietante. Ed è esattamente quello che sta avvenendo in Cina. Negli ultimi mesi, e in alcuni casi da diversi anni, Pechino ha smesso di pubblicare una serie di informazioni fondamentali: vendite di terreni, investimenti esteri, tassi di disoccupazione, fiducia delle imprese, numero di investitori nei mercati finanziari, valutazioni immobiliari, vendite al dettaglio e persino dati vitali sulle cremazioni, lasciando le autorità sanitarie senza indicazioni su cosa stia accadendo. Gli uffici preposti hanno semplicemente cessato di comunicare.
Con la seconda economia più grande al mondo e crescenti dubbi sulla sua salute economica, questa opacità è motivo di seria preoccupazione. Da tempo, gli osservatori più attenti nutrono perplessità sui dati relativi al Pil cinese. Si sostiene che l’economia sia cresciuta del 5% lo scorso anno, un risultato che, se confermato, sarebbe straordinario. Tuttavia, cifre di questa portata sono suscettibili di manipolazioni in ogni Paese, ma soprattutto in uno come la Cina, dove la promessa di una crescita economica eccezionale è centrale per il potere e il controllo permanente del Partito comunista cinese. Alcuni esperti ritengono che i tassi di crescita siano stati gonfiati di 2 o 3 punti percentuali.
Lo scorso dicembre, l’economista cinese Gao Shanwen, figura di spicco nel panorama accademico, si trovava a Washington per un incontro tra i colleghi del Peterson Institute, un autorevole gruppo di esperti. Durante un panel, forse spinto dal desiderio di esprimere liberamente la propria opinione, ha dichiarato senza mezzi termini che nessuno conosce con certezza i reali tassi di crescita della Cina. Secondo le sue stime, potrebbero attestarsi intorno al 2%. «Negli ultimi due o tre anni», ha affermato, «il Pil reale medio potrebbe essere stato di circa il 2%, anche se i dati ufficiali parlano di quasi il 5%».
Nessuno nella sala ha battuto ciglio. Gao Shanwen sembrava aver momentaneamente dimenticato di non essere un attore indipendente, privo della libertà di offrire valutazioni obiettive. La notizia delle sue parole, tuttavia, è arrivata immediatamente a Pechino. L’economista è stato prontamente richiamato all’ordine e ridotto al silenzio. Ha perso il suo incarico presso la società di intermediazione finanziaria in cui lavorava, i suoi commenti sono stati cancellati da tutti i siti accessibili in Cina e gli è stata revocata l’autorizzazione a parlare di questioni economiche. Nel frattempo, l’associazione cinese dei titoli ha imposto a chiunque discuta della salute economica del Paese di limitarsi a dichiarazioni positive.
Da quanto sopra, si deduce che i dati un tempo pubblicati regolarmente non raccontano una storia rosea. Tacitare gli economisti è una cosa, ma mettere a tacere i dati stessi non fa che alimentare l’allarme.
E l’allarme è scattato. Ora gli osservatori internazionali temono il peggio: una crisi immobiliare nascosta, un problema significativo di disoccupazione, un possibile crollo degli investimenti e gravi difficoltà finanziarie per il governo.
Per decenni, la Cina ha costruito un sistema stabile di crescita economica basato su cinque pilastri fondamentali:
- Produzione a basso costo per competere e, in ultima analisi, sostituire l’industria manifatturiera occidentale;
- Consumatori americani desiderosi di contrastare la stagnazione dei propri salari con prodotti e beni intermedi a prezzi accessibili;
- Crediti delle banche centrali per lo sviluppo aziendale, sostenuti da ingenti riserve di debito denominato in dollari;
- Una valuta nazionale scambiata a valori ben inferiori alla media ponderata del dollaro, la moneta di riserva mondiale, favorendo così le esportazioni rispetto alle importazioni;
- Investimenti infrastrutturali diretti e finanziati dallo Stato, calibrati in base agli obiettivi nazionali.
Non si è mai trattato del libero mercato che molti analisti, negli anni Novanta e oltre, immaginavano sarebbe diventato. Tuttavia, la Cina ha beneficiato di un contesto normativo flessibile, che ha ridotto i contenziosi legali che affliggono le economie occidentali, e di un approccio amministrativo tollerante verso le imprese, purché non minacciassero le priorità politiche.
Un elemento cruciale è stato il presupposto che il sistema commerciale internazionale non avrebbe mai messo in discussione dazi bassi e investimenti transfrontalieri. Questo assunto, però, è radicalmente cambiato. La prima amministrazione Trump, nel 2018, ha avviato un processo di revisione delle relazioni commerciali, portando a una documentata riduzione delle importazioni americane dalla Cina.
Due anni dopo, l’inizio della pandemia ha invertito questa tendenza, con gli Stati Uniti che hanno fatto affidamento sulla Cina per ingenti forniture di beni, come le mascherine, in gran parte importate. Cinque anni dopo, il secondo mandato di Trump ha segnato una svolta epocale, rompendo con ottant’anni di politica commerciale americana attraverso l’introduzione di dazi. L’obiettivo è riequilibrare i conti, rilanciare la produzione interna e generare entrate per ridurre la dipendenza da un’imposizione fiscale elevata.
Se e in che misura questo cambiamento avrà gli effetti sperati negli Stati Uniti è ancora da vedere. Tuttavia, è probabile che abbia già avuto un impatto significativo sulle prospettive economiche della Cina, mettendo in discussione l’idea, a lungo data per scontata, che gli Stati Uniti sarebbero rimasti per sempre il principale mercato di consumo per i prodotti cinesi.
Vale la pena soffermarsi sull’ironia di questa situazione. Per secoli, gli imprenditori hanno fantasticato sulle enormi potenzialità della Cina come mercato di consumo, immaginando prodotti e servizi da vendere. «Un paio di scarpe per ogni piede cinese», «il mercato cinese ci renderà ricchi», «un mercato di 400 milioni di clienti»: questi slogan hanno circolato per oltre un secolo.
Eppure, quando si è arrivati al dunque, l’imprevedibilità degli affari economici ha ribaltato le aspettative. Non è stata la Cina come consumatore, ma la Cina come produttore a dominare il panorama per decenni dopo la sua apertura. Solo ora, negli Stati Uniti, si sta prendendo piena consapevolezza delle implicazioni per l’industria manifatturiera americana.
Cosa fare, dunque? Una strada migliore rispetto al protezionismo sarebbe una deregulation su larga scala, un dollaro più forte sul mercato interno e più competitivo all’estero, e una riduzione dei costi per fare impresa attraverso un rinnovato spirito imprenditoriale americano. Questo cambiamento, in un modo o nell’altro, sarà necessario. I dazi da soli non possono arginare la marea.
Nel frattempo, la Cina si trova improvvisamente ad affrontare gravi sfide economiche, che potrebbero diventare così significative da minacciare persino la stabilità politica del Paese. Al momento, gli osservatori internazionali sono in gran parte all’oscuro della reale gravità della situazione. I dati, semplicemente, non ci sono.
Copyright Epoch Times
Articoli attuali dell'autore
22 luglio 2025
Gli obblighi vaccinali e il medico diventato eroe
19 giugno 2025
Il ritorno alle cose vere
15 giugno 2025
Elon Musk e il saper chiedere scusa
24 maggio 2025
Il senso del rating