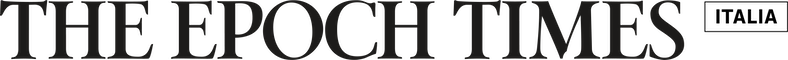COMMENTI
Il giorno in cui New York andò in default

Photo: Pixabay
| Aggiornato alle
Condividi articolo
Tempo di lettura: 10 Min.
Tempo di lettura: 10 Min.
Nel novembre 1974, il critico cinematografico del New York Times Vincent Canby scriveva che New York era diventata «una metafora di quelli che sembrano gli ultimi giorni della civiltà americana».
«È governata da sciocchi» diceva, «i suoi cittadini sono alla mercé dei criminali che, il più delle volte, sono protetti da un’empia alleanza tra difensori delle libertà civili e poliziotti corrotti. L’aria è irrespirabile. Il traffico è insostenibile. I servizi sono in declino e il morale è tale che ordinare una tazza di caffè può trasformarsi in una richiesta di un labbro gonfio». L’anno successivo, New York City rimaneva senza fondi.
«È governata da sciocchi» diceva, «i suoi cittadini sono alla mercé dei criminali che, il più delle volte, sono protetti da un’empia alleanza tra difensori delle libertà civili e poliziotti corrotti. L’aria è irrespirabile. Il traffico è insostenibile. I servizi sono in declino e il morale è tale che ordinare una tazza di caffè può trasformarsi in una richiesta di un labbro gonfio». L’anno successivo, New York City rimaneva senza fondi.
Il declino di New York avveniva in parallelo con le spese comunali che crescevano a dismisura. Dal 1965, il bilancio era più che triplicato, con le uscite che aumentavano in media del 12 per cento all’anno. Il ministro al Tesoro William E. Simon diceva: «dal 1963 al 1973, le spese municipali pro capite di altre grandi città statunitensi sono aumentate, in media, di 2,2 volte. Nello stesso periodo, quelle di New York sono cresciute di circa 3,5 volte, un tasso superiore del 50 per cento», di conseguenza, «la spesa pro capite di New York è oltre tre volte maggiore di qualsiasi città con popolazione superiore al milione di abitanti».
Il livello di spesa di New York per l’assistenza sociale (aiuti pubblici e Medicaid), l’istruzione superiore e gli ospedali era praticamente unico, come osservava l’autore Charles R. Morris: «Su base pro capite, solo Washington D.C., che funge anche da governo statale, supera il tasso di spesa di New York City in questi ambiti, e nessun altro ente si avvicina al livello newyorkese» con una spesa di 585 dollari pro capite a New York rispetto a 105 a Detroit, 234 a Los Angeles, 89 a Chicago e settantasei a Filadelfia.
Il livello di spesa di New York per l’assistenza sociale (aiuti pubblici e Medicaid), l’istruzione superiore e gli ospedali era praticamente unico, come osservava l’autore Charles R. Morris: «Su base pro capite, solo Washington D.C., che funge anche da governo statale, supera il tasso di spesa di New York City in questi ambiti, e nessun altro ente si avvicina al livello newyorkese» con una spesa di 585 dollari pro capite a New York rispetto a 105 a Detroit, 234 a Los Angeles, 89 a Chicago e settantasei a Filadelfia.
L’importo medio dei sussidi erogati ai beneficiari dell’Aid to dependent children – 351 dollari al mese – era il più alto degli Stati Uniti, con il secondo, terzo e quarto Stato in classifica che pagavano rispettivamente 340, 295 e 289 dollari. Un altro onere era rappresentato dal costo del personale. Sebbene i dipendenti comunali non fossero retribuiti in modo esagerato rispetto ad altre città, erano molto più numerosi. New York impiegava 49 persone ogni mille residenti. Nelle altre grandi città, la cifra oscillava tra 30 e 32 dipendenti ogni mille abitanti.
Oltre ai contributi federali e statali, il governo cittadino aveva solo due fonti di finanziamento per queste spese: tassazione e indebitamento. Quanto alla prima, c’era sempre meno da tassare: tra il 1966 e il 1973, come scrive l’autrice Kim Phillips-Fein, «la città ha aumentato più volte le imposte sul reddito, mentre le tasse sulla proprietà sono salite e quelle sulle imprese sono state estese a coprire una varietà di piccole aziende e società». Di conseguenza, le tasse di Gotham divennero molto più alte rispetto ad altre città statunitensi. Invece di pagare, molte imprese e individui se ne andarono semplicemente. Johnny Carson trasferì The Tonight Show in California nel 1972. Anche Pepsi e Shell partirono. «Parti del settore dell’abbigliamento, grandi panifici, trasformatori alimentari e birrifici lasciano la città» scriveva Simon «e entro il 1969 avevano portato via circa 140 mila posti di lavoro. La fuga accelera a un ritmo spaventoso: solo tra dicembre 1974 e dicembre 1975 sono scomparsi 133 mila posti di lavoro. Una stima prudente suggerisce che tra il 1970 e il 1977 sono svaniti circa 400 mila posti di lavoro». Tra il 1970 e il 1980, la popolazione della città diminuì del 10 per cento.
Era facile capire il motivo di tutto questo: mentre le tasse aumentavano, crescevano anche gli omicidi, del 248 per cento tra il 1960 e il 1973. «Nel 1975 – scriveva Morris – la città aveva il 41 per cento della popolazione dello Stato, ma il 68 per cento di beneficiari di assistenza. E con il 44 per cento del reddito personale dello Stato, doveva pagare il 73 per cento dei costi locali di welfare».
«Una “città” di imprese e contribuenti grande quanto San Francisco ha fatto le valigie e lasciato New York», scriveva il New York magazine nel 1976. «Abbiamo condotto un nobile esperimento di socialismo locale e ridistribuzione del reddito» diceva Ken Auletta, «uno dei chiari risultati del quale è stato ridistribuire gran parte della nostra base imponibile e molti posti di lavoro fuori dalla città». A causa della scomparsa della base imponibile, le entrate della città crescevano solo del 5 per cento all’anno.
«Una “città” di imprese e contribuenti grande quanto San Francisco ha fatto le valigie e lasciato New York», scriveva il New York magazine nel 1976. «Abbiamo condotto un nobile esperimento di socialismo locale e ridistribuzione del reddito» diceva Ken Auletta, «uno dei chiari risultati del quale è stato ridistribuire gran parte della nostra base imponibile e molti posti di lavoro fuori dalla città». A causa della scomparsa della base imponibile, le entrate della città crescevano solo del 5 per cento all’anno.
Il comune di New York copriva il deficit indebitandosi a breve termine per finanziare la spesa corrente. «All’inizio degli anni Settanta, New York rappresentava regolarmente circa il 25 per cento di tutti i titoli municipali a breve termine in circolazione nel Paese» scriveva Morris, ed entro la fine del 1974 vendeva 600 milioni di dollari di obbligazioni ogni mese, molte garantite da entrate previste che non si materializzarono. In novembre, il debito a breve termine in circolazione ammontava a 5 miliardi e 300 milioni di dollari, in aumento di 1 miliardo e 900 milioni da giugno, un incremento quadruplo in quattro anni. Entro la fine del 1974, New York rappresentava oltre il 40 per cento dell’indebitamento a breve termine esente da tasse negli Stati Uniti.
«Nel 1974, il debito pro capite a New York City era di 1.767 dollari – diceva Daniel Patrick Moynihan – mentre a Chicago era di 427». Questa valanga di obbligazioni fece scendere i prezzi e salire i rendimenti. In novembre, i titoli cittadini, che a fine anni Sessanta rendevano il 4 per cento, arrivavano all’8,34 per cento. In dicembre, il tasso salì al 9,48 per cento. In febbraio, emerse che la città non aveva le entrate fiscali legalmente richieste per garantire un’emissione obbligazionaria di 260 milioni di dollari, e Bankers Trust e Chase Manhattan si rifiutarono di sottoscriverla. A marzo, la città offrì 912 milioni di dollari di titoli a breve termine esenti da tasse fino all’8 per cento, un rendimento effettivo tre volte maggiore, su base equivalente fiscale, rispetto a quello disponibile in una banca di risparmio. Settimane dopo, più della metà rimaneva invenduta. Era il crack di New York City. Con fondi federali e statali e attraverso una Municipal Assistance Corporation, la città rifinanziò i debiti e il governo statale assunse il controllo delle sue finanze. Era il default.
Molti dei problemi che New York aveva negli anni Sessanta e Settanta non erano unici. Città in tutta l’America lottavano con la suburbanizzazione e i tagli agli aiuti federali, e quelle del Nordest con la migrazione di imprese verso il Sud e l’Ovest. Ma solo New York fallì. Come scrive Phillips-Fein nel suo libro finalista al Pulitzer Fear City: New York’s Fiscal Crisis and the Rise of Austerity Politics, «la grandezza del settore pubblico della città portò [quei problemi, ndr] in primo piano». Il fallimento di New York potrebbe non sembrare offrire lezioni oltre il livello statale. Il governo federale può stampare tutto il denaro necessario per finanziare le sue operazioni: non deve mai andare in default nel senso di “non poter pagare”, perché fa “default” in modo soft pagando con denaro che vale meno.
In ultima analisi, tuttavia, default è default. Il fallimento di New York rappresenta un esempio di cosa accade quando un governo spende persistentemente più di quanto incassa e si riduce a essere alla mercé dei mercati obbligazionari per tirare avanti. I newyorkesi ora vedono la ripetizione di quello che Morris chiamava «l’esperimento liberal» del 1960-75, che Auletta definiva il «nobile esperimento di socialismo locale e ridistribuzione del reddito»: esempi che farebbero bene a ricordare. Come tutti noi.
Copyright Epoch Times
Articoli attuali dell'autore
24 agosto 2025
Il giorno in cui New York andò in default