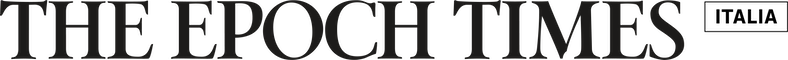I bambini pagano la tecnologia a caro prezzo

Photo: Pixabay
| Aggiornato alle del
Condividi articolo
Tempo di lettura: 6 Min.
Tempo di lettura: 6 Min.
Viviamo in un’epoca in cui gli schermi – smartphone, tablet, televisori – sono diventati onnipresenti, compagni inseparabili anche per i più piccoli, spesso fin dai primi mesi di vita. Ma dietro a una manciata di minuti di tranquillità per i genitori, si nasconde un costo elevatissimo per lo sviluppo cerebrale dei nostri figli. E la ricerca scientifica suggerisce che i rischi siano tutt’altro che marginali.
Il cervello di un bambino, soprattutto nei primi anni, è un cantiere in piena attività. Come spiega il dottor Ernesto Lira de la Rosa, psicologo clinico, la straordinaria plasticità cerebrale dei primi cinque anni dipende da stimoli autentici: il gioco, il dialogo, il contatto umano. Quando uno schermo sostituisce lo sguardo di un genitore o l’interazione con un coetaneo, si interrompe quel delicato ecosistema relazionale che nutre intelligenza ed emozioni. E i segnali non tardano a emergere: difficoltà di attenzione, ritardi nell’apprendimento, aumento dell’irrequietezza sono spesso i primi campanelli d’allarme di un “cervello in sofferenza”.
Tra i 6 e i 12 anni, l’ingresso nel mondo scolastico non è di per sé sufficiente a garantire un uso consapevole e appropriato della tecnologia. Social network e piattaforme video, se non controllati, espongono i bambini a cyberbullismo, contenuti violenti e alla pressione di un confronto costante con i pari, erodendo il tessuto delle amicizie reali. Il risultato è l’isolamento: bambini che preferiscono la solitudine di uno schermo alla complicità di un gioco all’aperto, un’autostima fragile, sedentarietà e un preoccupante aumento dell’obesità infantile.
Gli adolescenti, poi, sono ancor più vulnerabili: più aumenta il tempo passato online, più crescono ansia, frustrazione e vulnerabilità. Il bombardamento di immagini patinate, stili di vita “perfetti” e like come misura del valore personale finiscono per generare insicurezze profonde. È un circolo vizioso: più cercano conforto sugli schermi, più si allontanano da empatia, resilienza e autocontrollo, qualità indispensabili per affrontare la vita.
A livello neurologico, il quadro è altrettanto allarmante: l’uso intensivo di dispositivi digitali altera la corteccia prefrontale, responsabile di funzioni esecutive come pianificazione, attenzione e memoria, controllo inibitorio e regolazione delle emozioni. Il sistema nervoso, confuso e iperattivato dalla sovrastimolazione digitale, risponde con un rilascio eccessivo di dopamina e cortisolo – l’ormone dello stress – che innesca impulsività e compromette concentrazione e pazienza. In poche parole, il cervello viene spinto a “spegnere” le aree più evolute in favore di quelle più primitive. Ecco perché, spesso, spegnere un telefono può scatenare reazioni sproporzionate nei più giovani.
A tutto questo si aggiungono danni fisici: squilibri muscolari e posturali, affaticamento oculare, riduzione della vista, disturbi del sonno e, nei casi più gravi, sintomi simili all’Adhd, ovvero il disturbo dell’attenzione. La Commissione Lancet, composta da un team internazionale di esperti in ambito scientifico, medico e sanitario, ha concluso che quasi la metà della popolazione mondiale mostra segni di assuefazione tecnologica, mentre le dipendenze digitali sono ormai riconosciute ufficialmente come patologie dalla comunità scientifica internazionale.
Il quadro è a dir poco allarmante se si considera che oggi è sempre più comune vedere bambini di sei o sette anni con uno smartphone personale. Una normalità apparente che solleva interrogativi profondi sul ruolo educativo della famiglia e della scuola. Come sottolinea il professor Giuseppe Riva, esperto di neuropsicologia, la tecnologia non va demonizzata, ma richiede un uso consapevole e supervisionato. Le app educative, ad esempio, possono rappresentare un’opportunità di apprendimento se inserite in un contesto relazionale, controllato e limitato nel tempo.
Un passo importante in questa direzione è stato compiuto dal ministero dell’Istruzione italiano, che dall’anno scolastico 2024-2025 ha vietato l’uso di dispositivi elettronici personali in tutte le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado. Una misura che vuole proteggere la scuola come spazio di relazione, concentrazione e crescita reale, lontano dalle distrazioni digitali. Ma non basta. La vera sfida è culturale: famiglie, insegnanti e istituzioni devono collaborare per promuovere un’educazione digitale che rispetti le esigenze evolutive dei minori, favorendo esperienze reali e interazioni significative.
Non si può infine ignorare un’ultima, scomoda verità: le app sono progettate per creare dipendenza. I dati dei nostri figli alimentano algoritmi sempre più sofisticati, pensati per tenerli incollati agli schermi. Ogni click, ogni interazione, è moneta sonante per un sistema pubblicitario che trasforma il loro tempo in profitto. E la dipendenza non è un più un effetto collaterale, ma l’obiettivo.
È quindi necessario ridurre l’esposizione agli schermi, riscoprire il valore del tempo di qualità e costruire un rapporto sano con la tecnologia sono passi imprescindibili. Solo così si potrà garantire alle nuove generazioni uno sviluppo armonico, in un mondo dove la tecnologia sia al servizio dell’essere umano e non viceversa. Il futuro dei nostri figli dipende dalle scelte che facciamo oggi.