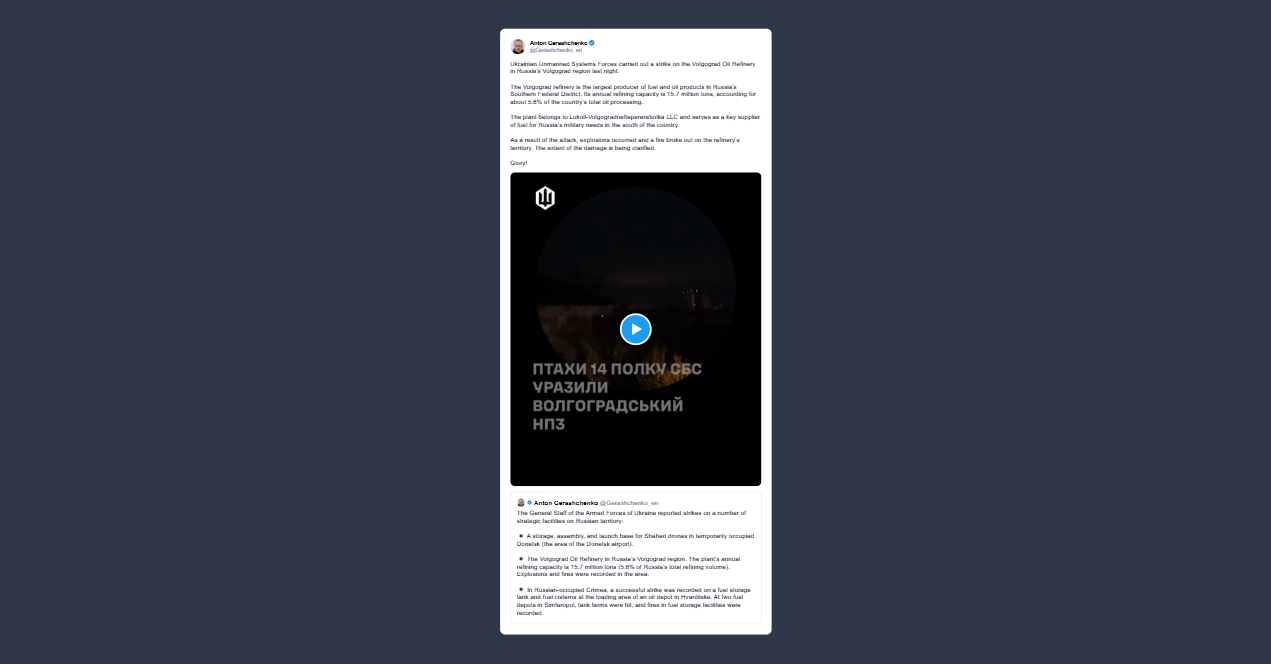Lo sfruttamento del monopolio delle terre rare si sta ritorcendo contro il regime cinese. La scarsità – causata deliberatamente per mettere in difficoltà i settori industriali civile e militare, statunitensi e di tutto l’Occidente – paradossalmente, negli Stati Uniti sta provocando l’espansione di questo settore cruciale. L’America e le nazioni alleate, stanno creando intere filiere produttive indipendenti dal controllo della Repubblica Popolare Cinese.
Il 31 ottobre il ministro del Tesoro Scott Bessent ha dichiarato al Financial Times che la minaccia di bloccare le esportazioni di terre rare è «un grave errore», aggiungendo che a breve il Partito comunista cinese si ritroverà con un’arma di ricatto spuntata. Bessent prevede che il vantaggio cinese in questo campo duri al massimo altri due anni, e che dal 2028 il mondo sarà quindi libero dal cappio cinese.
E sebbene vi siano opinioni differenti sulle tempistiche, l’opinione dominante è che usando il monopolio delle terre rare come arma di ricatto il Pcc si sia dato la zappa sui piedi. Kenneth Rogoff, già capo economista del Fondo monetario internazionale e oggi docente di economia internazionale a Harvard, ha infatti dichiarato a The Epoch Times Usa: «Posso garantirvi che la posizione di monopolio della Cina risulterà gravemente indebolita da questa scelta, perché col tempo gli altri Paesi troveranno fonti alternative».
Vincent Harris, professore di Ingegneria elettrica e informatica alla Northeastern University, ha commentato che, sebbene la strategia di Pechino appaia aggressiva, in realtà «è la Cina a trovarsi in una situazione rischiosa». Il regime comunista si è infatti imbarcato in una «partita di poker» che difficilmente vincerà, dice il professor Harris: «Pechino ha usato il monopolio delle terre rare come leva (o come un’arma) geopolitica per piegare gli altri imponendo limitazioni o restrizioni. Finora è riuscita a farlo con successo per una ventina d’anni, ma deve stare attenta: se tira troppo la corda, l’Unione europea o gli Stati Uniti finiranno per trovare soluzioni alternative ai magneti basati sulle terre rare, lasciando la Cina senza più quell’arma». E, evidentemente, la corda si è già spezzata: Donald Trump è alquanto diverso da George W. Bush, da Obama e da Biden.
LA LEZIONE GIAPPONESE
Simili tattiche ricattatorie sono un classico del regime cinese. Nel settembre 2010, ad esempio, una nave da pesca cinese entrava in collisione con una motovedetta giapponese nei pressi delle isole Senkaku; Tokyo aveva arrestato il comandante del peschereccio e Pechino aveva reagito sospendendo temporaneamente le esportazioni di terre rare, mettendo in grossa difficoltà il settore automobilistico giapponese.
«I giapponesi giurarono di non ritrovarsi mai più in una simile posizione – spiega il professor Harris – Nel 2011 e nel 2012 presero misure drastiche per accumulare scorte di magneti in terre rare, proprio per evitare che Pechino potesse esercitare nuovamente quella pressione». Oltre all’accumulo di scorte e al riciclo, da allora il Giappone ha anche iniziato a investire in modo massiccio in attività minerarie lontane dalla sfera di influenza cinese, in particolare nella società australiana Lynas Rare Earths, oggi principale produttore non-cinese mondiale di terre rare, portando la propria dipendenza dalla Cina dal 90 al 60 per cento.
«Io credo che l’Unione europea e il settore automobilistico statunitense abbiano capito bene la lezione giapponese» dice il professor Harris, osservando che il passo naturale in simili casi è recidere il legame di dipendenza e divenire autonomi. E a quel punto, l’ex monopolista rimane con un pugno di mosche: perso il monopolio, si ritrova con un colossale eccesso di capacità produttiva inutile. Quando si mettono a confronto il libero mercato e il monopolio (che è connaturato al comunismo), il libero mercato vince sempre.
Una lezione che la dittatura comunista cinese evidentemente non è in grado di imparare. Il 9 ottobre scorso, infatti, il ministero del Commercio del regime di Pechino ha ordinato le più rigide restrizioni mai adottate sulle esportazioni di terre rare e magneti: gli esportatori cinesi, prima di vendere anche minime quantità all’America, sono obbligati a chiedere il permesso al regime. La Repubblica Popolare Cinese controlla circa il 70 per cento dell’estrazione, il 90 per cento della raffinazione e il 93 per cento della produzione mondiale di terre rare e magneti, per cui l’impatto sulla capacità produttiva americana è enorme.
In risposta, l’amministrazione Trump ha firmato nel giro di dieci giorni una raffica accordi di cooperazione mineraria con Australia, Giappone, Thailandia e Malesia.
IL VERO PREZZO DELLE TERRE RARE
Secondo gli esperti, Stati Uniti e alleati possiedono senz’altro le competenze necessarie per costruire velocemente proprie catene di approvvigionamento. Il vero ostacolo è la differenza di prezzo tra i prodotti occidentali e quelli cinesi: «Quando ci confrontiamo sul mercato libero, il nostro costo è fino a cento volte superiore a quello di una fabbrica di Baotou: è un dato di fatto» dice il professor Harris. Una differenza abissale, che deriva dagli elevati standard ambientali imposti dall’Agenzia per la protezione dell’ambiente statunitense, a fronte della politica cinese che, per conquistare il monopolio, ha sacrificato ambiente e salute pubblica.
E la vita degli operai cinesi. Perché il costo del lavoro in Cina è un terzo della media occidentale: nei principali Paesi europei e negli Stati Uniti il salario lordo minimo nel settore industriale è generalmente compreso tra i 2 mila e i 3.500 dollari. In Italia, un operaio metalmeccanico neoassunto è pagato con un minimo che varia dai 1.500 ai 1.700 euro.
In Cina, un operaio prende l’equivalente di cifre comprese tra i 650 e gli 850 dollari lordi al mese. Esclusi ovviamente le centinaia di migliaia (molto probabilmente due milioni) di operai ridotti in schiavitù nello Xinjiang, il cui “costo del lavoro” si riduce a qualche ciotola di riso e una branda in un dormitorio della fabbrica.
Facendo due calcoli, il professor Harris stima che i derivati dalle terre rare attualmente in uso, se venissero prodotti dalle aziende americane costerebbero dalle cento alle cinquecento volte in più dei corrispettivi cinesi.
Questo porta a due logiche considerazioni. La prima: considerato che circa la metà delle terre rare e dei magneti è impiegata per veicoli elettrici, pale eoliche, pannelli solari eccetera, la transizione verde è “pagata col sangue” degli operai cinesi (e dei minatori africani che estraggono le terre rare nelle miniere di proprietà cinese). La seconda: produrre in Occidente gli stessi volumi di “magneti” attualmente impiegati nella cosiddetta “transizione ecologica” determinerebbe un impatto spaventoso sull’economia.
Tradotto: la costosissima (per le casse pubbliche) “transizione verde” attualmente è resa possibile solo dal lavoro sottopagato o forzato della dittatura comunista cinese. Ma a condizioni di libero mercato sarebbe semplicemente impraticabile, anche lasciando in essere gli enormi sussidi pubblici che la tengono in piedi.
Due domande sorgono a questo punto spontanee: gli operai delle nuove filiere europee e americane delle terre rare, quanto verranno pagati? Se saranno pagati in modo equo (cosa probabile) sarà ancora possibile insistere nella “transizione ecologica” come la si intende oggi?