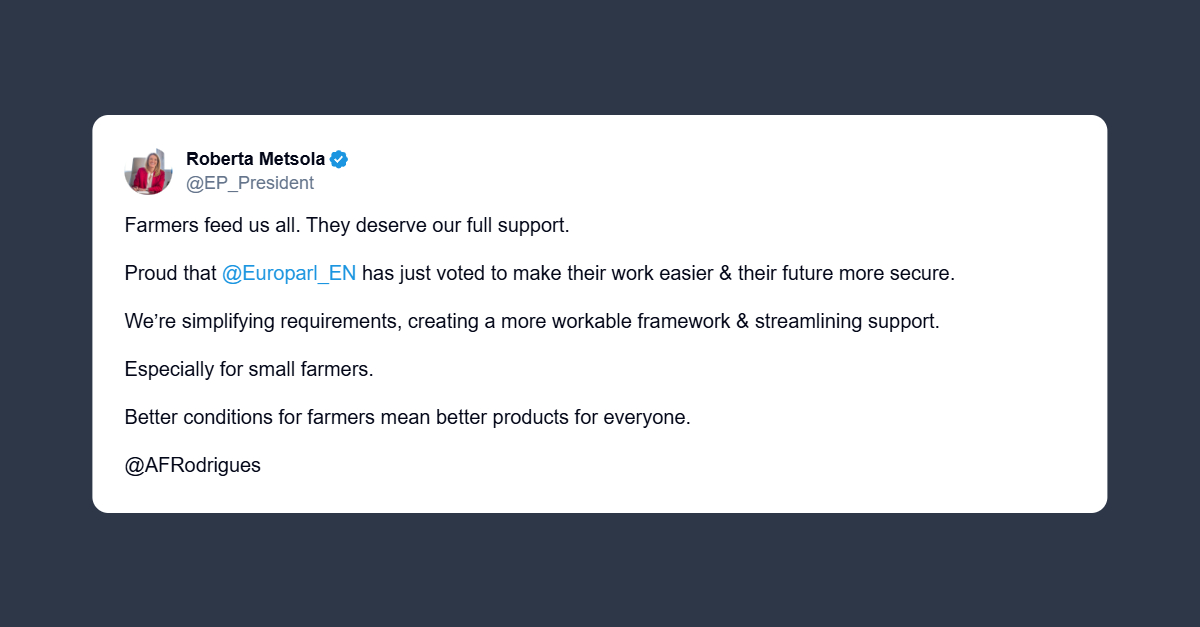La Cina ha nell’Iran il suo principale alleato in Medio Oriente in forza di un accordo strategico che prevede cooperazione economica e militare. Questa alleanza non è nata dal nulla. Le trattative sono iniziate dopo la salita al potere di Xi Jinping nel 2013, e hanno preso slancio con la sua visita in Iran nel 2016. Ma una componente qui è cruciale: Teheran fornisce armamenti alla Russia, a partire dai droni, mentre la Cina assorbe quasi tutte le esportazioni energetiche iraniane, fondamentali per sostenere la propria economia e il proprio apparato militare. Secondo alcune fonti, tra Cina e Iran operano voli cargo Boeing 747 che spengono i transponder all’ingresso nello spazio aereo iraniano per eludere il tracciamento civile, restando però visibili ai radar e ai caccia israeliani. Cosa trasportano? «La Cina sta inviando qualcosa che non vuole far sapere al mondo. Potrebbero essere munizioni, droni — meno probabile — o addirittura armi nucleari», ha dichiarato l’esperto di Cina Gordon Chang a Fox.
I 747 hanno una notevole capacità di carico, ma non sono adatti a trasporti militari roll-on/roll-off, a differenza dei C-17 e C-5 americani. Air China ne possiede una decina: velivoli obsoleti, destinati alla dismissione, ma ancora acquistabili a basso costo, il che rende incerta la loro effettiva disponibilità. In ogni caso, la capacità di trasporto strategico aereo della Cina resta limitata, con circa 80 Y-20 e una quarantina di IL-76 forniti dalla Russia nei primi anni Duemila.
L’Iran dipende in modo critico dai consumi cinesi. Secondo la società Kpler, circa il 90% delle esportazioni energetiche iraniane è diretto in Cina, in violazione delle sanzioni. Dal 2022, Pechino ha intensificato l’importazione illegale di petrolio iraniano, pagandolo in yuan e a prezzi stracciati. Senza queste entrate, l’economia iraniana — già in difficoltà — rischierebbe il collasso, mettendo in crisi il regime. Ma perché questo petrolio, se sanzionato, non viene fermato? La risposta sta nella differenza tra sanzioni e loro applicazione. La marina degli Stati Uniti potrebbe intercettare le “petroliere fantasma” iraniane negli Stretti di Hormuz o di Malacca, ma sarebbe troppo oneroso. Inoltre, molte sanzioni colpiscono singole navi, facilmente rivendute, rinominate o registrate sotto nuove bandiere da società di comodo. Una soluzione sarebbe modificare l’impianto sanzionatorio per colpire l’intero ecosistema logistico: broker, Stati di bandiera e società di classificazione. Secondo gli esperti, colpire l’intera flotta fantasma e questi attori renderebbe insostenibile la capacità dell’Iran di eludere le sanzioni.
Il regime iraniano — guidato dal leader supremo Ali Khamenei, dal presidente Masoud Pezeshkian e dal Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche — è ancora in piedi, ma la sua leadership è stata duramente colpita dagli attacchi israeliani. Di recente, decine di alti comandanti si erano riuniti in un rifugio montano ritenuto segreto. Israele ha atteso che fossero tutti presenti, per poi colpirli ed eliminarli.
Un eventuale crollo del regime rappresenterebbe un grave danno per la Cina. In primo luogo, Pechino perderebbe prestigio: l’accordo del 2021 ha consacrato l’Iran come partner strategico in Medio Oriente. La disgregazione di Teheran priverebbe il regime comunista cinese di un alleato fondamentale. In secondo luogo, la Cina perderebbe un alleato chiave per esercitare influenza su Hamas, Hezbollah e gli Houthi. I primi due sono stati in gran parte neutralizzati, ma gli Houthi restano attivi e capaci di minacciare il traffico marittimo nel Mar Rosso, cruciale per l’Europa. L’Iran, inoltre, produce armi per conto della Cina e le manda alla Russia, e questo consente a Pechino di evitare un coinvolgimento diretto nel conflitto ucraino. Infine, il danno più grave: la Cina non ha alternative immediate al petrolio iraniano. Un’interruzione delle forniture metterebbe in ginocchio l’intero sistema economico e politico di Pechino.