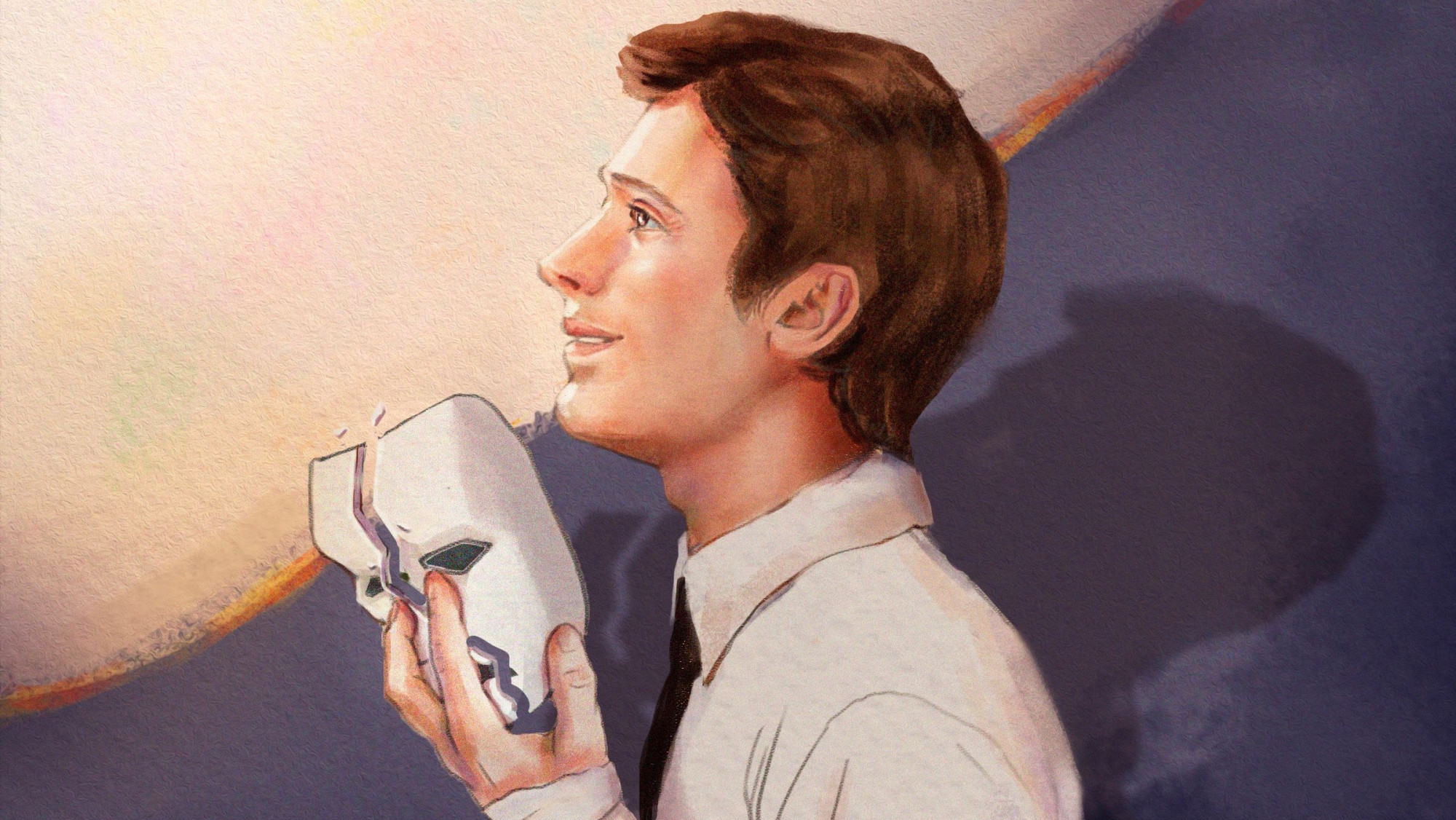Dopo essersi trasferita con la famiglia in una nuova città, Noga Metzal ha dovuto affrontare un difficile processo di integrazione nella scuola superiore. In un primo momento, sembrava che il gruppo di ragazze della classe la accogliesse con favore, ma col passare del tempo ha iniziato ad avvertire segnali di esclusione. Le compagne le voltavano le spalle, sussurravano tra loro e la bersagliavano con commenti sarcastici. La rimozione dai gruppi WhatsApp ha reso evidente la realtà: Noga era vittima di un boicottaggio.
Preoccupata, la madre si è rivolta agli insegnanti e al dirigente scolastico, che hanno reagito secondo prassi consolidate avendo già assistito a episodi simili. Hanno minimizzato il fenomeno, attribuendolo al fatto che Noga fosse una nuova arrivata e assicurando che la situazione si sarebbe risolta col tempo. Quando però la situazione si è aggravata, hanno suggerito di coinvolgere alcune compagne in un confronto diretto. Poiché il tentativo si è rivelato inefficace, i genitori hanno deciso infine di trasferire Noga in un’altra classe.
Nel corso degli ultimi decenni, il ministero dell’Istruzione israeliano ha promosso diversi programmi educativi per rafforzare i valori in ambito scolastico e incentivare il rispetto reciproco. Tra questi: “Tolleranza Zero”, “Il Diritto al Rispetto, il Dovere del Rispetto”, “La Chiave del Cuore” e altri programmi di mediazione. L’intento era anche quello di prevenire fenomeni di esclusione e bullismo. Tuttavia, uno studio recente condotto presso l’Università Ben-Gurion, sotto la guida del professor Avi Asor, rileva che tali iniziative raramente affrontano il legame tra aggressività e classe sociale. Poiché il tipo di boicottaggio descritto è connesso a dinamiche di status sociale, la maggior parte degli interventi non va alla radice del problema.
Tra i pochi programmi che si concentrano sul nesso tra aggressività e desiderio di popolarità vi è “Metzamichim”. Secondo Yoni Chona, direttore dell’organizzazione omonima, attiva in 400 scuole in Israele, il boicottaggio si configura come una lotta interna alle élite scolastiche o come reazione a una nuova presenza percepita come minacciosa. Ad esempio, una nuova studentessa che riesce a conquistare popolarità potrebbe suscitare la gelosia di una compagna, la quale reagisce organizzando un boicottaggio, giustificandolo con motivazioni fittizie come l’arroganza o presunti comportamenti provocatori.
Uno studio dell’Università della California, Davis, conferma che questo tipo di aggressività – definita «reputazionale» – contribuisce effettivamente alla popolarità di chi la esercita, a differenza di quella fisica, che non ha lo stesso effetto.
Per contrastare questa dinamica, il programma “Growers” propone un workshop di tre giorni, durante il quale gli istruttori hanno posto l’accento sull’importanza della cura reciproca. Viene chiesto agli studenti di riflettere su chi, tra i compagni, abbia dimostrato attenzione verso gli altri, impiegando il proprio status per sostenere chi è più vulnerabile. L’obiettivo è quello di stimolare una narrazione in cui la popolarità coincida con il coraggio di prendersi cura del prossimo.
In sostanza, il programma mira a incentivare comportamenti gentili, coinvolgendo in particolare gli studenti più popolari affinché sostengano chi si trova in posizioni marginali. «In questo modo – osserva Chona – si promuove un nuovo modello: il cabalista che è anche un ‘coltivatore’, capace di guidare con empatia e responsabilità». Al tempo stesso, gli studenti che ricorrono a tattiche di esclusione sono indotti a confrontarsi con coetanei che hanno conquistato la stima del gruppo grazie a comportamenti inclusivi.
In una fase successiva del workshop, si affrontano gli aspetti negativi delle dinamiche sociali. Vengono poste domande dirette, come: «Qualcuno ha mai usato il proprio status in modo da ferirti?», oppure: «Da dove proviene, secondo te, la maggior parte dell’aggressività?». I dati raccolti mostrano che solo il 7% degli atti aggressivi proviene da chi è socialmente emarginato; il restante 93% ha origine tra i soggetti più integrati. In questo modo, l’attenzione si sposta sull’aggressività esercitata “dall’alto”, e le viene attribuita una connotazione esplicitamente negativa.
Chona riferisce che gli studenti aggressivi, pur non venendo mai nominati direttamente, si riconoscono nelle dinamiche discusse in classe, si osservano e spesso provano vergogna. Parallelamente, gli insegnanti illustrano le modalità con cui l’aggressività si manifesta: «Proprio come si apprendono la geometria o le scienze – spiega Chona – è possibile insegnare a riconoscere le tattiche usate per rafforzare il proprio status sociale». Gli studenti vengono quindi invitati a interrogarsi sulle vere motivazioni dietro un boicottaggio: «Vi è mai capitato di comprendere le reali ragioni di un’esclusione?». In genere, emerge almeno una voce che riconosce nella paura o nel senso di minaccia la spinta principale dell’aggressore. Il passo successivo consiste nel domandare: «Pensate che quella persona ammetterebbe mai di sentirsi minacciata?». L’apprendimento non avviene attraverso i libri, ma nasce dal confronto in classe. È da queste conversazioni che prende forma un atteggiamento di rifiuto verso i comportamenti aggressivi. Alla domanda se l’obiettivo sia quello di rafforzare la moralità degli studenti, Chona risponde: «Non ci interessano i valori astratti. L’obiettivo è creare incentivi positivi per comportamenti altruistici e disincentivi per atteggiamenti antisociali, come insulti, calunnie e odio».
Secondo una diffusa convinzione, l’educazione familiare gioca un ruolo determinante: se un bambino cresce con valori solidi, sarà in grado di agire correttamente nella società. Ma, secondo Chona, non è sufficiente. «Il potere corrompe, anche i bambini. Inoltre, non sono consapevoli della responsabilità penale. Non è facile biasimare un bambino che percepisce che qualcuno gli stia ‘rubando’ gli amici, e ha a disposizione un mezzo per colpire quella persona con un semplice gesto». Chona si riferisce agli smartphone. «Oggi, gran parte della vita sociale dei bambini si svolge online. Se taggo qualcuno come “amico stretto”, è probabile che voglia condividere con lui le mie foto. Ma se lo rimuovo da quella lista, non si tratta di un boicottaggio in senso stretto, eppure è un gesto che può avere un impatto molto forte. I gruppi WhatsApp vengono creati in continuazione, spesso senza che i bambini sappiano se ne facciano parte o meno. La rete consente che si infliggano sofferenze continue, in modo silenzioso e spesso invisibile agli adulti».
Lo studio dell’Università israeliana Ben-Gurion ha valutato l’efficacia del programma su studenti di quinta e sesta elementare in otto scuole, confrontandoli con un gruppo di controllo composto da sette istituti (per un totale di 1.430 alunni). In entrambi i gruppi, studenti e insegnanti hanno risposto a questionari due settimane prima del workshop, due settimane dopo e infine a quattro mesi di distanza. Le variabili analizzate includevano il livello di aggressività in classe, la percezione che essa migliori lo status sociale, il senso di appartenenza e la capacità degli insegnanti di gestire il clima sociale.
È stato inoltre misurato il livello di coinvolgimento degli insegnanti, distinto tra medio-alto e basso. I risultati mostrano che, laddove l’impegno del personale scolastico è stato elevato, si è registrata una riduzione dell’aggressività a quattro mesi dalla conclusione del programma. In sintesi, il coinvolgimento attivo degli insegnanti si conferma come elemento determinante per l’efficacia del progetto: un workshop di tre giorni, da solo, non è sufficiente a modificare in modo duraturo il comportamento degli studenti né a migliorare il clima scolastico.
«SII GENTILE CON LORO»: IL METODO DI IZZY KALMAN CONTRO IL BULLISMO
Durante l’estate segnata dalla pandemia, poco prima che gli studenti tornassero tra i banchi, con alcuni che portavano con sé il peso di insulti e vessazioni, la psicologa americana Izzy Kalman ha illustrato un approccio alternativo alla gestione del bullismo. Diversamente dal modello israeliano dei “Mazmichim”, incentrato sulle dinamiche di gruppo e sull’influenza della classe dominante, Kalman propone un intervento basato sul cambiamento individuale della vittima.
La sua esperienza inizia negli anni Settanta, quando lavorava come psicologo scolastico in Israele. Notò allora che la lamentela più ricorrente tra gli studenti riguardava episodi di bullismo. Avvalendosi delle sue competenze, iniziò a utilizzare giochi di ruolo e simulazioni per insegnare ai ragazzi come affrontare simili situazioni, ottenendo – a suo dire – risultati significativi.
Il fulcro del suo metodo sta nella distinzione tra due tipi di danno: oggettivo e soggettivo. Il primo riguarda azioni che causano un pregiudizio materiale evidente – come un’aggressione fisica o un furto – e che costituiscono un reato a prescindere dalla percezione soggettiva. Il secondo, invece, dipende dalla reazione personale a parole o comportamenti altrui, come nel caso di un insulto: in tale situazione, il dolore provato deriva dal modo in cui si sceglie di interpretare l’offesa. Da questa distinzione nasce la regola d’oro che Kalman propone: rispondere alla prepotenza con gentilezza. Un principio semplice, ma controintuitivo. Secondo la psicologa, si tratta di un comportamento difficile da mettere in pratica, ma efficace: «Funziona, ed è ciò che conta».
Un aneddoto riferito da un conoscente sembra confermare questa tesi. Durante il servizio militare, l’uomo era regolarmente preso di mira da un altro soldato. Inizialmente reagiva difendendosi, finché un giorno, dopo aver letto alcuni testi di auto-aiuto, decise di cambiare strategia. Quando il bullo gli versò dell’acqua nel piatto durante il pranzo, egli rispose con calma: «Se questo ti fa sentire meglio, va bene. Per me è importante che tu stia bene». Da quel momento, il comportamento ostile cessò.
Kalman propone due esercitazioni per dimostrare l’efficacia del suo approccio. Nella prima, si reagisce a un insulto difendendosi e passando all’attacco; nella seconda, si accetta l’offesa con distacco e si risponde con un complimento. In questo secondo caso, l’interlocutore fatica a proseguire con l’aggressione verbale. «Quando mi difendo, divento un nemico», spiega Kalman. «Quando reagisco con gentilezza, divento un amico. È tutta qui la differenza». Ma è un metodo davvero efficace? Secondo Kalman, sì. Viene applicato sia nelle simulazioni scolastiche, sia da organizzazioni come “Be Strong” negli Stati Uniti e “Ta’tzumot” in Israele, che si occupano di promozione del benessere tra i giovani.
Tuttavia, il metodo può apparire come una rinuncia alla propria dignità. In un contesto sociale dove chi non reagisce è spesso considerato un perdente, rispondere con gentilezza può sembrare un’ammissione di debolezza. Kalman ribalta questa prospettiva: «Non è sottomissione, è rottura del ciclo della reciprocità negativa. Quando rispondiamo al male con il male, creiamo conflitto. Se invece interrompiamo questa dinamica e rispondiamo con gentilezza, l’altro, programmato anch’esso per la reciprocità, sarà indotto a cambiare atteggiamento. Così si trasforma un nemico in un alleato». Il principio, conclude Kalman, è semplice: chi riesce ad applicare la regola d’oro, può cambiare la qualità delle proprie relazioni. Non per cedere, ma per vincere entrambi.