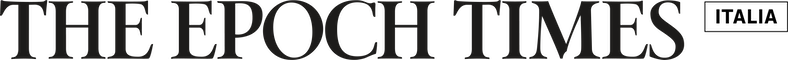Il 3 agosto 2014, ero davanti alla televisione, sconvolta nel vedere l’autoproclamato Stato Islamico avanzare in Iraq e Siria, eliminando con pulizie etniche yazidi e cristiani da ogni territorio conquistato. Sullo schermo scorrevano immagini inquietanti del monte Sinjar, sul quale decine di migliaia di yazidi si erano rifugiati e ora, intrappolati, morivano di fame e disidratazione sotto un sole cocente. I resoconti erano drammatici: gli elicotteri inviati per portare cibo, acqua e per far evacuare i più vulnerabili erano precipitati, lasciando le persone isolate sulla montagna. Dall’esperienza maturata in Medio Oriente e Africa sapevo che cosa sarebbe successo a quelle minoranze religiose. In quel momento presi una decisione: dovevo partire, dovevo aiutare. Poche settimane dopo atterrai a Erbil, in Iraq. I sopravvissuti si dirigevano verso la regione curda e iniziai a impegnarmi per soccorrerli. Conobbi donne e ragazze fuggite da orrori indicibili.
Unendo le forze con i leader locali yazidi, lavorai per il recupero di donne e ragazze rapite. Accompagnai i sopravvissuti nei campi rifugio ai quali tornavano, spesso dopo trattative lunghe e dolorose. Ascoltare le loro storie di brutalità, sopravvivenza e perdita rappresentò una delle esperienze più difficili della mia carriera nel settore umanitario. In quel periodo incontrai un vero eroe del popolo yazida, Mirza Dinnayi, l’uomo dietro le missioni di salvataggio in elicottero che avevo visto in televisione e che avevano ispirato la mia scelta di andare in Iraq. Lavorammo fianco a fianco nei campi profughi di Dohuk e altrove, cercando di aiutare quanti più possibile. Successivamente, Mirza ricevette il premio Aurora per il Risveglio dell’Umanità, mentre l’associazione che avevo fondato, Shai Fund, divenne beneficiaria dello stesso riconoscimento. Fu un momento di pieno senso e gratificazione, non per noi, ma per i sopravvissuti. Tuttavia, il nostro impegno non si limitò ai campi. Combattemmo anche affinché il mondo riconoscesse quell’orrore per quello che era: un genocidio.
Nel marzo 2015, la Camera dei deputati degli Stati Uniti approvò una risoluzione che riconosceva i crimini dell’Isis come genocidio, e l’anno successivo il ministro degli Esteri John Kerry pronunciò una dichiarazione formale in tal senso. Nel giugno 2016, la Commissione d’inchiesta delle Nazioni Unite concluse che l’Isis aveva commesso genocidio contro i yazidi, e poco dopo seguirono i parlamenti europeo e britannico. Il riconoscimento arrivò lentamente, ma fu fondamentale: aprì la strada alla giustizia, alle riparazioni e alla memoria. Quest’anno, nel ricordare l’undicesimo anniversario di quella tragica giornata, commemoriamo i sopravvissuti e le migliaia di persone che non sono mai tornate.
Nonostante il tempo trascorso, la condizione della comunità yazida non è sostanzialmente migliorata. A migliaia vivono ancora nei campi profughi sparsi in Iraq, impossibilitati a far ritorno nelle proprie case nel distretto di Sinjar, ancora distrutto. Oltre 2.500 donne e bambini yazidi risultano tuttora scomparsi, probabilmente prigionieri, sottoposti ad abusi e schiavitù. A undici anni di distanza, le loro storie restano un doloroso monito di un male rimasto impunito.
Il lavoro della comunità internazionale nel sostenere i yazidi nel processo di guarigione e ricostruzione, dopo le atrocità subite esclusivamente per la loro fede, deve proseguire. Dobbiamo chiederci: le politiche che promuoviamo in Medio Oriente e altrove tutelano davvero la libertà religiosa di tutti, ovunque e in ogni momento? Il genocidio yazida ci ricorda che il male prospera quando le persone di buona volontà rimangono inermi. Ma dimostra anche che la speranza perdura quando il coraggio prende il sopravvento.
Copyright Epoch Times