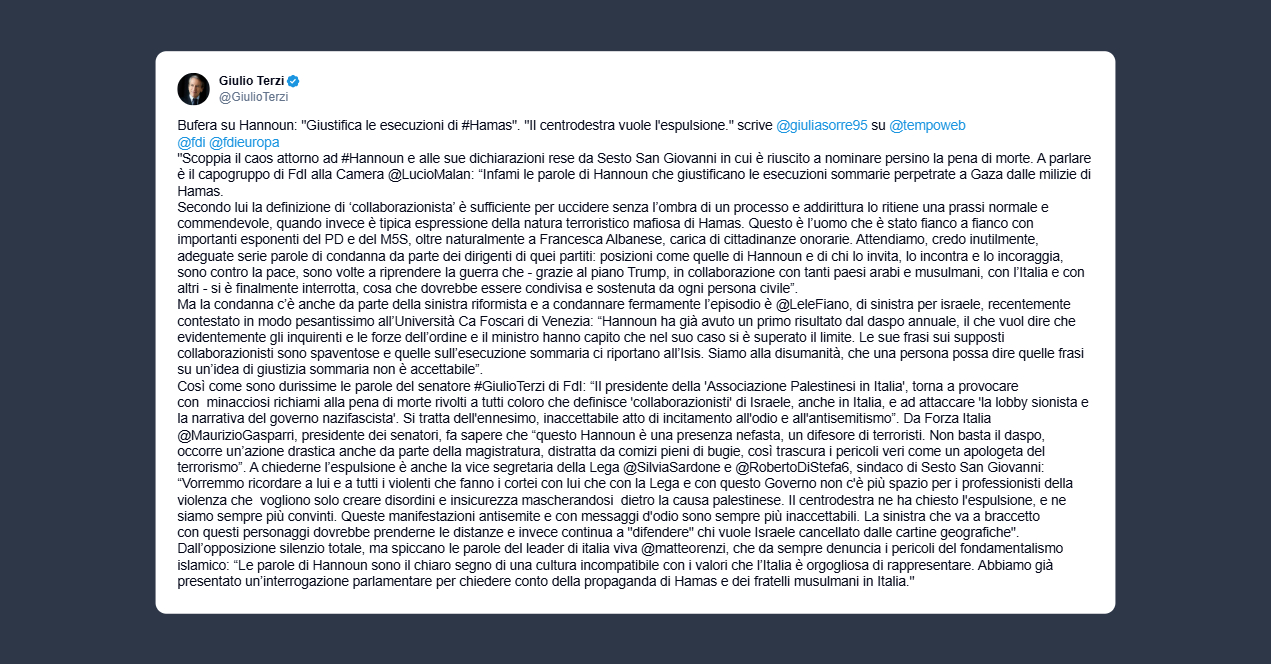Due binari distinti e destinati a non incontrarsi mai. Si può sintetizzare così la separazione tra le carriere di giudici e pubblici ministeri, il provvedimento “bandiera” della riforma della Giustizia italiana voluta dal governo di Giorgia Meloni. Lo scorso 30 settembre il testo di legge è stato approvato in via definitiva in Senato, ma non è stata raggiunta la maggioranza dei due terzi, perciò dovrà essere sottoposto a referendum confermativo, probabilmente nella primavera 2026.
Nel concreto, questa misura introduce a livello costituzionale due percorsi distinti per magistrati “requirenti” (Pm) e magistrati “giudicanti” (giudici), dunque non più un’unica carriera per le toghe ma una biforcazione che segna fin dall’inizio una scelta irreversibile tra funzione dell’accusa e del giudizio. Il magistrato che ricopre il ruolo di Pm non potrà più transitare liberamente nel ruolo di giudice, e viceversa.
Cambia anche l’organo di autogoverno dell’ordinamento giudiziario, il Consiglio superiore della magistratura: ne verrà istituito uno per la magistratura giudicante, e un altro per quella inquirente. Entrambi saranno presieduti dal Presidente della Repubblica, come avviene già, e avranno come membri di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di Cassazione. I componenti del Csm, inoltre, non saranno più eletti, ma estratti a sorte: i membri “laici” — un terzo del totale — da un elenco di giuristi predisposto dal Parlamento in seduta comune; i membri togati, tra tutti i magistrati che abbiano i requisiti fissati da una futura legge ordinaria. Il mandato durerà 4 anni e i componenti uscenti non potranno partecipare al sorteggio successivo. Entrambi i Consigli manterranno la gestione di assunzioni, trasferimenti, valutazioni di professionalità e conferimenti di funzioni, ma perderanno i poteri disciplinari, che passeranno a un nuovo organo di garanzia, l’Alta Corte disciplinare. L’organo prenderà il posto dell’attuale sezione disciplinare del Csm, sarà composto da 15 giudici tra toghe e membri laici sorteggiati, e controllerà l’operato di tutti i magistrati, decidendo sulle eventuali sanzioni.
Il Governo celebra la riforma come un traguardo «storico», una svolta che consentirà di scardinare il sistema delle “porte girevoli” e restituire ai cittadini una Giustizia più equa e efficiente. Per l’Associazione Nazionale Magistrati (Anm), invece, questa riforma «altera l’assetto dei poteri disegnato dai costituenti e mette in pericolo la piena realizzazione del principio di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge». L’Anm è convinta, poi, che le novità non rendano la giustizia «più rapida o più efficiente ma più esposta all’influenza dei poteri esterni».
Dal punto di vista della classe politica che ha proposto la riforma, la separazione delle carriere garantirebbe la terzietà del giudice. Il vantaggio sarebbe quello di favorire una maggiore trasparenza tra chi indaga e chi giudica, evitando che il pubblico ministero possa transitare in ruoli giudicanti. L’obiettivo è di impedire che figure dell’accusa passino al banco dei giudici, generando possibili pressioni o condizionamenti interni al sistema.
COME FUNZIONA ORA
In base alle regole vigenti, tutti i magistrati seguono lo stesso percorso formativo e possono cambiare funzione una sola volta durante la loro carriera e solo entro i primi dieci anni di servizio. Fino al 2022, prima della “riforma Cartabia”, questo limite era di quattro passaggi. Alcuni giuristi, infatti, ritengono che la riforma sia superflua, poiché nella pratica la distinzione tra le due funzioni esiste già. La prima presidente della Corte di Cassazione, Margherita Cassano, in una audizione alla Camera del luglio 2024 ha ricordato che «negli ultimi cinque anni» solo lo «0,83 per cento» dei pubblici ministeri è passato a funzioni giudicanti e lo «0,21 per cento» dei giudici a funzioni requirenti.
In Commissione Affari Costituzionali del Senato, lo scorso febbraio, il sostituto procuratore Domenico Airoma, della Direzione distrettuale antimafia di Napoli, ha spiegato che oggi il passaggio da un ruolo all’altro è già molto difficile anche perché può avvenire dopo un corso di qualificazione e un giudizio di idoneità del Csm.
Un altro punto molto discusso è l’introduzione del sorteggio per nominare i membri dei due Csm, che per i promotori della riforma rappresenta un’innovazione finalizzata a ridurre l’influenza delle dinamiche associative e politiche – le cosiddette “correnti” – nelle elezioni dei rappresentanti del Consiglio. Una parte della magistratura, invece, teme che questa separazione possa ridurre l’autonomia interna, frammentare il corpo giudiziario e porre di fatto i pubblici ministeri in una posizione più debole o più esposta a ingerenze della politica.
Quali vantaggi potrebbe portare la separazione delle carriere, invece, ai cittadini? Una distinzione netta tra toghe e titolari delle procure, potrebbe accrescere la percezione di una maggiore imparzialità del giudice e generare maggiore fiducia pubblica nel sistema giudiziario. Secondo un’indagine Istat sulla fiducia nelle istituzioni del nostro Paese, nel 2024 il 44% degli italiani dichiara di fidarsi della magistratura (assegnando un punteggio tra 6 e 10), una percentuale in calo rispetto al picco del 46,1% del 2023. Il 41,4% degli intervistati assegna, invece, punteggi compresi tra 1 e 5.
D’altro canto, per altri la separazione rigida delle carriere potrebbe complicare il coordinamento tra Pm e giudici nelle indagini e nei processi. Un modello più rigido potrebbe rallentare il sistema giudiziario, aumentando i tempi di definizione dei procedimenti, che già sono molto lunghi.
Ogni due anni il Consiglio d’Europa pubblica un rapporto relativo ai tempi della Giustizia in 44 Paesi. Gli ultimi dati diffusi fanno riferimento al 2022 e confermano la tendenza di riduzione dei tempi a partire dal 2010, quando i processi civili che raggiungevano il terzo grado di giudizio duravano in media 2.992 giorni, ossia 8 anni e 2 mesi. Nel 2022, la durata dei processi è scesa a 2.356 giorni, ossia 6 anni e 5 mesi.
In ogni caso, in Italia il tempo per arrivare alla definizione di una causa resta significativamente superiore rispetto agli altri principali Paesi europei: in Francia e in Spagna la durata era di 3 anni e 8 mesi, in Germania di 1 anno e 5 mesi.
COME FUNZIONA NEGLI STATI UNITI
Introdurre la separazione delle carriere, potrebbe avvicinare – in parte e almeno sul piano formale – il sistema giudiziario italiano a quello statunitense. Negli Usa, infatti, giudici e pubblici ministeri appartengono a due corpi distinti, con funzioni e percorsi professionali diversi. È necessario innanzitutto specificare che il sistema della Giustizia americano è, a livello strutturale, un riflesso del Federalismo; presenta cioè due distinti “rami”: la giustizia federale e quella statale. Operano in parallelo, ciascuna con competenze proprie, ma condividono una struttura a tre livelli: tribunali di primo grado alla base, corti d’appello al centro e la Corte Suprema al vertice. Questa doppia struttura nasce dalla necessità di risolvere controversie che, per loro natura, possono essere di competenza della legge federale o di quella statale. Perché un procedimento approdi in un tribunale federale, deve comportare una violazione della Costituzione o di una legge federale. I tribunali statali, invece, hanno una giurisdizione generale: possono giudicare quasi ogni tipo di illecito basato sul diritto statale.
I giudici federali, inclusi quelli della Corte Suprema vengono nominati dal Presidente e confermati dal Senato, con incarico a vita. Quelli statali vengono selezionati con criteri diversi, che variano in base allo Stato di appartenenza: alcuni sono nominati dal Governatore, altri dal Parlamento statale, molti vengono eletti direttamente dai cittadini. La nomina è politica, ma il mandato a vita è concepito per garantire l’indipendenza del potere giudiziario: il giudice non può essere rimosso né subire tagli di stipendio durante il servizio.
Negli Stati Uniti il pubblico ministero si chiama “prosecutor”, ma esistono varie denominazioni a seconda del livello: l’Attorney General, il Procuratore generale, è il capo del ministero della Giustizia, nominato dal Presidente e membro del Governo; ci sono poi gli U.S. Attorneys, che rappresentano il governo federale in ciascun distretto giudiziario; gli Assistant U.S. Attorneys, i sostituti procuratori, sono i magistrati inquirenti che materialmente conducono le indagini e sostengono l’accusa in tribunale. A livello statale, i capi delle Procure si chiamano District Attorneys, e sono spesso eletti direttamente dai cittadini.
A livello federale, gli U.S. Attorneys sono nominati dal Presidente e confermati dal Senato, ma restano in carica per un periodo limitato (di solito 4 anni) e possono essere rimossi in qualsiasi momento. Gli Assistant U.S. Attorneys invece sono assunti come funzionari pubblici dal ministero della Giustizia, tramite un processo selettivo basato su titoli e esperienze professionali. A livello statale e locale, la maggior parte dei District Attorneys è eletta dal popolo: ciò significa che il Pm risponde direttamente agli elettori e non al governo federale o statale.