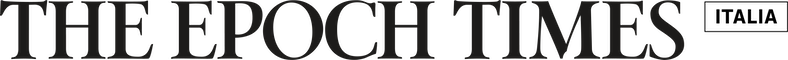L’uscita degli Usa dall’Oms e la lotta per il controllo della sanità mondiale

Illustrazione di The Epoch Times
| Aggiornato alle del
Condividi articolo
Tempo di lettura: 6 Min.
Tempo di lettura: 6 Min.
L’approvazione del primo trattato internazionale sulle pandemie da parte dell’Organizzazione mondiale della sanità a maggio è stata apprezzata dalle Nazioni Unite, ma ha suscitato critiche da parte degli Stati Uniti, che accusano l’agenzia di corruzione e di aver deviato dalla sua missione originaria di promuovere la salute mondiale.
Durante la 78esima Assemblea mondiale della sanità a Ginevra, l’accordo è stato approvato da 124 Paesi senza obiezioni e con 11 astensioni, ma la delegazione Usa era assente. In un messaggio video, il ministro della Salute Usa, Robert F. Kennedy Jr., ha invitato i ministri mondiali a considerare il ritiro statunitense come un segnale di allarme, proponendo un sistema sanitario alternativo fuori dall’Oms, definita «moribonda». La proposta, però, manca di dettagli operativi e appare poco attrattiva per altri Paesi, eccetto l’Argentina, unico altro membro ad aver lasciato l’organizzazione.
Donald Trump ha avviato il ritiro a gennaio 2025, riprendendo un processo bloccato da Biden nel 2020. L’Oms ha espresso speranza in un ripensamento, ricordando che la collaborazione con gli Usa, dal 1948, ha salvato milioni di vite. L’agenzia ha avviato riforme per rispondere alle critiche.
Donald Trump ha avviato il ritiro a gennaio 2025, riprendendo un processo bloccato da Biden nel 2020. L’Oms ha espresso speranza in un ripensamento, ricordando che la collaborazione con gli Usa, dal 1948, ha salvato milioni di vite. L’agenzia ha avviato riforme per rispondere alle critiche.
La pandemia di Covid-19 ha spinto i governi a investire miliardi in vaccini e tecnologie per prevenire future malattie, comprese quelle ancora inesistenti come la cosiddetta Malattia X. Questo approccio si scontra con una visione più tradizionale, che punta a rafforzare i sistemi sanitari locali, migliorare nutrizione, igiene e sviluppo economico. Le risorse limitate impongono scelte che determinano l’efficacia delle politiche sanitarie mondiali.
Il programma Make America Healthy Again dell’amministrazione Trump privilegia la prevenzione delle malattie croniche legate a malnutrizione e stili di vita. Ma l’uscita dall’Oms e i tagli agli aiuti esteri — incluso il possibile smantellamento dell’agenzia Usaid — sollevano timori di un vuoto di potere che potrebbe favorire governi autoritari, come la Cina, e l’industria farmaceutica, già influente sulle priorità sanitarie mondiali.
Secondo alcuni esperti, il ritiro Usa offre però l’occasione di correggere disfunzioni sistemiche, come la dipendenza dell’Oms da fondi privati. Tulio de Oliveira, virologo sudafricano, ha criticato l’uscita americana, ricordando che gli Usa investono meno dell’1% del Pil nella sanità pubblica mondiale, una cifra irrisoria rispetto alle perdite causate dalle pandemie. Ha citato l’H5N1, che sta decimando gli allevamenti avicoli e alzando i prezzi di uova e pollame, come esempio di minaccia emergente. Recentemente, l’amministrazione Trump ha annullato un contratto da oltre 700 milioni di dollari con Moderna per vaccini mRna contro l’influenza aviaria, considerati dal ministero della Salute «sotto-testati». Il portavoce del ministero della Salute Usa, Andrew Nixon, ha dichiarato che non saranno spesi fondi pubblici per ripetere gli «errori» della pandemia.
Oms, Banca mondiale e G20 richiedono decine di miliardi l’anno per la preparazione pandemica, principalmente per vaccini e tecnologie digitali. Ma David Bell, medico esperto di sanità internazionale, contesta queste stime, ritenendole gonfiate. Tra il 2000 e il 2020, escluse Covid-19 e l’influenza H1thal, i focolai pandemici hanno causato meno di 26 mila morti, contro i 2 milioni annui di tubercolosi, Hiv e malaria.
Secondo l’alleanza internazionale Gavi, la tubercolosi è tornata nel 2023 come principale killer infettivo, superando il Covid-19. Bell osserva che la malnutrizione, fattore di vulnerabilità, riceve sempre meno fondi, mentre l’Oms privilegia risposte verticali come i vaccini, guidata dalle priorità dei donatori. Il finanziamento dell’Oms dipende infatti da contributi volontari legati a progetti specifici, con la Fondazione Gates secondo maggior finanziatore dopo gli Usa, seguita da Gavi. Questo sistema ha spostato l’attenzione da cure di base a interventi centralizzati. Elisabeth Paul, esperta di sistemi sanitari mondiali, definisce questa deriva un tradimento della missione normativa dell’Oms, ridotta a esecutrice delle priorità dei donatori e dell’industria farmaceutica, che promuove i vaccini come unica soluzione.
Si delineano due approcci ideologici: combattere malattie specifiche, più attraente per i finanziatori, o promuovere la salute olistica, che rafforza la resilienza contro tutti i patogeni. La Paul sottolinea che un sistema sanitario solido, come previsto dall’agenda dell’amministrazione Trump, resta la migliore preparazione contro future pandemie. Misurare il successo solo in termini di vite salvate dai vaccini e ignorare le cause strutturali come la malnutrizione, distorce le priorità.
Mohamed Lamine Dramé, esperto di politiche sanitarie, critica i progetti imposti dall’alto senza consultare i governi locali. E osserva che il focus sulle emergenze lascia scoperte malattie come malaria e diarrea, ancora letali in molti Paesi.
Il ritiro Usa e i tagli agli aiuti, che hanno ridotto i fondi per programmi Hiv e tubercolosi, avranno impatti immediati sui Paesi più poveri. Tuttavia, alcuni analisti vedono un’occasione di riforma, come l’aumento delle quote obbligatorie dei membri al 40% del budget Oms. Intanto la Cina, pur contribuendo meno degli Usa, ha promesso 500 milioni di dollari in cinque anni.
Il problema, però, va oltre l’Oms. Le istituzioni finanziarie spingono priorità pandemiche per interessi privati e ostacolano il dissenso dei Paesi più piccoli. La crisi dell’Hiv dimostra che nuove strutture possono emergere quando l’Oms tarda a rispondere. Ripensare il ruolo dell’agenzia appare inevitabile in un contesto sanitario mondiale in rapido cambiamento.