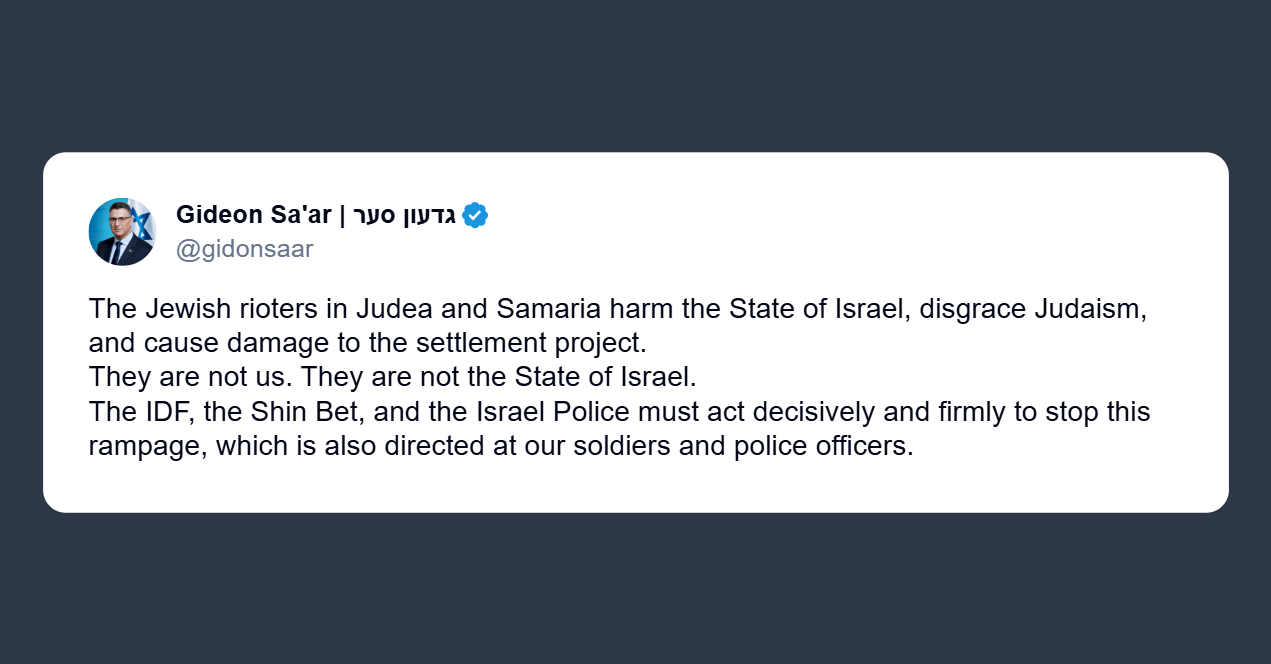Harvard torna ancora una volta sotto i riflettori. Il recente intervento da parte del ministero del Commercio degli Stati Uniti contro l’ateneo solleva un tema delicato quanto cruciale: quello della responsabilità delle istituzioni accademiche nel gestire in modo corretto i risultati della ricerca finanziata con fondi pubblici.
La situazione evidenzia come, nonostante le opportunità offerte dal Bayh-Dole Act per la valorizzazione delle innovazioni, l’università di Harvard non stia rispettando appieno gli obblighi legali e contrattuali imposti dal governo federale. Nella lettera inviata l’8 agosto al rettore Alan Garber, il ministro del Commercio Howard Lutnick contesta ad Harvard di non aver rispettato gli obblighi nei confronti dei contribuenti americani, violando requisiti di natura legislativa, regolamentare e contrattuale connessi ai programmi di ricerca finanziati con fondi federali e ai relativi diritti di proprietà intellettuale, compresi i brevetti. In risposta, il ministero del Commercio ha avviato una revisione approfondita delle presunte inadempienze dell’ateneo e procederà con il processo di “march-in”, che potrebbe portare alla cessione dei brevetti a proprietà federale.
Il Bayh-Dole Act, approvato con l’obiettivo di promuovere l’innovazione e garantire che i risultati delle ricerche finanziate pubblicamente siano accessibili e utilizzati a beneficio della società, conferisce al governo la possibilità di intervenire nei casi in cui l’istituzione titolare dei brevetti non riesca a sfruttare adeguatamente tali risorse. Il fatto che questa misura, mai adottata nei quarant’anni precedenti, venga ora applicata proprio ad Harvard, segnala una situazione di estrema gravità.
In particolare, il mancato adempimento agli obblighi di trasparenza e la scarsa attenzione a promuovere l’uso effettivo delle invenzioni appaiono contraddire la missione stessa di un’università di eccellenza. Se la ricerca pubblica non si traduce in applicazioni concrete, i fondi dei contribuenti rischiano di venire sprecati, con un danno non solo economico, ma anche sociale e scientifico.
Un portavoce di Harvard, in una dichiarazione inviata a The Epoch Times, ha definito questa iniziativa come «un’azione senza precedenti e di natura ritorsiva, volta a punire l’ateneo per aver difeso i propri diritti e la propria autonomia». Ha aggiunto che «le tecnologie e i brevetti sviluppati ad Harvard rappresentano innovazioni salvavita e che hanno rivoluzionato interi settori industriali». L’università si dichiara «completamente impegnata a rispettare il Bayh-Dole Act, garantendo che il pubblico possa beneficiare delle numerose innovazioni nate da ricerche finanziate con fondi federali».
Ma la difesa di Harvard non riesce a scalfire la sostanza delle contestazioni: mantenere i diritti di proprietà senza un’adeguata valorizzazione va contro lo spirito della legge e mina la fiducia nei confronti delle istituzioni accademiche. È legittimo che il governo pretenda un’azione concreta per garantire che i brevetti finanziati con fondi pubblici producano benefici tangibili.
In questo contesto, la richiesta del ministero del Commercio di un elenco completo dei brevetti e di prove sul rispetto delle normative appare necessaria per chiarire la reale situazione. Le autorità sembrano intenzionate a far valere la legge, anche con la possibilità di trasferire i diritti di brevetto a terzi, qualora Harvard continui a non onorare i propri impegni.
La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di tensioni tra l’università e il governo federale, che ha già sospeso ingenti finanziamenti a causa di altre contestazioni riguardanti la gestione di temi delicati come l’antisemitismo e la sicurezza nel campus. L’ateneo si trova così a dover rispondere non solo di questioni accademiche, ma anche di una più generale mancanza di responsabilità nei confronti del pubblico e dei finanziatori.
Finora il governo federale ha già sospeso ad Harvard oltre 2,6 miliardi di dollari in finanziamenti, compresi 2,2 miliardi in sovvenzioni federali, a seguito delle accuse di antisemitismo. Il ministero degli Interni il 22 maggio ha dichiarato che la leadership di Harvard ha favorito un ambiente che permetteva addirittura a soggetti antiamericani e filo-terroristi di molestare e aggredire fisicamente studenti, appartenenti in particolare alla comunità ebraica, compromettendo l’ambiente di apprendimento un tempo altamente stimato.
L’Ateneo, che purtroppo non è nuovo a comportamenti discutibili, ha collezionato nel tempo anche una serie di accuse legate a collaborazioni controverse e mancanze nella tutela dei diritti fondamentali. Nel 1997, il leader del Partito comunista cinese Jiang Zemin visitò l’università, dando inizio a un solido legame con Pechino. Da allora, Harvard ha maturato una lunga esperienza di relazioni con la Cina, tanto da fungere da amplificatore della propaganda della dittatura comunista e, tra le varie accuse, c’è anche quella di aver favorito, direttamente o indirettamente, la repressione dei dissidenti del regime cinese sul suolo americano. Numerosi parlamentari statunitensi hanno inoltre contestato le collaborazioni dell’università con enti cinesi soggetti a sanzioni, ritenendo l’ateneo complice nelle violazioni dei diritti umani perpetrate dal governo di Pechino.
Nel frattempo, l’ateneo sembra momentaneamente mostrare segnali di un possibile avvicinamento alle richieste del governo federale. Il 29 luglio, Harvard ha annunciato l’intenzione di consegnare al ministero degli Interni i moduli di assunzione di migliaia di membri del personale, in risposta a una specifica richiesta. Si tratta del documento denominato “Employment Eligibility Verification”, utilizzato per accertare l’identità e l’autorizzazione al lavoro delle persone impiegate negli Stati Uniti.