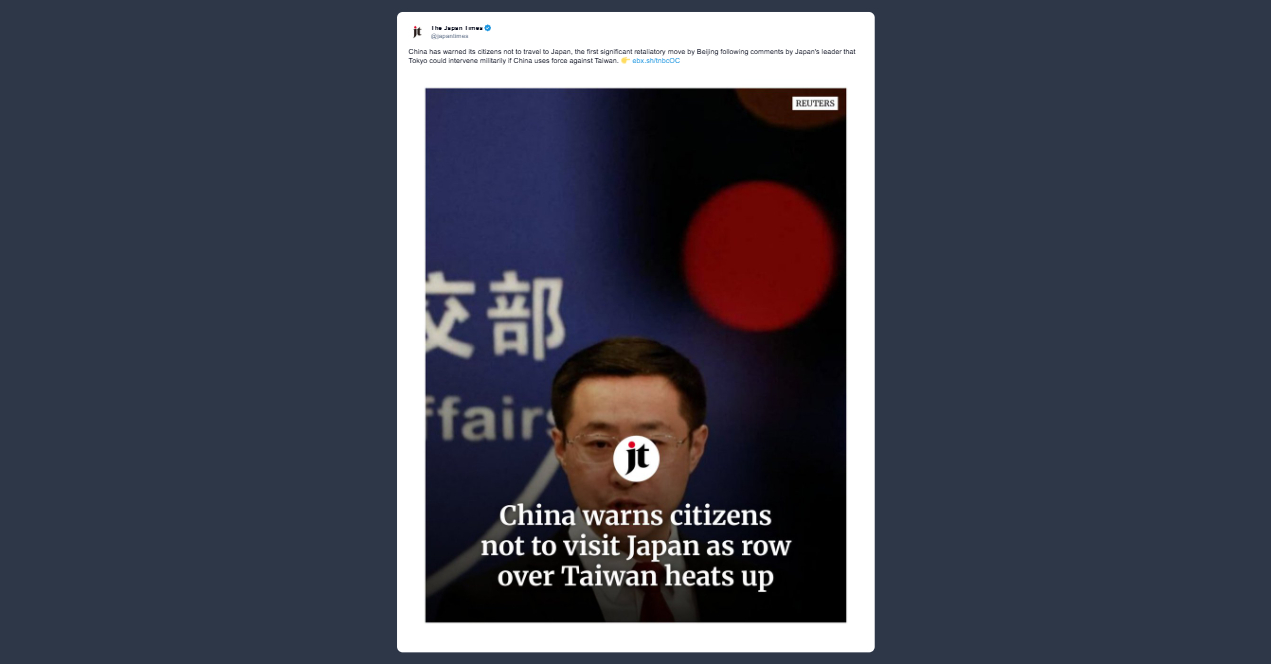Al vertice G7 dello scorso giugno, Ursula von der Leyen ha presentato un piccolo oggetto dal valore simbolico: un magnete di terre rare prodotto al di fuori della Cina. Realizzato in Estonia da un’azienda canadese, con materie prime provenienti dall’Australia e il supporto del Fondo europeo per la Transizione Equa, il magnete rappresenta un esempio concreto dell’impegno occidentale a diversificare le catene di approvvigionamento, riducendo la dipendenza dal regime cinese.
Attualmente, secondo l’Agenzia Internazionale dell’Energia, la Cina controlla circa il 90% della raffinazione mondiale delle terre rare: un magnete prodotto lungo una filiera alternativa rappresenta quindi un traguardo rilevante. Questi materiali sono cruciali per l’industria contemporanea: dai veicoli elettrici agli smartphone, dai sistemi d’arma avanzati ai magneti resistenti al calore. Le stime indicano, ad esempio, che un caccia F-35 necessita di oltre 400 chilogrammi di terre rare, mentre un sottomarino nucleare d’attacco supera i 4 mila.
Il termine “rare” non si riferisce alla scarsità di questi elementi nella crosta terrestre, bensì alla loro bassa concentrazione e ai costi elevati necessari per separarli da altri metalli. Il dominio cinese non riguarda soltanto l’estrazione, ma anche la raffinazione e la produzione industriale, inclusi i magneti. Grazie a questa posizione dominante, Pechino ha utilizzato le terre rare come leva strategica nella guerra commerciale con Washington. Nonostante gli accordi siglati a Ginevra e Londra per garantire le forniture agli Stati Uniti, i livelli precedenti ai controlli imposti da Pechino ad aprile non sono stati ristabiliti.
In America, l’amministrazione Trump ha accelerato gli sforzi per sviluppare una filiera nazionale attraverso deregolamentazione e investimenti. La supremazia cinese era già stata riconosciuta durante la presidenza Obama. Successivamente, l’amministrazione Biden ha introdotto crediti d’imposta e finanziamenti tramite l’Inflation Reduction Act. Secondo diversi analisti, l’Occidente ha ormai intrapreso un percorso irreversibile verso la creazione di una filiera autonoma, indipendentemente da eventuali allentamenti dei controlli da parte della Cina.
L’esempio del magnete europeo – realizzato grazie alla collaborazione di più Paesi – è stato indicato come un modello da replicare. La questione non riguarda solo la produzione, ma anche la raffinazione e la fabbricazione di componenti strategici. Attualmente, Mountain Pass, in California, è l’unica miniera attiva di terre rare negli Stati Uniti, ma invia ancora la maggior parte della sua produzione in Cina per la lavorazione. Il quadro attuale è frutto di scelte industriali compiute nei decenni scorsi: dagli anni ’90 in poi, la Cina ha consolidato la propria posizione attraverso joint venture obbligatorie, trasferimento tecnologico e sostegni pubblici, fino a conquistare oltre il 90% della raffinazione mondiale entro il 2010.
Nonostante gli sforzi anche da parte del Giappone per diversificare le forniture, il resto del mondo è tornato a rifornirsi dalla Cina, mantenendo di fatto inalterato il monopolio. Oggi Pechino raffina ancora il 90% delle terre rare mondiali. Ma secondo molti osservatori, il contesto è cambiato. La consapevolezza strategica del ruolo delle terre rare appare più radicata, così come l’impegno a livello di policy. Gli esperti mettono tuttavia in guardia da una nuova possibile offensiva cinese basata sulla concorrenza dei prezzi.