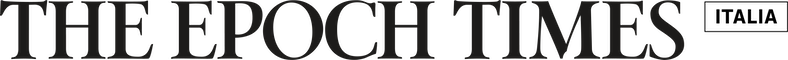Gli Stati europei "contro” la Convenzione europea per i diritti dell’uomo

| Aggiornato alle del
Condividi articolo
Tempo di lettura: 7 Min.
Tempo di lettura: 7 Min.
In tutta Europa si levano voci sempre più insistenti per reinterpretare o riformare la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, un pilastro del dopoguerra, oggi sotto pressione a causa di diversi problemi. Nata nel 1950, la Convenzione rappresenta uno dei primi trattati europei vincolanti in materia di diritti umani: garantisce diritti fondamentali come la vita, la libertà, il giusto processo, la privacy, la libertà di espressione e ripudia la tortura. Promulgata sotto l’egida del Consiglio d’Europa, un’organizzazione distinta dall’Unione Europea, la Convenzione è applicata dalla Corte europea per i diritti dell’uomo le cui sentenze sono vincolanti per tutti i 46 Stati membri del Consiglio d’Europa.
La Corte di Strasburgo è spesso finita nel mirino per decisioni che hanno generato attriti con le politiche nazionali. Nel 2005, ha stabilito che il divieto assoluto imposto dal Regno Unito al voto dei detenuti violava il diritto a elezioni libere, una sentenza accusata di aver oltrepassato le prerogative della Corte, ledendo l’autorità del Parlamento britannico. Negli ultimi mesi, le tensioni si sono acuite sempre col Regno Unito, dove il governo sta affrontando livelli record di immigrazione clandestina. Il primo ministro britannico, Keir Starmer ha escluso il ritiro dalla Convenzione, ma ha anche dichiarato che la Convenzione deve essere «adeguata alle sfide di oggi», mentre il Partito Conservatore ha avviato una revisione sull’ipotesi di uscita dalla Convenzione, e Reform Uk ha proposto di sostituirla con una Carta dei diritti nazionale.
Inoltre, nove Stati membri dell’Ue, guidati da Italia e Danimarca, hanno sottoscritto una lettera aperta in cui chiedono un riesame delle modalità con cui la Corte di Strasburgo interpreta le disposizioni della Convenzione, denunciando come certe sentenze abbiano limitato la capacità dei governi di esercitare il propio legittimo potere in materia di sicurezza e immigrazione. «Riteniamo che l’evoluzione nell’interpretazione della Corte abbia, in alcuni casi, ristretto la nostra capacità di adottare decisioni politiche nelle nostre democrazie», si legge nella lettera, che mette in guardia contro i rischi che tali limitazioni comportano per la protezione delle società di fronte alle sfide contemporanee. I Paesi firmatari (tra cui figurano anche Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia) hanno evidenziato casi di espulsione di cittadini stranieri condannati per reati penali, sostenendo che l’applicazione della Convenzione abbia «portato a tutelare le persone sbagliate e imposto troppe restrizioni alla capacità degli Stati di decidere chi espellere dal proprio territorio».
In risposta, il segretario generale del Consiglio, Alain Berset, ha lanciato l’allarme rischio-politicizzazione della Corte di Strasburgo, confermando, nella sostanza, che la Corte stessa debba essere al di sopra della politica e dei governi democraticamente eletti (e quindi confermando che le critiche degli Stati firmatari della lettera aperta sono fondate). Le organizzazioni per i diritti umani ribadiscono che la Convenzione garantisce diritti minimi e inalienabili, come il divieto assoluto di tortura e trattamenti inumani (che peraltro nessuno mette in discussione) che non possono essere sospesi in nessuna circostanza.
In risposta, il segretario generale del Consiglio, Alain Berset, ha lanciato l’allarme rischio-politicizzazione della Corte di Strasburgo, confermando, nella sostanza, che la Corte stessa debba essere al di sopra della politica e dei governi democraticamente eletti (e quindi confermando che le critiche degli Stati firmatari della lettera aperta sono fondate). Le organizzazioni per i diritti umani ribadiscono che la Convenzione garantisce diritti minimi e inalienabili, come il divieto assoluto di tortura e trattamenti inumani (che peraltro nessuno mette in discussione) che non possono essere sospesi in nessuna circostanza.
L’agenzia europea per le frontiere, Frontex, ha riferito il 7 agosto che gli attraversamenti irregolari delle frontiere dell’Ue hanno raggiunto quota 95.200 nei primi sette mesi del 2025. Nel Regno Unito, quest’anno sono stati registrati oltre 29 mila attraversamenti clandestini del Canale della Manica, accompagnati da un crescente arretrato di domande di asilo. I capi di Stato e di governo europei, nella loro lettera aperta, hanno sottolineato di rappresentare un ampio spettro politico – da Giorgia Meloni alla danese premier di centrosinistra Mette Frederiksen – che condivide la convinzione bipartisan che le convenzioni internazionali debbano essere ripensate. Nel Regno Unito, l’ex ministro dell’Interno Jack Straw (di sinistra) ha dichiarato al Financial Times il suo Paese dovrebbe «sganciarsi» dalla Convenzione per consentire le espulsioni, sostenendo che negli anni ’90 non era stato previsto questo «abuso» della Convenzione.
In casi urgenti, la Corte può infatti emettere misure cautelari, quando esista un rischio imminente di danno irreparabile, come tortura, morte o trattamenti degradanti. Queste misure sono temporanee ma giuridicamente vincolanti. Il piano del Regno Unito, annunciato nell’aprile 2022, di trasferire alcuni richiedenti asilo in Ruanda ha messo in luce questo potere. Due mesi dopo, la Corte di Strasburgo ha bloccato il primo volo programmato, innescando una serie di ricorsi. I tribunali britannici hanno infine dichiarato il piano illegale, con la Corte Suprema che, nel novembre 2023, ha stabilito che il Ruanda non fosse una destinazione “sicura”.
A titolo di comparazione, gli Stati Uniti (che non aderiscono alla Convenzione) hanno siglato ad agosto un accordo con il Ruanda per accogliere fino a 250 migranti espulsi, che non saranno cittadini né americani né ruandesi. Episodio che Robert Oulds, direttore del think tank britannico Bruges Group, ha così commentato a The Epoch Times Usa: «Gli Stati Uniti sono più disposti ad agire unilateralmente per difendere i propri interessi. Non si lasciano vincolare da trattati che non servono più il loro interesse nazionale» mentre, ha aggiunto, «nel Regno Unito ci aggrappiamo alla fantasia di una “leadership globale”, facendo cose che ci danneggiano nella speranza di ottenere l’approvazione di altri Paesi».
A titolo di comparazione, gli Stati Uniti (che non aderiscono alla Convenzione) hanno siglato ad agosto un accordo con il Ruanda per accogliere fino a 250 migranti espulsi, che non saranno cittadini né americani né ruandesi. Episodio che Robert Oulds, direttore del think tank britannico Bruges Group, ha così commentato a The Epoch Times Usa: «Gli Stati Uniti sono più disposti ad agire unilateralmente per difendere i propri interessi. Non si lasciano vincolare da trattati che non servono più il loro interesse nazionale» mentre, ha aggiunto, «nel Regno Unito ci aggrappiamo alla fantasia di una “leadership globale”, facendo cose che ci danneggiano nella speranza di ottenere l’approvazione di altri Paesi».
Ma i casi sono numerosi: nel 2021, la Danimarca ha approvato una legge che consente di trasferire i richiedenti asilo in Paesi terzi per l’esame delle loro domande, ispirandosi al modello ruandese. La misura, non ancora attuata, potrebbe attivare il blocco da parte della Corte. In Belgio, Nizar Trabelsi, cittadino tunisino condannato per terrorismo, è stato rimpatriato ad agosto dopo anni di battaglie legali e di reclusione negli Stati Uniti, dove era stato estradato nonostante una sentenza della Corte. Il 3 settembre, il ministro per l’immigrazione, Anneleen van Bossuyt, ha dichiarato all’emittente Vrt: «Io trovo sorprendente che si presti costante attenzione ai suoi diritti, e a cosa potrebbe accadere a lui. Io, piuttosto, sono preoccupata per il pericolo che questa persona rappresenta per la sicurezza dei nostri cittadini».
Articoli attuali dell'autore
24 novembre 2025
Usa e Ue discutono di dazi su acciaio e cooperazione energetica
02 novembre 2025
Reti elettriche sempre più in crisi a causa del solare