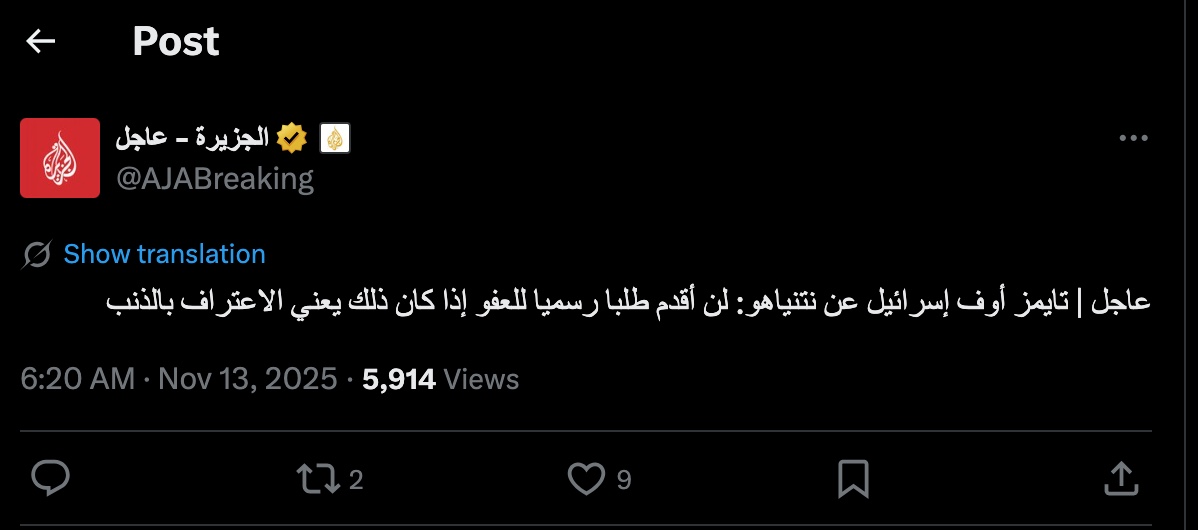I rappresentanti del governo kazako hanno annunciato il 6 novembre che il Kazakistan aderirà agli Accordi di Abramo. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha definito la decisione «un passo decisivo verso la costruzione di ponti fra le nazioni» e ha sottolineato che il Kazakistan è il primo Stato a aderire agli Accordi durante il suo secondo mandato.
Alcuni analisti ritengono la scelta in larga misura simbolica, poiché il Kazakistan intrattiene già relazioni diplomatiche con Israele e limitati scambi economici.
Ma l’adesione riveste un significato strategico più vasto. L’ingresso anche di una piccola repubblica dell’Asia centrale contribuisce a allargare l’influenza diplomatica statunitense e a estendere la presenza americana in una regione storicamente contesa dalla Russia e oggi sempre più corteggiata dalla Cina. Al tempo stesso, consolida la leadership americana nella costruzione di un sistema internazionale di alleanze.
Fonti ufficiali di Washington hanno precisato che l’intesa favorirà la cooperazione israelo–kazaka nei settori della difesa, della sicurezza informatica, dell’energia e delle tecnologie alimentari. Trump ha aggiunto che «altri Paesi sono in fila per aderire».
L’annuncio è giunto alla vigilia del vertice organizzato alla Casa Bianca con i capi di Stato e di governo delle cinque nazioni dell’Asia centrale: Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan. In vista dell’incontro, il ministro degli Esteri americano Marco Rubio aveva incontrato il presidente kazako Kassym-Jomart Tokayev per discutere il rafforzamento degli scambi commerciali, degli investimenti e della cooperazione nei settori dell’energia, della tecnologia e delle infrastrutture.
L’intesa per la tregua fra Israele e Hamas mediata da Trump, ha riaperto lo spazio politico per rilanciare gli Accordi di Abramo, avviati nel 2020 con Emirati Arabi Uniti e Bahrein e successivamente estesi al Marocco e, in attesa di ratifica, al Sudan. L’adesione del Kazakistan potrebbe ora aprire la strada ad altri Paesi turcofoni del Caucaso e dell’Asia centrale. Questi Stati vedono infatti un avvicinamento agli Stati Uniti e a Israele – e un contemporaneo allontanamento dall’asse Cina-Russia-Iran – come una scelta strategicamente vantaggiosa. Gli Accordi di Abramo si sono trasformati in uno dei pilastri di una crescente coalizione filoamericana fra Paesi a maggioranza musulmana.
Partecipando all’iniziativa, il Kazakistan si inserisce negli obiettivi strategici di Washington volti a garantire la sicurezza delle catene di approvvigionamento di minerali di importanza strategica e a ampliare l’accesso alla rotta commerciale transcaspica, nota anche come “Middle Corridor”. Questo collegamento tra l’Asia centrale e l’Europa, che evita Russia e Iran, si rafforza come alternativa strategica per l’Occidente nel contesto dei conflitti in Ucraina e in Medio Oriente.
Le grandi risorse minerarie del Kazakistan – tra cui terre rare, litio, tungsteno e rame – lo rendono un partner prezioso per gli Stati Uniti, nell’ambito della riduzione della dipendenza dalla Cina, che oggi fornisce agli Stati Uniti circa il 70 per cento delle importazioni di terre rare.
Per Astana, la cooperazione con Washington si inserisce nella sua politica estera “multivettoriale”, che mira a mantenere un equilibrio tra Russia, Cina e Occidente per preservare la propria sovranità. Con l’influenza russa indebolita dalla guerra in Ucraina e la presenza economica cinese in espansione, l’adesione agli Accordi di Abramo consente al Kazakistan di approfondire i legami con gli Stati Uniti senza provocare apertamente i due potenti vicini.
L’inclusione di Paesi dell’Asia centrale estende gli Accordi oltre la loro originaria dimensione arabo–israeliana, proiettandoli nel più vasto spazio eurasiatico. Azerbaigian e Uzbekistan, che intrattengono già stretti rapporti con Israele, sono considerati possibili prossimi aderenti, mentre l’Arabia Saudita continua a manifestare interesse verso la normalizzazione.
Per gli Stati Uniti, questo allargamento rappresenta un progresso strategico nella competizione con la Cina. Gli Stati a maggioranza musulmana che rafforzano i legami con Israele attraverso gli Accordi tendono a allinearsi, almeno sul piano implicito, con l’ordine economico e militare sostenuto da Washington. Ogni nuovo membro consolida la presenza americana in regioni dove Pechino si è finora limitata a un’influenza economica di tipo transazionale. Il Kazakistan costituisce quindi un successo diplomatico per gli Stati Uniti, capace di controbilanciare tanto il predominio cinese negli investimenti quanto la leva di sicurezza russa in Asia centrale.
La solidità degli Accordi di Abramo indebolisce inoltre la propaganda cinese che descrive Washington come forza destabilizzatrice. Sebbene Xi Jinping abbia cercato di accreditare la Cina come mediatore internazionale – in particolare con la riconciliazione tra Arabia Saudita e Iran del marzo 2023 – i risultati sono stati limitati. Al contrario, la Casa Bianca ha rivendicato, nella documentazione ufficiale, che Trump «ha contribuito a porre fine a almeno otto conflitti», fra cui la guerra tra Israele e Hamas.
E mentre gli Accordi di Abramo continuano a produrre risultati concreti (intese di normalizzazione diplomatica, incremento degli scambi commerciali, nuovi voli diretti, cooperazione tecnologica e energetica, e una più stretta cooperazione in materia di sicurezza) la credibilità del regime cinese nel mondo musulmano risulta invece appannata.
Il rapporto delle Nazioni Unite del 2022 sullo Xinjiang ha denunciato «gravi violazioni dei diritti umani», e diverse organizzazioni continuano a criticare l’impunità del regime comunista cinese. Questo mentre altre società cinesi risultano implicate in trasferimenti tecnologici, vendite di armamenti e forniture al regime militare birmano, accusato di atrocità contro la minoranza musulmana rohingya.
Il ruolo del regime cinese in Medio Oriente resta prevalentemente economico, centrato su forniture di petrolio e progetti infrastrutturali, mentre la sua influenza militare rimane marginale. Gli Stati Uniti, per contro, conservano un apparato di cooperazione militare irrinunciabile per la stabilità regionale, garantendo la difesa di alleati fondamentali come Arabia Saudita, Giordania, Egitto e Israele.
Washington dispone inoltre di basi militari strategiche in Qatar, Bahrein, Kuwait ed Emirati Arabi Uniti, oltre a sostenere e addestrare le forze armate irachene e a coordinare le operazioni antiterrorismo in Siria. Intanto, le iniziative cinesi di ricostruzione, soprattutto in Siria, si sono in gran parte arenate, rafforzando la persistente preminenza americana nei settori della difesa, dell’intelligence e della sicurezza regionale.
Il nuovo impulso agli Accordi di Abramo evidenzia l’evoluzione dell’architettura geopolitica mondiale. Non più confinati alla normalizzazione tra Stati mediorientali, gli Accordi si sono trasformati in uno strumento strategico di competizione fra Stati Uniti e Cina. Estendendosi a nuove regioni e coinvolgendo Stati a maggioranza musulmana, rafforzano la posizione americana e limitano la dipendenza dalle dinamiche economiche e diplomatiche del regime cinese.