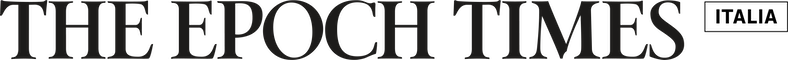Il 29 aprile, a quattro settimane dall’introduzione dei suoi primi dazi, Donald Trump diceva agli operai del Michigan: «Dopo decenni di politici che hanno sacrificato Detroit a favore di Pechino, finalmente alla Casa Bianca c’è un vero difensore dei lavoratori».
Anche nel suo primo mandato, Donald Trump aveva dato una netta rottura col “vecchio” Partito repubblicano. Con le sue politiche protezionistiche — il pilastro del suo programma “America first” — il presidente americano ha saputo attirare fra i sostenitori del partito conservatore anche un nuovo segmento sociale: quello dei lavoratori sindacalizzati.
Shawn Steel, dirigente del partito repubblicano, ha commentato a Et Usa dicendo che grazie a Trump il “Grand Old Party” è diventato il partito della classe operaia: «Trump insegna ai repubblicani alla “Country Club”, al ceto medio, a collaborare e schierarsi con la classe lavoratrice», una cosa che «non succedeva da 120 anni». E i risultati si vedono, dice il dirigente repubblicano: «La nostra formazione politica sta ottenendo risultati migliori rispetto ai democratici fra gli uomini delle classi lavoratrici», e non a caso, perché un tempo «il Partito repubblicano riuniva insieme agricoltori, commercianti, allevatori e operai, e ora Trump ha recuperato quello spirito originario».
The Donald ha trasformato il partito repubblicano in un modo che prima di lui sarebbe stato impensabile. Ha saputo coniugare i principi classici dei conservatori — quali meno tasse, deregulation, energia abbondante e a basso costo — con le tipiche politiche degli avversari di sinistra, fra cui dazi e persino la presenza pubblica nelle imprese private.
Ma Trump evita di racchiudere le sue scelte in rigide categorie teorico/ideologiche – come fanno invece i “politici di professione” – per identificarle piuttosto sul piano pragmatico: lui le definisce soluzioni di “buon senso”. Un’impostazione nuova, dietro cui si sono via via allineati numerosi politici repubblicani.
Trump ha anche voluto una maggiore presenza pubblica nei settori strategici per la sicurezza nazionale, segnando un cambiamento di rotta significativo: la sua amministrazione ha acquisito partecipazioni azionarie in diverse aziende, fra cui il colosso dei semiconduttori Intel, il produttore di terre rare Mp Materials, la società mineraria Trilogy Metals e il gruppo Lithium Americas.
Il governo federale, inoltre, ha ottenuto il golden power in Us Steel nell’ambito della fusione con la giapponese Nippon Steel. Sempre nell’ottica di rafforzare la filiera interna, Trump ha negoziato accordi sulla ripartizione degli introiti con produttori di processori come Nvidia e Advanced Micro Devices.
L’amministrazione Trump spiega l’intervento pubblico come una risposta inevitabile all’aggressività commerciale del regime cinese: una necessità per combattere ad armi pari insomma, utile anche a recuperare rapidamente il terreno perduto nell’ultimo quarto di secolo, quando le classi dirigenti occidentali si crogiolavano nell’illusione di potersi arricchire (impunemente) sfruttando il cosiddetto “comunismo alla cinese”.
In politica estera, il programma “America first” è molto distante dalla strategia interventista (per non dire guerrafondaia) della precedente stirpe di repubblicani. Un cambiamento reso evidente durante la visita alle nazioni del Golfo avvenuta nel maggio 2025, quando il presidente americano ha criticato apertamente le (fallimentari) operazioni di “esportazione della democrazia” in Medio Oriente dei neocon dell’amministrazione Bush-figlio, guidata dai falchi Dick Cheney e Donald Rumsfeld. Parlando a Riad, Trump ha ironizzato sugli occidentali che «insistono nel voler insegnare agli altri come vivere» e che nel frattempo «distruggono più Paesi di quanti ne costruiscano».
A differenza del neo-conservatorismo guerrafondaio dei primi anni 2000, inoltre, la politica estera “America first” privilegia l’emisfero occidentale quale area di primario interesse per gli Stati Uniti.
Le scelte di Trump hanno trovato largo consenso nella classe operaia americana – evidentemente molto meno indottrinata dal marxismo di quella europea – che un tempo rappresentava la forza trainante del Partito democratico. L’analisi del voto delle presidenziali 2024 evidenzia come gli appartenenti alla classe operaia (intesa come cittadini privi di titolo universitario) abbiano preferito Trump a Kamala Harris con un margine di sei punti percentuali. Un record, considerando che la Harris godeva dell’appoggio più totale dell’intero establishment politico-mediatico americano.
Questo capovolgimento di fronte rappresenta un elemento cruciale della rinascita del partito repubblicano statunitense: la base operaia e i cittadini più sfortunati, dopo decenni di illusioni (e menzogne) propinati loro dalla sinistra, ora hanno una valida alternativa. Tutto quello che d’ora in poi il Grand Old Party dovrà fare è continuare sulla strada tracciata da Donald Trump: restare fedele a questo ritorno alle proprie origini. In occasione di una cena organizzata dalla Testata conservatrice American Spectator lo scorso maggio, il senatore Jim Banks ha rimarcato come il legame di Trump con la classe operaia sia stato un «dono» al Partito Repubblicano, dicendo: «È stata la classe lavoratrice, con ancora maggiore intensità rispetto al 2016, a riconfermare Trump alla Casa Bianca nel 2024».
Nel panorama politico statunitense si stanno manifestando cambiamenti sociali e demografici epocali. Ri-orientando le priorità del Partito repubblicano verso i valori fondanti della repubblica statunitense, e basandosi sul semplice «buon senso», Donald Trump ha ridato voce alla vera America.