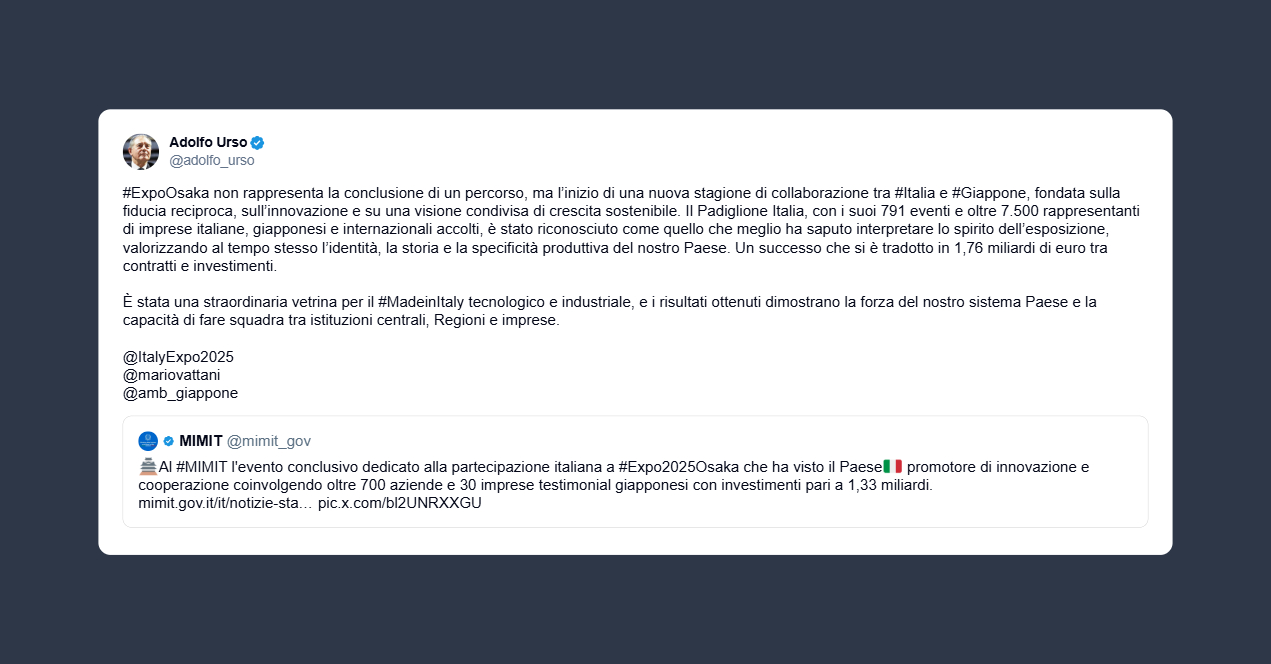Una legge per semplificare la legge di semplificazione del sistema normativo italiano. Non è uno scioglilingua, ma la sintesi del disegno di legge approvato in via definitiva il 29 ottobre alla Camera dei Deputati. Proposto dal ministro per le Riforme istituzionali e la Semplificazione Maria Elisabetta Alberti Casellati (Forza Italia), il testo introduce una «legge di semplificazione normativa» annuale, con cui il Governo punta a riordinare e snellire lo sconfinato apparato di norme italiane. Il tentativo è quello di migliorare una legge in vigore dal 1997, introdotta dal primo governo di Romano Prodi, ma che non ha mai funzionato davvero, secondo gli esperti, per via della complessità del procedimento e nelle scadenze troppo rigide da esso imposte.
Ma quali novità introduce la legge? Ogni anno, entro il 30 giugno (un mese più tardi rispetto alla norma precedente), il Governo dovrà presentare un disegno di legge di semplificazione normativa basato su proposte raccolte entro il 30 aprile dai ministeri competenti, ma anche da consultazioni pubbliche con sindacati e associazioni di categoria; prima della presentazione del ddl in Parlamento, la Conferenza Unificata, un organo di coordinamento fra lo Stato e gli enti territoriali (Regioni, Province, Comuni), è tenuta a esprimere un parere obbligatorio sul testo. Questo ulteriore passaggio è funzionale a favorire la collaborazione e l’intesa fra i diversi livelli di governo quando una materia tocchi competenze condivise.
Il disegno di legge conferisce all’Esecutivo delle deleghe legislative, purché «nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali», sostanzialmente dei “paletti” per circoscrivere la discrezionalità del legislatore delegato. Il Governo dovrà infatti riordinare le norme «per settori omogenei» mediante la redazione o l’aggiornamento di codici di settore o testi unici, «assicurando l’unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la semplicità della disciplina»; dovrà provvedere al «coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti», garantendo la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e semplificando il linguaggio normativo; quando possibile, Palazzo Chigi sarà tenuto a varare disposizioni di immediata applicazione, limitando il rinvio a successivi provvedimenti di attuazione; dovrà poi provvedere alla «abrogazione espressa» delle norme che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo, e favorire «la riduzione di oneri e di adempimenti non necessari».
Un’altra novità è l’introduzione della Valutazione di impatto generazionale (Vig), in attuazione di una delle promesse contenute nel programma elettorale del centrodestra del 2022. Si tratta di un’analisi preventiva delle conseguenze dei nuovi atti normativi (esclusi i decreti legge) sulle generazioni più giovani. A tale scopo sarà istituito, presso la Presidenza del Consiglio, un osservatorio di esperti incaricato di monitorare «la promozione dell’equità intergenerazionale».
La legge voluta dal ministro Casellati prevede anche disposizioni per la digitalizzazione della produzione normativa, tramite l’adozione di formati digitali standardizzati per tutti i testi normativi e regolamentari e l’aggiornamento del Codice dell’Amministrazione Digitale (Cad),il testo unico che disciplina l’uso delle tecnologie digitali nella Pubblica Amministrazione. L’obiettivo è quello di rendere più accessibile e coerente il corpus normativo. In Italia, infatti, una delle cause della complessità del sistema legislativo è anche la frammentazione dei testi: le leggi e i regolamenti sono pubblicati in formati e banche dati diversi, spesso non coordinati tra loro, con difficoltà di aggiornamento e accesso anche per chi deve applicarli, come funzionari, imprese, o cittadini.
Tra le deleghe al Governo previste dalla legge, spicca quella in materia di Istruzione, come enunciato dall’articolo 15 (Capo III) del testo. È uno degli articoli più concreti e “operativi”, perché riguarda direttamente la Scuola e il Ministero dell’Istruzione e del Merito. L’obiettivo è riordinare e semplificare la complessa normativa che oggi disciplina l’istruzione, frammentata in centinaia di decreti, regolamenti e leggi stratificate. Il Governo, su delega del Parlamento, dovrà quindi adottare uno o più decreti legislativi per raccogliere e coordinare tutte queste norme in testi unici — cioè in raccolte organiche e coerenti di disposizioni su un unico argomento.
Il disegno di legge sulla Semplificazione normativa è tutt’altro che “semplice”, e si inserisce in un quadro altrettanto complesso e intricato. In Italia esiste un numero monstre di leggi in vigore, tale che nessuno riesce a quantificarne esattamente la cifra. Anche perché bisogna distinguere tra norme formali (non abrogate) oppure sostanziali (effettivamente operative), e il conteggio cambia se si includono solo le leggi nazionali, oppure anche quelle regionali, provinciali, comunali. Molte leggi, inoltre, sono modifiche o integrazioni di leggi precedenti.
In un’intervista al Corriere della Sera, nel 2022, il ministro della Giustizia Carlo Nordio ne ha contate 250mila, commentando che «più lo Stato è corrotto, più sforna leggi».
Secondo Normattiva – una banca dati online che opera dal 2010, curata dall’Istituto poligrafico e zecca dello Stato italiano – dal marzo 1861 al dicembre 2022 in Italia sono entrati in vigore 203.068 atti normativi, tra leggi, regi decreti, decreti reali, decreti risalenti al fascismo, e altre tipologie oggi in disuso. Molti di questi provvedimenti sono stati abrogati o sono decaduti, ma non tutti. Risultano ancora in vigore, per esempio, diversi “decreti del Duce del Fascismo”, come il n. 117 del 1 marzo 1943, relativo alla produzione, al collocamento e alla vendita del seme del baco da seta, oppure il n. 380 dello stesso anno, che regola la produzione dei “rigenerati del cuoio”. E l’unico modo per sapere quanti degli oltre 200 mila atti presenti nella banca dati siano ancora in vigore, è cliccare su ognuno di essi per verificare singolarmente l’eventuale vigenza.