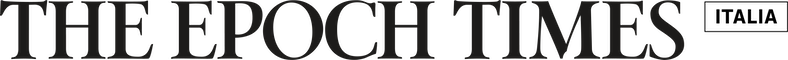COMMENTI
Il fallimento del modello neo-keynesiano applicato nella Cina comunista

Container provenienti dalla Cina nel porto di Los Angeles, a San Pedro, California, Stati Uniti, 1 maggio 2025. REUTERS/Mike Blake/Foto d'archivio
Negli ultimi dieci anni, l’economia cinese ha potenziato un modello neo-keynesiano centralizzato, incapace di reggere senza un accordo commerciale. Il settore manifatturiero dipende dal vasto surplus commerciale con gli Stati Uniti. L’eccesso di capacità produttiva non è un’eccezione: è una costante. Secondo la Cheung Kong Graduate School of Business, la Cina produce il 30% dei beni manifatturieri mondiali, consumandone meno del 18%. Nel primo trimestre del 2025, il tasso di utilizzo della capacità industriale è scivolato al 74,1%.
La pianificazione centralizzata keynesiana mira a garantire piena occupazione e crescita economica, nonostante vincoli finanziari e un indebitamento eccessivo. Per farlo, deve collocare la produzione interna in eccesso sul mercato estero, per rispondere alle gravi carenze di capitale circolante. Pechino ha riconosciuto indirettamente il problema, ponendo la competizione “involutiva”, cioè eccessiva e inefficiente, tra le priorità delle politiche economiche del 2025, con misure per limitare investimenti ridondanti e regolare l’espansione produttiva in alcuni settori. Ma l’eccesso di capacità non è casuale: deriva da scelte politiche deliberate, con autorità locali e nazionali che spingono la crescita del prodotto interno lordo a ogni costo.
Questo modello cerca di mantenere occupazione e crescita anche a scapito di rendimenti inferiori al costo del capitale, e funziona solo se l’eccesso produttivo trova sbocco sui mercati internazionali, ottenendo valuta di riserva e contenendo i costi attraverso il trasferimento del capitale circolante dai consumatori del resto del mondo, controlli valutari e tassi di cambio fissati. Ma l’aumento del debito, il progressivo indebolimento della moneta e i crescenti problemi di fallimenti e liquidità minacciano di far crollare questo sistema, anche senza una recessione formale.
La Cina ha capito di non poter resistere a una guerra commerciale né di poter rimpiazzare gli Stati Uniti — il mercato più ricco e vasto — con quello europeo o latino-americano. Ha quindi necessità impellente di un accordo commerciale per eivtare che la catena di fallimenti, in corso dal 2021, sfoci in una crisi finanziaria conclamata. Ad aprile 2025, la deflazione persiste per il terzo mese consecutivo. Secondo Allianz, i fallimenti delle imprese cresceranno del 7% nel 2025 e del 10% nel 2026, nonostante i nuovi stimoli fiscali.
Le piccole e medie imprese, soprattutto quelle orientate all’export, stanno fallendo a rotta di collo a causa del calo dei flussi di cassa e della revoca delle esenzioni dai dazi Usa. Nelle regioni dipendenti dalle esportazioni, i licenziamenti aumentano, con un tasso di disoccupazione urbana previsto al 5,7% nel 2025, superiore all’obiettivo ufficiale, come riportato dalla Cnbc. L’indice Pmi manifatturiero ufficiale del National Bureau of Statistics è precipitato a 49,0 ad aprile 2025, il calo più netto da dicembre 2023, segnando una contrazione di produzione, ordini e occupazione, con gli ordini esteri al minimo da almeno 11 mesi.
Il crollo del settore immobiliare, che un tempo valeva fino al 30% del prodotto interno lordo, ha indebolito il sistema bancario, ridotto la ricchezza delle famiglie e innescato un effetto patrimoniale negativo, deprimendo consumi e domanda di credito. Le forze dell’economia cinese sono evidenti, ma le fragilità risultano troppo gravi per essere trascurate. Questo scenario evidenzia l’inefficacia della pianificazione centralizzata. Le debolezze attuali derivano da anni di politiche governative focalizzate sulla costruzione di infrastrutture e beni, nella speranza di venderli in futuro.
A ciò si aggiungono l’ondata di fallimenti, il tracollo del mercato immobiliare e l’indebitamento delle amministrazioni locali, che mettono a dura prova il sistema finanziario, proprio mentre i prestiti insoluti della Nuova Via della Seta esplodono: Paesi come Sri Lanka, Zambia, Ghana e Pakistan, coinvolti nell’iniziativa, sono andati in default o hanno richiesto salvataggi del Fondo monetario internazionale, con un debito non contabilizzato di 385 mila miliardi di dollari generato dal progetto.
Le politiche keynesiane conducono inevitabilmente a debito elevato e stagnazione. Quando integrate in un sistema di pianificazione centralizzata, con un’economia finanziaria chiusa e controlli sui capitali, generano un mix pericoloso di eccesso produttivo, impoverimento e inefficienza economica.
Copyright Epoch Times
Articoli attuali dell'autore
26 giugno 2025
L’Iran è sempre più isolato in Medio Oriente