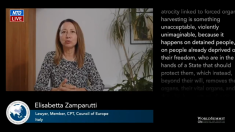Esiste un fenomeno riconosciuto a livello scientifico solo da qualche decennio, ma il cui utilizzo risale all’alba dei tempi: l’effetto placebo, ‘la medicina più antica del mondo’, è concettualmente piuttosto semplice ma allo stesso tempo potente, al punto da lenire il dolore di una malattia o durante una terapia.
Per spiegare approfonditamente questo fenomeno e i fattori che concorrono a determinarlo, Epoch Times ha intervistato Luana Colloca, medico con dottorato di ricerca in neuroscienze che ricopre l’incarico di professore associato all’Università del Maryland, presso la School of Nursing and School of Medicine of Baltimora. La dottoressa Colloca, che da diversi anni svolge un’intensa ricerca sul placebo, ha scoperto che questo effetto può essere indotto anche da alcuni fattori sociali, a volte strettamente connessi al medico curante.
In che cosa consistono l’effetto placebo e nocebo?
L’effetto placebo è un cambiamento in un sintomo clinico, legato alle aspettative del paziente e al contesto psicosociale in cui viene svolto il trattamento. Mentre l’effetto placebo può rafforzare e migliorare i sintomi, l’effetto nocebo è l’opposto. Viene chiamato il ‘gemello cattivo’ del placebo poiché le aspettative negative – la paura dei sintomi – possono peggiorare il dolore e la sintomatologia.
Si sta quindi parlando di cambiamenti clinici ma anche comportamentali in soggetti sani e sono correlati ai sistemi discendenti dell’organismo, che modulano percezioni, sintomi ed esperienze.
Quali sono i fattori che concorrono a determinare questi due effetti?
Innanzitutto sono fenomeni molto complessi che si verificano anche negli animali. Esistono diversi fattori. In particolare, nell’uomo si tende a riassumere tutto intorno all’aspettativa, intendendo con questo termine l’anticipazione di una situazione positiva o negativa. L’aspettativa è un fattore cognitivo importante che circonda la vita dell’uomo, dal programmare una vacanza all’amare una persona.
Bene, queste aspettative possono essere rilevanti anche in ambito clinico. Anche quando non si è completamente consci di avere un’aspettativa, esistono dei meccanismi collegati ad aree del cervello meno evolute dal punto di vista cognitivo (ma comunque estremamente forti perché fanno parte dell’evoluzione dell’uomo) che vengono attivati. Questi sono fattori di condizionamento correlati soprattutto alla memoria.
Pertanto, nel momento in cui si fa un’associazione, come per esempio quella tra il camice bianco e un farmaco o il colore di una pillola e il suo effetto, si impara ad associare al cosiddetto stimolo condizionante (per esempio il colore della pillola) uno stimolo incondizionato (l’effetto della medicina di cui è fatta la pillola). E nel momento in cui l’essere umano vede qualcosa di simile o identico, risponde con lo stesso effetto. Questa è la scoperta di Pavlov del 1927, che ancora oggi costituisce la base del condizionamento, dato che può modificare la risposta al trattamento terapeutico. Per fare un esempio, quando andiamo dal dentista il suono del trapano può scatenare delle risposte di paura e ansia. Oppure se una persona sottoposta a un trattamento chemioterapico entra in una stanza con un colore associato al trattamento, può provare la tipica nausea dovuta alla chemioterapia, senza però essere stata ancora sottoposta a questo genere di cura.
L’apprendimento, l’empatia e il comportamento sociale sono anch’essi fattori. Può spiegare meglio il loro ruolo?
Sono contenta di questa domanda perché nel 2009 abbiamo messo in discussione il modello classico in vigore dal 1980, che vedeva l’effetto placebo legato solo all’aspettativa e al condizionamento. La cosa interessante è che abbiamo notato come l’empatia per un’altra persona, che è alla base delle relazioni interpersonali, costituisca uno stimolo così forte da indurre risposte placebo. Per esempio, in laboratorio abbiamo invitato un collega in cui simulava un effetto analgesico sotto un particolare stimolo. Senza utilizzare alcun condizionamento, abbiamo invitato alcuni volontari sani a osservare quanto succedeva in laboratorio. In seguito abbiamo testato gli stessi soggetti ma con alti livelli di dolore sperimentale, utilizzando degli shock elettrici per indurre uno stimolo dolorifico fasico.
Che cosa significa ‘fasico’?
Che dura poco, nell’ordine di qualche millisecondo. In laboratorio dobbiamo indurre degli stimoli dolorifici per studiare l’aspetto discendente della modulazione del dolore. Ma il dolore deve essere accettabile. È importante prestare attenzione agli aspetti etici; sono persone che in laboratorio trascorrono diverse ore e, dal punto di vista etico, ricevere uno stimolo dolorifico fasico rispetto a uno tonico è molto più accettabile.
Ok, riprendiamo il discorso
Bene, l’osservazione di una persona che riceveva un trattamento analgesico, ha prodotto forti risposte placebo nonostante le persone ricevessero stimoli dolorifici. Dal 2009, altri team scientifici hanno dimostrato e confermato questi dati, sia nell’ambito dell’effetto placebo che nocebo. Pertanto, l’osservazione, l’empatia e quello che definiamo apprendimento sociale, sembrano fattori molto forti, in misura maggiore rispetto all’aspettativa generata da istruzioni o informazioni verbali. Abbiamo quindi introdotto il concetto secondo cui le relazioni interpersonali, l’empatia e l’aspetto sociale siano estremamente importanti nel produrre risposte placebo.
Esiste un effetto placebo inconsapevole?
Assolutamente sì. È un aspetto a cui sono molto interessata e che ritengo sia molto collegato alla coscienza. Abbiamo valutato l’effetto placebo analizzando degli studi retrospettivi: anche i neonati o gli animali producono effetti placebo importanti. In questo caso le parole servono poco. Piuttosto è l’esperienza, intesa come associazione tra stimolo condizionante e incondizionato, a giocare un ruolo importante. Non abbiamo condotto alcuna ricerca sull’aspetto sociale, ma riteniamo che l’osservazione e l’apprendimento sociale siano anch’essi cruciali nel modulare la risposta placebo in neonati, bambini e animali.
In quale modo può essere sfruttato un placebo nella guarigione?
Innanzitutto è importante chiarire che non è possibile trattare le malattie con il placebo. È difficile pensare che sia possibile cambiare un quadro patologico e certamente i placebo non vengono utilizzati in presenza di malattie gravi. Ma alcune malattie degenerative come il Parkinson o il dolore cronico possono migliorare attraverso un placebo: dalla cura del contesto, al modo in cui si informa un paziente, al creare aspettative positive oppure creando un’alleanza terapeutica tra medico e paziente. Nello stesso tempo, dal momento che l’aspetto inconscio gioca un suo ruolo nel determinare i sintomi (alla luce di quanto detto prima su aspettativa e condizionamento), probabilmente è possibile prescrivere regimi terapeutici in cui il placebo sostituisce il farmaco attivo. Se questo funzionasse, sarebbe possibile indurre la stessa risposta terapeutica, accettabile, ma con una riduzione della somministrazione del trattamento e degli effetti collaterali.
Vorrei spiegare meglio questo punto. Abbiamo chiamato questo fenomeno dose-extending placebos, appunto Placebo che verrebbero usati per estendere l’azione di un farmaco attivo. Se sfruttassimo questi meccanismi di condizionamento, subconsci o inconsci, potremmo pensare di ridurre il numero di analgesici e ottenere lo stesso beneficio in termini di gestione del dolore. La minore quantità di farmaco attivo permette inoltre di evitare fenomeni di intolleranza e di abuso di farmaci, dove per esempio negli Stati Uniti l’abuso di oppioidi costituisce un problema.
Durante l’effetto placebo, cosa succede nell’organismo a livello biochimico e fisiologico?
È un meccanismo di guarigione spontanea. Come a livello periferico i tessuti possono guarire da una ferita (per esempio un semplice taglio alla mano), allo stesso momento è giusto pensare che i meccanismi cerebrali legati al placebo funzionino nello stesso modo. Esiste insomma una potenzialità nel mettere in atto meccanismi di guarigione che possono essere spontanei. Questi meccanismi sono rilevanti poiché il placebo può innescare il rilascio di sostanze endogene, in particolare endomorfina, una sostanza molto simile alla morfina che si lega agli stessi recettori degli oppioidi, ma anche altre sostanze endogene. La capacità del cervello di rilasciare oppioidi endogeni è estremamente importante poiché dal punto di vista evoluzionistico, il corpo ha la possibilità di ridurre il dolore in maniera spontanea e nello stesso tempo di preservare aree del cervello che possono essere critiche nella modulazione dell’esperienza del dolore.
Personalmente mi piace utilizzare questa espressione – esperienza del dolore – poiché il dolore non è solo un numero, con un’intensità da 1 a 10; piuttosto è un’esperienza. Certamente è quantificabile (appunto 0 pari a nessun dolore e 10 al massimo immaginabile), ma allo stesso momento porta con sé un importante aspetto affettivo ed emozionale. Il dolore interferisce con la vita quotidiana e il cervello possiede dei meccanismi che una volta attivati riducono questa esperienza.
Purtroppo questi meccanismi non vengono attivati in tutti i soggetti nello stesso modo. Alcune persone sono più vulnerabili al dolore e a certi sintomi forti, altre hanno invece fattori protettivi. Il motivo di questa differenza ancora sfugge, ma si sta lavorando in questa direzione per cercare di capire, dal punto di vista psicologico, chimico e genetico, i meccanismi che regolano l’effetto placebo e quindi questa sorta di capacità di guarigione intrinseca che il cervello può mettere in atto.
Sarebbe interessante creare, attraverso la ricerca, un test in cui esiste un identikit della risposta individuale al placebo. L’ideale sarebbe arrivare a capire quando il paziente dispone di una protezione nei confronti del placebo, per mettere in atto delle strategie personalizzate durante il trattamento terapeutico.
Negli studi scientifici è possibile scambiare erroneamente l’effetto placebo per qualche altro fenomeno?
Assolutamente sì. In medicina è importante essere cauti poiché molti pazienti, quando certe risposte vengono scambiate per una effetto placebo, ricevono diagnosi non accurate. È quindi importante stabilire dei confini, delle regole. L’effetto placebo è una conseguenza neurobiologica che è parte delle caratteristiche del paziente, non è isteria o qualcosa di negativo come è stato ampiamente pensato in passato. Non si può quindi negare un trattamento attivo solo perché un paziente tende a essere un soggetto che risponde al placebo. Piuttosto potrebbe essere un aspetto positivo per creare un trattamento terapeutico benefico.
Per quale altro fenomeno può essere scambiato l’effetto placebo?
Malattie legate al soma [al corpo, ndr] e alla psiche possono essere scambiate per un effetto placebo. E poi in passato, nell’ambito delle malattie allergiche, il placebo è stato molte volte utilizzato per innescare una risposta allergica. È stato anche impiegato per indurre attacchi epilettici o altre malattie psichiatriche; veniva in pratica somministrato un placebo per diagnosticare una malattia. Questo comportamento viene attualmente considerato non etico, dal momento che esistono altri metodi per fare diagnosi. Allo stesso momento, nel caso dei placebo esistono altre problematiche. In ambito clinico esiste per esempio la menzogna. Mi domando se sia giusto utilizzare un placebo senza dirlo al paziente. Credo che questi aspetti etici siano rilevanti.
Quali sono i rischi del mentire?
È un argomento che mi sta a cuore e a cui mi sono a lungo dedicata. A livello personale, ho deciso a un certo punto della mia carriera di frequentare due master in bioetica. Esistono soggetti che sono a loro agio nell’ascoltare una menzogna, da quelle più leggere fino a quelle più grosse. In generale la menzogna è ancora utilizzata in ambito clinico; lo scopo e la sua giustificazione è di non fare male al paziente.
Ma mentire è problematico. Abbiamo condotto degli ampi studi, in cui abbiamo intervistato più di ottocento pazienti con malattie croniche. Quando abbiamo domandato, almeno negli Stati Uniti, quanto fossero a loro agio quando il proprio medico dice loro delle bugie, hanno risposto di preferire una comunicazione aperta, in cui eventualmente non sanno il momento in cui ricevono il placebo, ma sono consapevoli di questa pratica. Personalmente, ho scritto molto su questo argomento e sono contraria alla bugia: non è necessaria perché esistono modi diversi per comunicare la stessa informazione.
Tecnicamente parliamo di ‘framing effect’, ossia il modo in cui vengono utilizzate diversi tipi di parole o espressioni per comunicare lo stesso contenuto. Lo scopo è di indurre risposte placebo ed evitare quelle nocebo. Mi viene da pensare che quando si fa una visita al cuore, se la valvola mitralica non funziona correttamente, il cardiologo potrà eventualmente spiegare i meccanismi emodinamici e così via. I pazienti sono pronti ad accettare questo.
Mi chiedo per quale motivo non si possa fare lo stesso con un meccanismo cerebrale quale l’effetto placebo. Si può illustrare ai pazienti che esistono funzioni conosciute che fanno parte dei meccanismi inibitori discendenti della modulazione dei sintomi, come per esempio il dolore, che possono essere attivati grazie a delle risposte placebo. Se si raggiunge questo livello di onestà ma anche di comunicazione tra paziente e medico, è possibile evitare forme di menzogna. Si tratta piuttosto di parlare e presentare gli effetti placebo – e il placebo stesso – in modo aperto.
In passato i medici hanno utilizzato consapevolmente i placebo?
Assolutamente sì ed è il trattamento più antico in medicina. Esistono prove che lo riconducono almeno al 1670; testi in cui Thomas Jefferson racconta che i medici più abili nei trattamenti, usavano una miriade di placebo. La storia del placebo storicamente parlando è affascinante. Sono esistite pillole composte da pane, talco, cenere e di qualunque sostanza che non faceva male, ma che veniva somministrata per trattare i pazienti quando non esisteva un trattamento valido. Mi piace pensare al placebo come un rimedio in extremis, quando non esiste più alcun trattamento. In questo caso è un aspetto molto interessante della storia della medicina.
Ovviamente c’è stata poi una fase in cui dalla volontà di aiutare un paziente si è passati a una più negativa, dove si somministrava un placebo quasi per evitare i pazienti noiosi, ponendo dei limiti a una ottimale relazione medico-paziente. In quel caso, i placebo lenivano delle forme di isteria. Occorre infatti pensare che molte volte i pazienti si aspettano un trattamento e hanno bisogno di ricevere qualcosa. Esiste in questo caso un’aspettativa per un trattamento e la persona ha bisogno di una pillola.
Oggi, spero, siamo a un livello in cui il placebo viene dato con razionalità, se viene somministrato. Sicuramente, non deve essere accompagnato dalla menzogna, ma a un comportamento aperto. In generale mi piace pensare che l’effetto placebo possa essere stimolato senza ricorrere a pillole di zucchero o talco. Abbiamo studiato che esistono numerosi trattamenti e modalità di interazione tra paziente e medico che possono essere messi in atto senza usare un placebo, ma ottenendo comunque un effetto positivo. Pertanto l’effetto placebo è un meccanismo che può essere stimolato e indotto anche senza un placebo.
Quali sono i fattori che causano l’effetto nocebo e come si spiega?
Possiamo spiegare il fenomeno nocebo in chiave evoluzionistica. Abbiamo condotto degli studi in cui è stata paragonata in laboratorio la risposta placebo con quella nocebo. Abbiamo notato che la risposta nocebo, per esempio il dolore, viene messa in atto in maniera rapida e senza la necessità che il soggetta debba fare un’esperienza in merito. Piuttosto, quando abbiamo paragonato questi due effetti provocati da suggestioni verbali e condizionamenti, abbiamo notato che l’effetto nocebo può essere innescato dalla parole. Una parola che porta un connotato simbolico associato a un’esperienza dolorifica importante, può indurre un effetto nocebo.
Insomma, l’uomo induce questo effetto rapidamente e in modo molto più forte rispetto alla risposta placebo, che richiede esperienza.
Abbiamo interpretato questa differenza in termini evoluzionistici: il corpo mette in atto queste risposte per preservarlo da nuovi eventi negativi. Il fatto che queste risposte siano più efficaci e veloci di quelle placebo, è un problema in medicina. Questo perché, durante uno studio, quando si dice al paziente che proverà dolore, si crea un condizione di anticipazione della sofferenza che può essere così forte da aumentare il dolore insito in una procedura chirurgica o in un qualsiasi intervento medico.
Il motivo è da ricercarsi in alcune aree del cervello. Per esempio l’ippocampo contribuisce a modulare queste risposte ed è una delle regioni più antiche del cervello. Di nuovo, ribadisco l’importanza di una comunicazione terapeutica ottimale.
L’ansia gioca un ruolo nocebo?
Sì. In realtà esistono meccanismi specifici che non dipendono dall’ansia. Ma abbiamo notato che i soggetti ansiosi, nevrotici e con l’abitudine a catastrofizzare un evento, tendono ad amplificare l’aspetto nocebo. Queste persone solitamente manifestano maggiormente la risposta nocebo, che a volte è tale da bloccare l’effetto terapeutico di un trattamento.
Per esempio, in Germania durante uno studio è stato utilizzato un potente farmaco per lenire un dolore indotto sperimentalmente. Nel momento in cui è stato detto ai soggetti che il trattamento per via endovenosa sarebbe stato interrotto, ma in realtà non lo era, non è stata riscontrata alcuna risposta al trattamento. Il risultato in questione suggerisce che la consapevolezza al trattamento che non viene somministrato o una situazione che crea un’aspettativa negativa, può annullare la risposta a un trattamento attivo. Questo permette di comprendere l’importanza dell’effetto nocebo durante una pratica clinica.
Come deve essere condotto uno studio scientifico rigoroso di questo tipo?
Oggi siamo fortunati poiché esiste una metodologia ben consolidata. Sappiamo per esempio che nel momento in cui vogliamo parlare dell’aspetto neurobiologico, dobbiamo escludere altri fattori come la possibilità di remissione naturale di un sintomo o cofattori che possono interferire. Nell’ambito di una sperimentazione clinica, il metodo migliore per fare questo è di avere tre gruppi di soggetti sperimentali: un gruppo farmaco attivo, un gruppo placebo e un gruppo che non assume nè un farmaco nè un placebo. In questo modo si identifica la risposta placebo.
Inoltre oggigiorno, dal punto di vista della mappatura del cervello siamo fortunati. Esistono diverse metodologie, come la risonanza magnetica funzionale, la PET, l’elettroencefalografia, la magnetoencefalografia: strumenti che permettono di esplorare le risposte nel cervello a seguito di un evento. E poi esistono altri settori scientifici in crescita, che permettono di studiare dei fattori genetici associati al placebo. Tutto questo consente di condurre studi accurati.
Ovviamente sono studi che richiedono risorse, poiché quando si parla di studi cerebrali o genetici è necessario disporre di un numero adeguato di soggetti e di una metodologia rigorosa e inoltre i costi non sono sempre accessibili.
Negli studi, come si misurano l’effetto placebo e nocebo?
Quando esiste il gruppo placebo e quello che non assume farmaci, si possono paragonare le risposte terapeutiche. Ma è anche semplicemente possibile chiedere ai soggetti di misurare la propria aspettativa di miglioramento. Si usano in questo caso delle scale validate a livello scientifico in cui si domanda al soggetto quanto si aspetta di migliorare o di avere specifici effetti collaterali presenti in una lista. In questo modo, si ricavano informazioni utili a un medico per cercare di identificare quelle condizioni che possono favorire una risposta placebo o nocebo.
Attualmente in medicina vengono utilizzati dei placebo? E quali saranno le prospettive future?
Per quanto mi riguarda, noto che esistono differenze culturali. Il modo in cui vengono visti l’effetto placebo e nocebo cambia in base alla nazione. Per esempio, in Germania è possibile prescrivere un placebo e sono state create delle linee guida per utilizzare farmaci inerti e meccanismi placebo. Negli Stati Uniti sono a conoscenza del fatto che nel pronto soccorso, in casi di dolore acuto viene utilizzato questo trattamento.
In futuro spero che ci siano più normative. Stiamo conoscendo questo fenomeno dal punto di vista neurobiologico: è quindi il caso di rivedere le linee guida dell’American Medical Association [AMA, la più grande associazione di medici e studenti negli Usa; ha il potere di certificare le scuole mediche nazionali, ndr] che ha una nota nel capitolo 29 riservato all’uso dei placebo in ambito medico. Questa parte risale a diversi anni fa e secondo me è importante aggiornarlo. Inoltre è importante avere delle linee guida aggiornate anche a livello internazionale.
Pertanto, se prima non si chiariscono in quali ambiti si può utilizzare il placebo diventa problematico il suo utilizzo, anche da un punto di vista legale (basti pensare agli effetti legati all’abuso e a pratiche non etiche come la menzogna).
Spero che in futuro, più che al placebo inteso come farmaco inerte o pillola di zucchero, si faccia uso di questo effetto come a un qualcosa di realmente utilizzabile in ambito clinico e legato molto alla relazione medico-paziente, in cui si presta attenzione alle esperienze precedenti della persona e alle sue aspettative. Questo richiede un cambiamento nel modo in cui si instaura l’alleanza terapeutica tra medico e paziente, ed esige ovviamente una consapevolezza da ambo le parti.
Esiste infine nella comunità medica un certo scetticismo su questa risposta?
Credo di sì, per due ragioni. Noi ricercatori pubblichiamo gli studi sulle riviste scientifiche, ma sono i giornalisti che hanno il ruolo di informare la comunità medica e soprattutto la società. Per questo motivo sono sempre contenta di parlare dei nostri risultati scientifici. Pubblicare solo su riviste non è sufficiente. C’è anche la necessità di agire a livello di politiche, per sapere quali sono le norme che i medici dovrebbero rispettare nell’utilizzo dei placebo e dei suoi effetti. E, ripeto, istruire le generazioni future di medici e paramedici su questo fenomeno, facendo capire che non si sta parlando semplicemente di errori o fenomeni psicologici. È invece un fenomeno di autoguarigione innato del nostro corpo.