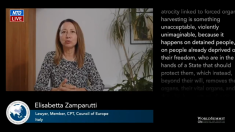Muhammad Alì è morto. The Greatest, come aveva deciso di farsi chiamare quando ancora nessuno, tranne lui, sapeva che sarebbe stato il più grande pugile della storia della boxe, se n’è andato nello stesso silenzio con cui aveva combattuto, per oltre trent’anni, il morbo di Parkinson.
Chi gli era vicino sosteneva si trattasse non di morbo ma di ‘sindrome’ di Parkinson: una serie di danni cerebrali irreversibili dovuti ai troppi traumi subiti nella sua lunga carriera.
Forse. Quello che è certo è che di colpi, prima il giovane Cassius Clay e poi Muhammad Alì (che erano la stessa persona solo fino a un certo punto), ne avevano presi davvero tanti: Sonny Liston, Floyd Patterson, Joe Frazier, George Foreman sono alcuni fra i più grandi, e devastanti, campioni della storia del pugilato (nomi che – a chi piace la boxe – fanno accapponare la pelle ancora oggi). E Clay/Alì li aveva battuti tutti: tutti ko, tranne il grande Smoking Joe Frazier, che a Manila nel 1975, perse contro Alì solo ai punti, dopo 15 round, nell’incontro più drammatico e più ‘bello’ di sempre.
«MI HANNO RUBATO LA BICICLETTA! LI VADO A CERCARE E LI PICCHIO!»
Cassius Marcellus Clay era nato a Louisville, nel Kentucky, il 17 gennaio 1942. La sua storia è molto diversa dal cliché del pugile che ‘viene dalla strada’ (e spesso dal riformatorio, come ‘Iron’ Mike Tyson: l’ultimo grande campione della boxe). Cassius era un bravo e rispettoso bambino di una (fortunata) famiglia di colore della classe media del sud degli Stati Uniti: non perdeva tempo in giro, andava a scuola.
E la storia del Campione infatti inizia ai tempi della scuola: un giorno di ottobre del 1954, qualcuno ruba al piccolo Cassius la sua nuova bicicletta; mentre cammina furioso in cerca della bici (e soprattutto del ladro), incrocia tale Joe Martin – gestore di una scuola di boxe amatoriale – che gli chiede che gli è successo; Cassius risponde: «Mi hanno rubato la bicicletta: vado a cercarli e li picchio!». Martin gli risponde sorridendo: «Ok, ma prima devi imparare a picchiare. Sei capace?». Cassius non è un teppista e non è capace. Ma ci penserà Joe a insegnargli.
Un inizio di carriera emblematico: il più grande pugile di sempre, ha imparato a combattere non per sfogare la sua rabbia in ‘modo legale’ ed evitare la galera (o peggio), ma per ‘ottenere giustizia’.
La bicicletta non verrà mai ritrovata e tantomeno i ladri; ma dopo soli sei anni, nel 1960, il diciottenne Cassius Clay vincerà la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Roma.
VOLA COME UNA FARFALLA E PUNGI COME UN’APE – STORIA DI UN PUGILE PUROSANGUE
Cassius Clay vince la prima delle sue tre cinture WBA (una volta esisteva una sola ‘categoria’: un solo campione del mondo dei pesi massimi) il 25 febbraio del 1964 battendo Sonny Liston, il campione del mondo in carica unanimemente considerato invincibile.
Ma Liston è tutt’altro che invincibile: impotente sotto la grandine di diretti e ganci del giovane sfidante che non riesce nemmeno a toccare, nonostante debba essere più esperto e in teoria più veloce di lui (Clay era alto 1,91, Liston 1,85) il campione del mondo in carica si ritira alla sesta ripresa. E ‘Louisville Slugger’ Cassius Clay – un ragazzino su cui nessuno puntava letteralmente nulla – diventa il campione del mondo dei pesi massimi di pugilato.
Sul piano strettamente tecnico, Muhammad Alì è stato un eccellente pugile, che riassumeva tutte le qualità del campione nato: forte, veloce, resistente e intelligente. E probabilmente è vero che il più bravo in assoluto sia stato ‘Sugar’ Ray Robinson, il peso medio cui Clay si era ispirato all’inizio della sua carriera.
Ma Alì è stato indiscutibilmente il più grande: ha battuto a inizio carriera – quando era così veloce che gli avversari riuscivano giusto a sfiorarlo e nemmeno vedevano i suoi pugni – tutti i migliori.
E ha ribaltato tecnica e strategia di combattimento quando, trentaduenne, ha dovuto riprendersi il titolo che l’esercito degli Stati Uniti gli aveva ‘tolto’ dopo averlo accusato di diserzione. Nel match del 1974 a Kinshasa, nello Zaire, il ‘vecchio’ Alì prende pugni dal colossale George Foreman per otto round: otto riprese in cui il giovane Foreman picchia senza sosta ‘massacrando’ Alì, che incassa e resiste in modo incredibile; fino a quando George abbassa la guardia: quattro pugni e Foreman crolla come un grattacielo colpito dal terremoto: è ko.
Rumble in the Jungle (così avevano soprannominato il primo incontro di boxe mai trasmesso in mondovisione) non è solo l’incontro della riconquista del titolo mondiale e della consacrazione di Alì a mito del pugilato. È la rivincita di un ‘nigger’ che aveva combattuto e battuto la discriminazione razziale a modo suo: «Nessun Vietcong mi ha mai chiamato negro» aveva dichiarato come spiegazione della sua obiezione di coscienza. Un’obiezione di coscienza che aveva pagato cara.
IL CAMPIONE
La storia di Muhammad Alì è nota: biografie, film e documentari l’hanno raccontata da tutte le angolazioni possibili. La sua teatralità unica, la fede nell’Islam e la grande amicizia con Malcolm X, emblematiche di una ricerca non tanto di riscatto sociale quanto di ‘Giustizia’ per i neri d’America; il rifiuto di arruolarsi nell’esercito americano perché, lui, non aveva «nessun problema con i Vietcong», e il rifiuto di ‘vendersi’ in un compromesso di comodo (ovviamente, non sarebbe mai finito a combattere nella foresta: gli avrebbero dato un incarico formale e avrebbe potuto continuare a combattere per i tre anni della ferma); poi il linciaggio pubblico, il processo per diserzione, il ritiro della licenza di combattimento, la perdita del titolo e il disastro finanziario. Fino al ritorno epico: la riconquista del titolo, contro Foreman a Kinshasa, la sconfitta e la seconda riconquista contro il giovane Leon Spinks nel 1978, il declino e il ritiro; e poi il terzo ritorno – già malato – e la mancata terza riconquista del titolo nel 1980, contro Larry Holmes, quando il Campione getta la spugna.
Già il giovane Cassius Clay, con obiettiva percezione della propria predestinazione, dopo i primi incontri aveva iniziato a definirsi ‘GOAT’ (Greatest of all Times), il più Grande di tutti i tempi.
Gli americani, invece, lo hanno sempre chiamato ‘Campione’: un soprannome semplice, sobrio ed essenziale; e strano, sia per gli eccessi espressivi di cui era protagonista Alì, che per la cultura – anch’essa eccessiva – tipica degli americani.
Prima che essere (o apparire) ‘campioni nello sport come nella vita’ diventasse un luogo comune del marketing sportivo, Muhammad Alì era diventato campione – sul serio – dentro e fuori dal ring. E, soprattutto, campione era rimasto anche nella vita – grazie al suo talento naturale unico, all’enorme impegno e alla straordinaria capacità di sacrificio. Tutte qualità alla cui base non può che esserci una costante forza morale. E infatti, nonostante fama e ricchezza – questo è doveroso sottolinearlo, oggi più che mai – droghe, alcol e depravazioni varie, sono sempre stati vizi a lui del tutto estranei.
Ora, il Campione se n’è andato. Ma il suo esempio rimane.