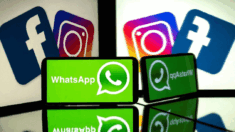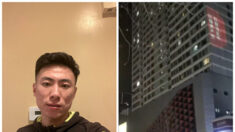Con una mossa che potrebbe aiutare a fare luce sulle violazioni dei diritti umani in Cina, a inizio luglio la dogana statunitense ha sequestrato 13 tonnellate di prodotti a base di capelli umani, mentre il 20 luglio il Dipartimento del Commercio ha multato un’azienda cinese di accessori per capelli.

I superstiti, gli investigatori e gli attivisti uiguri sostengono che i capelli sequestrati provengano dalle donne rinchiuse nei campi di concentramento e di lavoro sparsi in tutto lo Xinjiang – la regione più occidentale e mussulmana della Cina – e che per la prima volta le autorità statunitensi abbiano tra le mani un’importante e concreta prova su cui basare ulteriori indagini sulla persecuzioni delle minoranze mussulmane in Cina.
Il giornalista investigativo Ethan Gutmann, che ha incontrato in Turchia e Kazakistan molti sopravvissuti ai campi di prigionia cinesi, commenta: «La mia stima molto approssimativa è che il carico [sequestrato, ndt] contenga i capelli di circa 90 mila donne incarcerate nei ‘campi di rieducazione’. Sebbene questo tipo di capelli lunghi ed esotici, castani con riflessi rossastri, siano di solito contrassegnati nei cataloghi cinesi con la dicitura ‘mongolian’, i capelli sono in realtà stati tagliati dalle teste di donne uigure, kazake, kirghise e hui».
Ad ogni modo, il governo statunitense ha già intrapreso una serie di azioni per contrastare le repressioni nello Xinjiang.
Il 20 luglio il Dipartimento del Commercio ha aggiunto 11 aziende cinesi coinvolte in abusi nello Xinjiang, tra cui la Hetian Haolin Hair Accessories, alla sua cosiddetta ‘entity list’. Questo elenco è uno strumento per limitare l’esportazione, la riesportazione e il trasferimento di prodotti da parte di persone o aziende coinvolte in attività che minacciano la sicurezza nazionale o gli interessi politici esteri degli Stati Uniti.
Mentre il 31 luglio, l’ufficio del Dipartimento del Tesoro delegato al controllo dei beni esteri (Ofac) ha sanzionato un ente governativo cinese e due funzionari per la loro implicazione in violazioni dei diritti umani come la detenzione arbitraria di massa e i gravi maltrattamenti fisici.
Dentro i campi di concentramento
Gulbakhar Jalilova, cittadina kazaka sopravvissuta ai campi di concentramento cinesi, era una commerciante; si recava spesso quindi a Urumchi, la capitale della regione autonoma dello Xinjiang, per acquistare vestiti. Nel 2017 è stata arrestata mentre si trovava nel suo hotel, con l’accusa di «favoreggiamento di attività terroristiche».

La Jalilova, madre di quattro bambini, è stata quindi rinchiusa in una cella di 6 metri quadrati per 465 giorni, insieme a molte altre donne, a cui ogni giorno venivano somministrati dei farmaci non meglio precisati.
Una delle prime cose che le autorità del campo facevano quando le donne arrivavano nella struttura era proprio tagliare loro i capelli, un’operazione che poi veniva ripetuta regolarmente sulle donne che rimanevano nel campo per lunghi periodi.
Recentemente l’edizione americana di Epoch Times ha parlato telefonicamente con la Jalilova, che nell’ottobre del 2019 aveva già incontrato a Istanbul il giornalista investigativo Ethan Gutmann. La donna ha raccontato a Gutmann che le detenute venivano disposte davanti a un muro bucato, ammanettate, mentre una persona il cui volto non poteva essere visto tagliava loro i capelli rimanendo dall’altra parte del muro.
Gutmann ha raccolto molte testimonianze dalle donne superstiti, comprese le esperienze che hanno vissuto quando sono arrivate nel campo per la prima volta: «Era praticamente universale. Entrando nel campo, le donne venivano costrette a mettersi in fila davanti a un muro bucato. Quando era il proprio turno, venivano costrette ad appoggiare la testa contro il buco mentre delle mani senza volto tagliavano loro i capelli con una forbice; citando le parole di una delle donna: come fossero animali».
E a rendere questo atto ancora più violento, c’è il fatto che nella cultura tradizionale uigura i capelli lunghi sono considerati molto importanti per le donne.
La storia della Jalilova è stata confermata anche da un’altra sopravvissuta ai campi di concentramento, la trentenne Mihrigul Tursun, che ha testimoniato davanti al Congresso degli Usa nel novembre del 2018. La ragazza è stata incarcerata in tre distinte occasioni, la prima volta in una prigione mentre le altre due in un campo di concentramento, per un totale di 11 mesi distribuiti in un periodo di oltre 2 anni (2015-2017). Recentemente la ragazza ha raccontato a Epoch Times che tre giorni dopo il suo primo ingresso in prigione, i capelli di tutte e cinquanta le detenute che erano nella sua cella sono stati tagliati, e che quasi tutte avevano delle lunghe trecce.
La Tursun aveva capelli lunghi fino alla vita quando è entrata in prigione: «Eravamo tutte depresse, sconvolte emotivamente. Si sentivano impotenti e senza speranza. Si sentivano disonorate. Anche se non faceva male fisicamente, faceva male mentalmente, emotivamente e spiritualmente».
La Tursun ha ancora ricordi felici di sua madre che le intrecciava i suoi lunghi capelli fino all’età di 15 anni. Ricorda con tenerezza i molti concorsi di capigliatura che si svolgevano nella sua scuola. Spiega che le donne uigure intrecciano i capelli in ben 15 modi differenti e utilizzano molti accessori per capelli.
Secondo Elfidar Hanim, il segretario dell’Associazione americana degli uiguri, l’importanza attribuita alla cura dei capelli è tornata utile alle autorità cinesi, che ora usano i capelli delle detenute uigure per fare soldi.
Il lotto da 13 tonnellate prodotto dalla Lop County Meixin Hair Product, che la dogana statunitense ha sequestrato il 1° luglio, ha infatti un valore commerciale di circa 800 mila dollari. Per Hanim questo business va avanti da anni: «La Cina fa questo commercio da diverso tempo, ma questi prodotti per capelli non sono mai stati sequestrati. Questa volta è successo perché c’è più consapevolezza sulla questione e anche perché Radio Free Asia ne ha parlato recentemente».
Hanim si riferisce a un’inchiesta pubblicata il 28 maggio e realizzata dal reporter Gulchehra Hoja intitolata ‘Hair Product Industry Linked to Uyghur Forced Labor Booming in Xinjiang’s Lop County’ (L’industria dei prodotti per capelli è legata al boom del lavoro forzato uiguro nella contea di Lop dello Xinjiang). E in effetti Radio Free Asia ha confermato a Epoch Times via e-mail che la propria inchiesta ha aiutato la dogana statunitense a effettuare il sequestro della spedizione in questione.
La punta dell’iceberg
Ma Gutmann e Hanim ritengono entrambi che i prodotti a base di capelli siano la prova di un solo aspetto della più ampia gamma di gravi violazioni dei diritti umani in corso in Cina.
Scrive infatti Gutmann: «Eppure questa è semplicemente la punta dell’iceberg. Andate più a fondo e troverete le prove del lavoro forzato, della schiavitù sessuale e della sterilizzazione forzata. Moltissime vite – secondo le mie stime oltre 10 mila donne ogni anno, come minimo – vengono soppresse a causa del prelievo forzato di organi. Quando le donne occidentali usano prodotti di bellezza cinesi contenenti collagene, si stanno inavvertitamente spalmando in faccia i resti di queste persone».
Anche Hanim ha dichiarato che gli uiguri all’interno di questi campi di concentramento sono sottoposti al prelievo forzato e illegale di organi, alla sterilizzazione forzata e che i detenuti vengono usati come cavie per i test medici. «Ma non è tutto, ora usano gli uiguri pezzo per pezzo per farci soldi, commercializzando tutto quello che possono», ha detto Hanim, che paragona queste storie a quelle dei campi di concentramento nazisti.
Le ex detenute Tursun e Jalilova hanno invece citato anche il fatto che tutte le detenute venivano sottoposte a esami del sangue e test di gravidanza. Le donne incinte venivano costrette ad abortire. Inoltre, hanno raccontato che ogni giorno venivano somministrate loro alcune medicine non identificate, che tra l’altro fermavano le mestruazioni nelle giovani donne. Secondo la Jalilova, i farmaci venivano loro somministrati per tenerle tranquille: non sentivano più né il dolore né la fame.

In uno studio pubblicato il 28 luglio, lo Uyghur Human Rights Project (UHRP) ha affermato che il regime cinese ha compiuto uno «sforzo incessante» per coprire i suoi crimini contro la popolazione musulmana dello Xinjiang. Dopo essere stato incalzato in occasione della valutazione dell’agosto 2018 del Comitato Onu per l’eliminazione della discriminazione razziale, il regime ha cercato di giustificare l’esistenza dei campi di concentramento come un tentativo di educare gli «estremisti» o qualificandoli come «centri di formazione professionale».
«Più tardi, il governo, mentre lanciava un vasto programma di lavori forzati in fabbrica ed emetteva lunghe condanne detentive senza processo, ha sostenuto che i detenuti si erano ‘laureati’», ha dichiarato l’Uhrp in un comunicato.
Test del Dna
Gutmann e Hanim hanno dichiarato che il lotto di capelli umani proveniente dallo Xinjiang e sequestrato dalla dogana statunitense dà agli Stati Uniti l’opportunità di condurre ulteriori indagini, dal momento che ora hanno un prova concreta tra le mani.

«Pare che la Dogana statunitense effettuerà il test del Dna, probabilmente per verificare che i capelli provengano da persone di etnia uigura o kazaka, piuttosto che da cinesi di etnia Han – afferma Gutmann – Ma questo non basta. Pechino ci ha dato involontariamente la prova fisica di un crimine».
Hanim ha detto che si tratta di una prova difficile da verificare; è facile effettuare il test del Dna quando la radice del capello è intatta, mentre questi prodotti a base di capelli non hanno la radice. In ogni caso, secondo Hanim, la dogana statunitense non dovrebbe restituire questa spedizione ai cinesi: «Vorremmo che distruggessero i capelli o li tenessero, invece di restituirli alla Cina, perché loro li rivenderebbero ad altri Paesi, li rivenderebbero ai Paesi poveri. Inoltre, la Cina troverà il modo di ricommercializzarli, in futuro potrebbero dar loro un nome diverso e potrebbero trasferirli in diverse regioni o addirittura etichettarli come capelli indiani».
Infine, secondo Hanim gli Stati Uniti dovrebbero sollecitare gli altri Paesi occidentali a non comprare prodotti legati al lavoro forzato o ai campi di concentramento dello Xinjiang.
Articolo in inglese: Seized Human Hair Products From Xinjiang Provide Evidence of Persecution